![]()
autori
vari
Gli albori
della vita italiana
Questo
e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di:
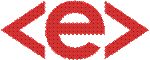
QUESTO E-BOOK:
TITOLO: Gli
albori della vita italiana conferenze tenute a Firenze nel 1890.
AUTORI: Guerrini,
Olindo; Villari, Pasquale; Molmenti, Pompeo; Bonfadini, Romualdo; Bonghi,
Ruggero; Graf, Arturo; Tocco, Felice; Rajna, Pio; Bartoli, Adolfo; Schuffer,
Francesco; Barzellotti, Giacomo; Panzacchi, Enrico; Masi, Ernesto
TRADUTTORE:
CURATORE:
NOTE: Il testo è presente in formato immagine sul sito The Internet
Archive (http://www.archive.org/). Realizzato in collaborazione con il Project Gutenberg
(http://www.gutenberg.org/) tramite Distributed Proofreader (http://www.pgdp.net/).
Contiene:
Olindo GUERRINI Preludio
Pasquale VILLARI Le
origini del comune di Firenze
Pompeo MOLMENTI Venezia e le
repubbliche marinare
Romualdo BONFADINI Le
origini del comune di Milano
Romualdo BONFADINI Le
origini della monarchia in Piemonte
Ruggero BONGHI Le
origini della monarchia a Napoli
Arturo GRAF Le
origini del papato e del comune di Roma
Felice TOCCO Gli
ordini religiosi e l'eresia
Pio RAJNA Le
origini della lingua italiana
Adolfo BARTOLI Le
origini della letteratura italiana
Francesco SCHUPFER Le
università e il diritto
Giacomo BARZELLOTTI La
filosofia e la scienza nel periodo delle origini
Enrico PANZACCHI Le
origini dell'arte nuova
Ernesto MASI Epilogo
Informazioni
sul "progetto Manuzio"
Il
"progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber
Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la
pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato
elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet:
Aiuta anche tu
il "progetto Manuzio"
Se questo
"libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le
finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber.
Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca.
Qui le istruzioni:
http://www.liberliber.it/aiuta/
GLI ALBORI
DELLA
VITA ITALIANA
Conferenze tenute a Firenze nel
1890
DA
O. Guerrini, P. Villari, P. Molmenti, R. Bonfadini,
R. Bonghi, A. Graf, F. Tocco, P. Rajna, A. Bartoli,
F. Schupfer, G. Barzellotti, E. Panzacchi, E. Masi.
QUARTA EDIZIONE.
MILANO
FRATELLI TREVES, EDITORI
1897.
PROPRIETÀ LETTERARIA
Riservati tutti i diritti.
Tip. Fratelli Treves.
LE CONFERENZE DI FIRENZE SU
GLI ALBORI DELLA VITA ITALIANA[1]
«Raccogliere
ascoltatrici e ascoltatori devoti, quanti amano genialità di studi, vigoria di
pensieri, pittrice eleganza nel dire, e invitare gl'ingegni più colti, perchè
ognun di essi nelle spirituali adunanze, colorisca, secondo un ordine
determinato, una parte del gran quadro della Vita Italiana nei varii secoli; parve assunto degno di quelle
tradizioni di gentilezza onde Firenze si onora, e occasione bene augurata per
procurare che i più valenti, mossi da un solo pensiero, illustrino le pagine
gloriose della storia nostra civile. Firenze negli Orti neoplatonici, ai rezzi
delle ville suburbane, nelle botteghe degli speziali, e poi nelle accademie e
nei dotti ritrovi, ebbe in altri tempi il primato delle letterarie adunanze.
Noi vorremmo che ora potesse modestamente dar l'esempio di eletti convegni, in
cui l'ascoltare fosse studio e ricreazione dell'animo.»
Così diceva un
manifesto che portava in calce alfalbeticamente disposti, i nomi di Guido
Biagi, G. O. Corazzini, Tommaso Corsini, Francesco Gioli, Diego Martelli, Carlo
Placci, Arnaldo Pozzolini, Piero Strozzi, Pasquale Villari, e che, distribuito
ne' salotti fiorentini e forestieri e commentato in varie lingue dalla viva
eloquenza di apostoli convinti, ebbe la fortuna d'essere accolto con ogni
favore. L'idea d'una serie di letture sopra un determinato argomento parve
utile e buona: avrebbero almeno servito all'intento di farci conoscer meglio
una parte della nostra vita passata e ricondotto a Firenze uomini di chiara
fama, la cui voce da un pezzo non avea risuonato fra noi.
Il manifesto
piacque a quanti lo lessero. Scritto con uno stile leggermente précieux, parea fatto apposta per
accarezzare gli orecchi più delicati, per esser ritenuto a memoria, come una
musica di parole armoniose e soavi. Era destinato segnatamente alle signore,
senza le quali, - come disse un amico dell'amico più grande che esse abbiano
avuto, di Messer Giovanni di Boccaccio, non si può far cosa che abbia profumo
di gentilezza. E le signore che rimandarono le schede di associazione con le
loro firme in lettere inglesi, magre e sottili, aveano subito compreso d'essere
invitate a metter su qualche cosa che avrebbe voluto esser durevole e degna.
Frattanto,
mentre d'ogni parte si chiedevan notizie di queste letture e della Società che
le aveva promosse, venne innanzi l'inverno. L'argomento della prima serie era
già scelto: Gli albori della Vita
Italiana: e, distribuite le parti, già cominciavano i giornali ad
annunziare questo che sarebbe stato l'avvenimento letterario dell'anno,
storpiando maledettamente quel povero titolo che, di proto in proto, si mutava
ora in allori e ora in alberi.
Restava da
sceglier la sala per le conferenze: e la scelta avea grande importanza perchè
da essa dipendeva il carattere e l'intonazione delle letture. Il luogo alle
volte determina il buon esito d'un'impresa: lo Stabat in teatro non sarebbe lo Stabat,
e la musica del Barbiere, non
potrebbe esser sonata sull'organo di chiesa. Così queste letture non dovevano
diventare lezioni cattedratiche e nemmeno conferenze popolari. Una sala
pubblica, l'Aula Magna, quella del Buonumore, la Filarmonica, la Sala di Luca Giordano, per un'infinità di ragioni,
oltre a quelle accennate, non parevano adatte. Non ci voleva una sala a
pigione; ma si desiderava l'ospitalità signorile di qualche antico palazzo. Il
sogno era una bella sala con arazzi alle pareti, con un di quei larghi camini
del quattrocento che invitavano i nostri antichi all'intimità del focolare, con
le lumiere di nitido cristallo penzolanti da un soffitto a cassettoni, con il
profumo dei fiori accomodati nelle paniere e nei vasi, con il tepore....
moderno d'un calorifero invisibile. E il sogno si avverò grazie ad un
gentiluomo artista, sempre primo dove si tratti di tentare cosa utile e buona,
e la cui benevola cortesia è a prova di fuoco come la porcellana della
splendida Manifattura di Doccia. Il marchese Carlo Ginori, deputato al
Parlamento, R. Commissario per le antichità e belle arti della Toscana,
proprietario d'una fabbrica meravigliosa, cacciatore, schermidore e navigatore
appassionato, affittuario dell'isola di Montecristo e, dopo tutto, bello e
compito cavaliere, - concesse alla società la sala del suo palazzo, e le Letture fiorentine si chiamarono «le
conferenze di Casa Ginori».
La scelta della
sala e la pubblicazione del programma per la prima serie di letture che
cominciarono il 1.^o marzo 1890 per cessare il 19 aprile, crebbero la curiosità
universale. Se ne parlava dappertutto, nei crocchi degli sfaccendati, come ai domino serali dei professori
dell'Istituto Superiore, ai five o'clock
tea delle più fashionables forestiere,
come ai pranzi spirituali delle duchesse. Gli scolari chiedevano alla capitale
o in provincia una tessera di giornalista per esservi ammessi; i giornalisti
soli si dolevano di non poter essere, almeno una seconda volta, scolari.
Il primo marzo
alle 3 pomeridiane precise, Olindo Guerrini saliva trepidando sulla cattedra
improvvisata nella sala Ginori e sedutosi per leggere il suo Preludio, onde iniziavasi la serie delle
Letture, si guardò intorno con occhi spauriti. Gli s'affollava da presso e lo
stringea d'ogni parte una folla di ascoltatrici e d'ascoltatori curiosi, un
pubblico da dar soggezione ai più esperti e da far subito desiderare a
qualunque oratore di poter lì per li scomparire. Davvero meriterebbe uno studio
particolare l'uditorio di quella sala, composto com'era di quanto ha Firenze di
più culto ed eletto. Abbozzare qualche ritratto sarebbe indiscretezza; dirò
soltanto che c'eran signore d'ogni età, d'ogni classe, d'ogni nazione,
giovinette studiose che non perdevano una sillaba di quanto sentivano,
gentildonne rinomate per genialità di studi e per eleganza di non studiati
pensieri, donne ammirate per opere d'ingegno e per amore alle arti, volti
sbiancati dagli anni ma cari e venerandi, volti rosei e sorridenti nella
primavera della vita e ne' trionfi mondani, volti eburnei di fanciulle dallo
spirito arguto, chiome nere con qualche filo d'argento, chiome sfidanti l'ala
del corvo, o rutilanti come l'oro liquefatto o bionde come le spighe mature;
occhi stellanti fatali ai poeti, e poeti co' baffi appuntati, e senatori
veleggianti nel mare dei sogni entro le punte d'un solino, e giovinotti
azzimati col fiore all'occhiello, e scolari, e artisti, e ufficiali, e barbe e
occhiali di professori....
Le conferenze
ebbero sempre questi giudici che non disertarono il campo. Conosco signore che
si fecero scrupolo di mancare una sola volta; altre che vennero da lontano per
assistervi; altre e moltissime che rimasero col desiderio, e scrivevan lettere
alle amiche per aver compiuti ragguagli. Ma dei singoli oratori non parlo:
l'opera che tutti insieme questi valenti ingegni hanno compiuto è una splendida
pagina della nostra storia, da essi rimessa in luce. Gli Albori che si distinguevano a mala pena di mezzo alle oscurità
delle origini, son ora rischiarati dalle indagini e dalla dottrina d'uomini per
i quali il sapere è professione; ed ora il bel volume edito dai Treves
appagherà il desiderio di quanti non poteron ascoltare questi artisti della
parola.
Io non farò che
enumerarli. Al Guerrini, nel cui volto tutti cercavano i lineamenti ideali di
Lorenzo Stecchetti, successe l'onorevole Romualdo Bonfadini che svolse la prima
parte del tema Le Origini dei Comuni
Italiani. Parlar di Milano fu per
lui facile assunto, e più facile ancora incatenare gli uditori con parola
fluida ed ornata. Alto della persona, con una voce baritonale, col gesto largo
e l'aspetto d'un padre nobile, riaffermò la riputazione ormai assodata di
parlatore valente. Venezia e le
repubbliche marinare era la seconda parte del tema sulle Origini dei Comuni e toccò a Pompeo
Gherardo Molmenti, che la trattò con finezza d'artista e con quella signorile
eleganza ch'egli sa mettere in ogni cosa. La terza parte: Firenze, fu il trionfo del Villari che, come pensatore profondo, come
oratore appassionato ed efficace, ebbe un de' maggiori successi di che possa
andar lieto. Salito sulla cattedra, riuscì subito ad affascinare il pubblico
con la vivezza del dire improvviso e la chiarezza del ragionamento. Il Villari
non è un dicitore studiato: la sua eloquenza è tutta cose, e prorompe dalla
profondità del sentimento, dalla convinzione della verità di quanto afferma. Lo
chiamerei un oratore all'inglese, perchè appunto sdegna i piccoli artifizi
della rettorica e, come il suo grande maestro De Sanctis, fa consistere tutta
l'arte nella sincerità e nell'onestà del pensiero.
Le Origini del comune di Firenze, che
posson credersi un soggetto arido e freddo, appena tollerabile per un erudito,
furono per lui tema di splendide considerazioni storiche, dalle quali assurse a
concetti nobilissimi sulla società umana e sulla moralità sociale. Gli uditori
scaldati a quell'onda di vivide e calde parole, salutaron con applausi
entusiastici l'illustre autore del Savonarola,
del Machiavelli e delle Lettere Meridionali che avea trovato in
quell'ora, dinanzi a così eletta adunanza, le note più squillanti e più umane
della sua eloquenza d'artista.
Alle Origini
dei Comuni successero le Origini della
Monarchia in Piemonte ed a Napoli. Dovea parlare del Piemonte Giuseppe Giacosa; ma,
impeditone da malattia, fu sostituito egregiamente dal Bonfadini che ebbe
un'altra volta liete e cordiali accoglienze. Di Napoli lesse più tardi, quando fu rimesso in salute, Ruggiero
Bonghi che svolse il tema al solito con molta e soda dottrina.
Le origini del Papato e del Comune di Roma dettero modo
ad Arturo Graf, al poeta di Medusa,
all'autore del Diavolo, professore
nell'Università di Torino, di mostrare com'egli sappia accoppiare una
straordinaria cognizione dei fatti con una non comune facilità d'esposizione.
Pio Rajna, la cui dottrina di filologo è pari soltanto alla nobile rigidità del
carattere, parlò delle Origini della
lingua Italiana con autorità di scienziato e con garbo di artista, rendendo
accessibili le più difficili ed intricate questioni. A Francesco Schupfer le Università Italiane ed il Diritto dettero
agio di esporre molte nuove e sapienti vedute intorno al grave e importante
argomento. Il professor Felice Tocco, parlando da maestro degli Ordini religiosi e dell'eresia, confermò
la sua fama di pensatore originale e profondo e di geniale espositore.
Le due letture
che seguirono, quella del professore Adolfo Bartoli sulle Origini della Letteratura Italiana e quella di Enrico
Panzacchi, furono, con l'altra del Villari, giudicate bellissime fra le più
belle di questa serie. Il Bartoli lesse, con limpida dizione, alcune splendide
pagine che compendiano mirabilmente quant'egli ha scritto in molti e pensati
volumi. Il Panzacchi con una calda improvvisazione trattò delle Origini dell'arte nuova, e il poeta
bolognese non fu mai come quel giorno ispirato ed eloquente. Quando ebbe finito
gli fu fatta una vera ovazione, e le signore lo circondarono come volessero
rapirlo.
Una bella
lettura del prof. Giacomo Barzellotti sulla Filosofia
e le scienze nel periodo delle origini, in cui con forma chiara ed
artistica si spiegano i più astrusi problemi onde le menti umane erano allora
affaticate, e un meraviglioso Epilogo
di tutte le dodici letture, nel quale Ernesto Masi dimostrò d'essere ad un
tempo pensatore profondo e dicitore elegante, chiusero la Prima serie dedicata
agli Albori, il 19 di aprile.
Quel giorno un
cartoncino stampato con tutti i lenocinii dell'arte e distribuito alle
ascoltatrici e agli uditori plaudenti, annunziava per l'anno venturo una nuova
serie di letture sulla Vita Italiana nei
secoli XIII e XIV. Il roseo manifesto porta anche la firma del marchese
Carlo Ginori chiamato, per le sue benemerenze, a far parte della Società promotrice di pubbliche letture.
Così andò, e -
lasciatemelo dire - andò proprio bene!
Guido Biagi.
PRELUDIO
DI
OLINDO GUERRINI
Quando, egregie
signore e signori, quando l'autore ha compiuto l'opera, allora comincia a
pensare alla prefazione. Così il signore Iddio, dopo aver creato dal nulla l'Universo,
pensò alla prefazione - all'uomo - e lo creò ultimo, a propria imagine e
somiglianza. Ma il pubblico, che non è iniziato ai misteri della tecnica
d'arte, e ignora, per fortuna sua, con quali artifizi si costruiscono un libro
o un dramma musicale, crede ingenuamente che l'opera sia stata pensata ed
eseguita in quella stessa successione di tempi e di idee in cui la trova
disposta. Crede cioè che l'autore abbia cominciato dal principio e finito colla
fine; e che la prefazione o il preludio, che stanno sul limitare del libro o
del dramma, sieno stati i primi, in ordine cronologico, ad esser composti.
E il buon
pubblico erra. Che se, del resto, ragionasse soltanto per analogia, si
convincerebbe subito che una gran parte delle faccende di questo mondo, contro
ogni canone apparente di logica, non cominciano dal principio. Sembra un
paradosso, ma è un fatto di tutti i giorni. Quante spese, per esempio, fatte
prima d'avere i denari! Tutta la teoria del credito è fondata appunto su questa
facoltà particolare dell'uomo di poter cominciare dalla fine. Quanti dottori
esercitano la professione prima d'averla studiata; quanti sonetti si cominciano
a scrivere dall'ultimo verso, quanti romanzi si cominciano a leggere
dall'ultimo capitolo. Quante affermazioni prima della certezza, quanti
giuramenti prima della convinzione, quante nozze prima dell'amore! L'uomo è un
essere perfettamente illogico; il che lo distingue dai bruti.
Nel caso nostro
poi è legge di natura, fatale come quella della gravità, che la prefazione debba
esser fatta dopo il resto. Nella prefazione l'autore riassume il contenuto
dell'opera, indica l'ordine, espone il metodo seguito e passa in rassegna le
opinioni de' suoi colleghi sullo stesso argomento. Dimostra a luce meridiana,
ciò s'intende, che tutti i colleghi e predecessori ebbero sempre torto marcio;
pone delicatamente in dubbio lo stato delle loro facoltà mentali, la loro
fedina criminale e il loro stato di famiglia, e dopo di averli spesso
gratificati di molti ma non nobili titoli, passa a dimostrare la propria
superiorità, la virtù propria, il proprio genio. Ora tutte queste operazioni
espositive non possono esser condotte a bene che ad opera compiuta, quando
l'autore ha finalmente un'idea chiara di quel che voleva fare e di quel che gli
è riuscito di fare. Se la ciambella gli riuscì col buco egli la trasforma in
altare e vi erige sopra un tempio nella prefazione, dove offre a sè medesimo la
mirra e l'incenso, e fa la ruota in faccia agli ammiratori e tempera le saette
per gli eterodossi. Se la ciambella poi, non che col buco, riuscì senza la
minima traccia di soluzione di continuità, allora l'autore, come potete
credere, fa precisamente lo stesso, si erige l'altare, si fabbrica il tempio e
gratifica sè stesso dei più puri e più grati incensi della rettorica. Poichè,
dal giorno in cui fu trovata questa meravigliosa e matta arte dello scrivere,
non fu mai scrittore persuaso di aver fatto un brutto libro. Che se mai ne
nascesse un solo, in verità vi dico, che in quel giorno il sole si oscurerà perchè
sarà prossimo il giudizio universale.
Ad ogni modo,
per tornare in carreggiata, qualunque sia il genere o la fortuna dell'opera,
resta fissata questa legge che la prefazione si fa per l'ultima.
E se non
bastassero le prove addotte, basterebbe pensare un poco al preludio di un
dramma musicale. Ivi il maestro espone o riassume i motivi principali
dell'opera, quasi li racconta ad uno ad uno al pubblico, il quale per lo più
non è loro avaro di applausi d'incoraggiamento in principio, quanto è prodigo
poi di energici fischi di scoraggiamento alla fine. Ma se l'infelice maestro
non avesse già finita l'opera, come potrebbe accennarne i motivi principali nel
preludio? È dunque provato che l'esordio si fa dopo la conclusione: il che era
da dimostrare.
Da quel che ho
detto fin qui, risulta anche provata un'altra affermazione non meno inutile,
che cioè la prefazione è una instituzione antichissima.
È chiaro
infatti che, le leggi naturali non avendo mai subito alcun mutamento, gli
autori della più remota ed incredibile antichità debbano aver avuto le stesse
passioni e sofferti gli stessi bisogni che questi moderni. Intendo rispetto
alle relazioni col pubblico, e non al contenuto delle opere. Non so se come
tutte le invenzioni anche questa ci venga dalla China. Certo se lo merita. Ma
ad ogni modo quel remotissimo figlio del Cielo che primo commise una
prefazione, fu tratto dal desiderio di parlare di sè, della sua opera e di
propiziarsi il lettore, riuscendo come sempre all'effetto contrario, perchè è
vero quel che dice il Pascal che l'io è
odioso.
Il costume
latino, anzi più precisamente italiano, vorrebbe qui che io vi sprofondassi
meco nelle voragini della più oscura erudizione, in cerca delle origini della
prefazione. Avrete notato infatti che presso di noi non si scrivono poche
pagine sopra le cose meno importanti del mondo, se, col pretesto di illuminar
bene il lettore, non si risale alle origini del genere umano. I più discreti si
contentano della Bibbia. Molte volte vi sarà capitato in mano un opuscolo che
parla di un quadro, di un coccio di maiolica o di un arazzo, e avrete visto che
una buona metà è spesa a ricordarvi le pitture degli Egizi, i vasi degli
Etruschi, e le tele di Aracne. L'autore vi fa subito capire che vi stima
ignoranti e v'insegna, bontà sua, che Jubal inventò la musica e Tubalcain la
metallurgia. Gli atti e le memorie delle Accademie storiche od archeologiche,
ora quasi esclusivamente consacrate allo studio assiduo delle pentole e dei
pentolini storici e preistorici, primeggiano specialmente in questo comodo
genere di pedanteria. È incredibile come l'uso delle pentole fosse comune
presso i nostri lontani progenitori e come fosse grande la malizia loro nel
nasconderle sotto terra per fornir materia agli atti accademici; ma è più
incredibile ancora l'estensione e la profondità che ha preso ai nostri giorni
questa scienza dei pentolini, per cui gli archeologi moderni, dopo aver esposto
tutta la storia della ceramica, da certi segni e da certe graffiature sanno
dirci appuntino se il coccio fu di un Umbro o di un Ligure, se il vasaio fu
bello o brutto, ammogliato o scapolo. Il che importa molto alla umanità ed alla
archeologia.
La consuetudine
italica del far precedere ad ogni più piccola cosa una storia completa e un
profluvio di erudizione, somiglia molto al morbo della prefazione. È sempre un
preambolo che si volge bensì alla crassa ignoranza del lettore e non alla sua
supposta simpatia, come accade per lo più nella prefazione veramente detta; ma
come preambolo deve esser messo cogli altri. Ed anch'io per non esser meno
buono italiano e meno felice proemiatore, dovrei seguire questa bella
tradizione di erudita seccatura ed infliggervi il supplizio della storia e
della preistoria della prefazione. Ma tanta è la cortesia che mi avete
dimostrato, e per la quale vi sono gratissimo, che sento l'obbligo di essere
umano e vi risparmio la solita risalita della corrente dei secoli, la solita
Bibbia e i Fenici e gli Egizi.
Non posso però
fare a meno di ricordarvi i Greci, perchè tanto fu lieto il loro beato cielo che
vide nascere gli uomini meglio proporzionati del corpo e dell'intelletto che
fossero mai. Il buon gusto fiorì tanto e così felicemente sul fortunato suolo
dell'Ellade, che il suo profumo penetrò perfino la coriacea compagine della
prefazione, la indusse ad esser breve, e gli scrittori che erano Ateniesi nel
testo, furono Spartani nel proemio. Tempi invidiabili ed invanamente
desiderabili, nei quali Tucidide preludeva alla sua storia con dieci righe, ed
Erodoto preponeva alle sue Muse immortali
queste sole parole: «Erodoto d'Alicarnasso avendo per ricerche conosciuto tra
le altre cose, le cagioni delle guerre tra i Barbari ed i Greci, le scrisse in
questi libri e le pubblicò, perchè le cose fatte dagli uomini non siano in
progresso di tempo dimenticate, e le azioni preclare e mirabili, così dei Greci
come dei Barbari, non siano defraudate della debita lode.» E nient'altro!
Nell'originale sono trentanove parole, poco più di un telegramma comune. Oh, se
i fati benigni avessero concesso che le prefazioni fossero tutte così, io credo
fermamente che l'umanità sarebbe più felice!
I Romani,
grandi corruttori d'ogni cosa, guastarono questa aurea e santa semplicità
greca, e la prefazione di Tito Livio, per quanto bella, non è più così breve. A
poco a poco il decadimento non ebbe più riparo e si giunse a tanto che Cicerone
confessa ad Attico di aver pronta una raccolta di prefazioni che possono
adattarsi a qualunque libro.
A tanto giunge
il demone della prefazione, e c'è chi sostiene che i primi capitoli sallustiani
della congiura di Catilina e della guerra di Giugurta, non siano appunto che
due prefazioni del genere delle ciceroniane, a doppio uso, come i sofà letti o
le canne seggiole, poste in fronte al libro. Tanto e così esecrabile fu
l'imperversare della prefazione, che il pubblico irritato, nauseato, si
ribellò, e ai tempi di Plinio il giovane le prefazioni erano cadute in disuso.
Quanti forse tra voi non si augurano ora il ritorno di quella felice
rivoluzione!
Ma la
ribellione del pubblico e la sua avversione ai proemi, da Plinio in qua,
seguitò vivacissima e per 18 secoli non ha smesso e spero che non smetterà così
presto. C'è una guerra, ora sorda, ora fieramente rumorosa tra gli autori e i
lettori. I primi hanno bisogno di parlar di sè e dell'opera propria, gli altri
non ne vogliono sapere, hanno fretta e stimano perduto il tempo speso nei
preamboli. Il commensale che ha l'appetito in resta sdegna i piattini
dell'antipasto e si butta ai piatti di resistenza. Chi ha un colloquio,
d'affari o d'affetto, se la cosa gli preme, salta il proemio ed entra subito in
materia. E gli autori sono tanto ciechi da non vedere che quando si salta la
prefazione si fa un elogio al libro, poichè si crede di trovarlo buono e si ha
fretta di leggerlo. E che quando si fa sul serio si dimentichino i preamboli,
ce lo insegnò quello stesso Cicerone che teneva le prefazioni bell'e fatte e lo
confessava senza arrossire. Quando si trovò in faccia, non un avvocato in
tribunale, ma Catilina in Senato, e non si trattava più delle ciarle del poeta
Archìa, ma della testa che non era molto sicura sullo spalle; Cicerone, l'uomo
delle prefazioni premeditate, l'uomo che ispirò al Passeroni un enorme poema
che non è altro che una prefazione senza libro, credete voi che ricordasse i
precetti dell'oratoria e curasse che la parrucca della rettorica fosse
pettinata con tutte le regole? Si faceva sul serio, e saltò a pie' pari
nell'argomento e cominciò ex abrupto col
celebre quousque tandem. La paura di
perdere il capo non gli fece perdere la testa e spettava proprio a lui ad
insegnarci con tanta autorità che quando la cosa preme i preamboli sono
dimenticati.
Ebbene, il
pubblico ha sempre fretta. Vuol conoscere il libro e non l'autore. Questi gli
sorride dietro le frasche della prefazione, gli strizza l'occhio e gli dice:
guardami come son bello! Ma il lettore vuole il libro e non le smorfie: non
cura gli sfoghi del povero autore che ha tanto bisogno di convincere il
prossimo della perfezione dell'opera sua, di perorare, di persuadere; ma tira
dritto, salta le prime pagine serenamente e comincia il libro. L'autore
insiste, ma l'altro fa di peggio. Di qui una guerra accanita, di stratagemmi,
di imboscate, d'insidie; qua per immergere proditoriamente un'acutissima
prefazione nel cranio del prossimo, là per schivare l'orribil colpo e punire
degnamente lo scellerato aggressore. Le peripezie della lotta sono varie e la
fortuna alterna. Oggi, per esempio, lo sorti volgono contrarie alla prefazione;
il Dio delle battaglie sorride ai lettori. Vedete la poca fortunata resurrezione
del prologo nelle commedie. Quando gli eventi della guerra favorirono gli
autori, costoro infierirono sui miseri vinti ed inflissero loro il supplizio di
questi prologhi che narrano anticipatamente la commedia e le lodi di chi la
fece. Mutate le sorti, il prologo fu sepolto a suon di fischi. Ma eccolo,
cadavere quattriduano, uscito dalla fossa, così sfiaccolato e bastonato che non
c'è bisogno d'esser Profeti o Sibille per predire il suo prossimo ritorno alla
pace del sepolcro. Vedete anche il preludio dei drammi per musica, il quale, o
arieggia alla concisione greca, o si stacca dall'opera, sotto forma di
sinfonia, e tende a vivere di vita propria e non parassitaria. Così abbiamo
opere senza preludio e sinfonie senza opera, come segno certo della decadenza
della prefazione e dell'abominio in che è tenuta dal pubblico.
Ma gli autori
sono costanti, tenaci, testardi. Come i Pelli Rosse camminano cautamente nel
sentiero di guerra, si appiattano alle cantonate dei librai e scuoiano senza
pietà il povero ingenuo che cade nell'insidia. O si infingono come
l'avvelenatore ed aspergono di falso liquore gli orli del vaso, cercando di
fare inghiottire la prefazione sotto il nome di preludio, di preambolo, di
esordio, di proemio, di avviso al lettore. O commettendo ad altri il mandato di
perpetrare il misfatto premettendo al libro una lettera di amico illustre o le
lunghissime due parole dell'editore. Non v'è furberia che non sia stata
adoperata, non v'è lacciuolo che non sia stato teso. Il Manzoni inventò un brano
di cronaca vecchia. Altri più basso e più tardi, trovò la gherminella
dell'amico che pubblica i versi dell'amico morto ed abusò di tutti i più sacri
sentimenti di pietà e di compianto pur di far scoccare l'indegna trappola della
prefazione.
Quando il lettore
c'è caduto una volta, inferocisce, e vede dappertutto il fantasma della
prefazione che lo perseguita. Poche prefazioni si sono salvate dalla fiera
ecatombe, e si sono salvate perchè in fondo non sono prefazioni. Il prologo del
Decamerone è il racconto della peste, l'introduzione all'Enciclopedia una
esposizione di principii filosofici, il proemio al Cromwel un codice di
precetti d'arte. Si sono salvate, prima, certo, perchè belle, poi, certissimo,
perchè impersonali. Infatti possono stare assolutamente senza il libro e non
sono prefazioni che pel posto occupato nella paginatura. Tutte le altre sono
involte nell'odio e nella maledizione, e il lettore che si sente inseguito
dall'autore, gira alla larga, cogli occhi sospettosi; indovina il nemico, come
la colomba lo sparviere; fiuta il pericolo da lontano, lo fugge coll'anima
guasta e il fegato avvelenato, e non ha abbastanza vituperi, oltraggi e anatemi
pel nemico che lo tribola e lo caccia, il fratricida Caino!
Ma se gli odii
e le vendette fra le parti belligeranti sono giunte a tale che per poco non si
danno al cannibalismo, considerate che si tratta sempre di una prefazione
scritta, di poche carte stampate che si possono non leggere o sopprimere, se
così piace. Ma che avverrà quando la prefazione incarnata e fatta uomo, spinge
la temeraria crudeltà fino a presentarsi ad un pubblico di persone ben educate
e gentili quanto si voglia, ma non meno sensibili ai tormenti, non meno
dolorosamente eccitabili al martirio di un preambolo? È il mio caso. Io sono qui
l'odiosa, l'orribile, la spaventosa prefazione, cosciente del male che fa e
dell'avversione che desta. Io sono la prefazione eseguita contro ogni ragion
tecnica dell'arte, cioè fatta prima dell'opera e non dopo. Io sono la vittima,
ahimè non innocente! che gli autori hanno designato al sagrificio, la mascula
Ifigenia che colla sua perdita deve propiziare i venti alle altrui navi. Si
cercava Curzio che si gettasse nella voragine, Orazio al ponte, Muzio Scevola
all'ara. Si volle uno che morisse pel popolo tutto, un candido agnello, una
bianca colomba da offrire al nume irato su questo altare; ed eccomi, candido
agnello, bianca colomba, accettante la passione, interceditrice per tutti.
Che se la
giusta fama della cortesia vostra non mi avesse persuaso, avrei respinto con
orrore questo ufficio spietato di prefazione viva. D'altronde ricordai il detto
di uno Svizzero arguto, secondo il quale l'amore prima del matrimonio è una
prefazione troppo corta ad un libro troppo lungo, e pensai di esser breve
anch'io come l'amore, per conciliarmi la vostra benignità. Quanto al matrimonio
ci penserete voi ed i miei successori, contentandomi di augurarvelo felice e
ricco di numerosa prole.
Comincia dunque
così un ciclo di letture in questa gentile e gloriosa Firenze, destinata, senza
dubbio, dal suo fato a far attecchire finalmente in Italia questo genere d'arte
e di coltura. Pur troppo, finora, presso di noi, anzi in tutti i paesi latini,
i tentativi fatti non ebbero che risultati mediocri, mentre nei paesi nordici,
e specialmente anglosassoni, la lettura e la conferenza ebbero ed hanno una
vita vivace e lodata. Di chi la colpa? Un po' di tutti; dei lettori e del
pubblico. I primi furono per lo più troppo inamidati, troppo accademici, e il
pubblico troppo esigente, troppo facile alla stanchezza. Quest'arte deve ancor
fiorire e fruttificare tra noi, e senza dubbio la palestra che una colta
società apre oggi ai migliori ingegni italiani, gioverà a far amare questi ludi
minervali, e la prova sarà vinta. Poichè, non è già che le razze germaniche
siano dotate di maggior forza di resistenza fisica e morale, da sopportare
letture di maggior peso che gli omeri nostri non possono tollerare. Non è che
gli uomini del settentrione, abituati fino dalla puerizia ad una ragionevole
ginnastica del corpo e della mente, ne traggono muscoli più rigidi e nervi più
tesi contro l'urto e lo sforzo della seccatura. No, poichè non v'è possa umana
capace di resistere a tanto, e ve ne accorgete pensando soltanto che forza
erculea si richiegga per reprimere un indiscreto sbadiglio. La ragione sta qui;
che gli ascoltatori nordici hanno l'abitudine, ed i lettori l'attitudine alla
conferenza. I protestanti hanno sostituito sermoni e conferenze alle nostre
prediche, lasciando in disparte l'enfasi e la gonfiezza che dal Segneri in qua
sciupano la nostra eloquenza sacra, ed accostandosi sempre più al fare piano e
persuasivo delle lezioni e delle letture laiche, educando alla lor volta gli
ascoltatori a questo genere d'arte e guidandoli a gustarlo ed a compiacersene.
Così i lettori e gli ascoltatori, anche per questo, si sono raffinati ed
educati, e tra loro vibra spesso quella corrente di simpatia che è
indispensabile perchè una lettura non riesca a male. Infatti una conferenza è
una grande gabbia, dove sono chiusi due cani, o mettiamo due bestie più nobili,
due leoni, che debbono passare un'ora insieme. Cominciano a guatarsi, a
scodinzolare e ad annusarsi. Se c'è la corrente di simpatia, l'ora passerà
bene; se la simpatia non c'è, accade la baruffa e uno dei duellanti è
inevitabilmente accoppato. Così se la corrente ipnotica non si stabilisce tra
il conferenziere e gli ascoltatori; o il primo fa morire i secondi
coll'asfissia, o i secondi ammazzano il primo colla disapprovazione. In ogni
caso poi, qualunque dei due abbia la peggio, chi muore veramente e di mala
morte, è l'instituzione. Il giusto, secondo il solito, muore pel peccatore.
Ora, se altrove
questa corrente di sensi simpatici fra i lettori ed il pubblico è diventata
quasi abituale, purtroppo dobbiamo confessare che in Italia non è frequente. E
la ragione è facile. Le conferenze sono freddolose; una temperatura mediocre le
ammazza subito, è finchè le signore non si decideranno a frequentare con
assiduità questi convegni dove l'arte o la scienza le desiderano, l'ambiente
sociale e morale sarà sempre freddissimo.
La donna, che
(in generale s'intende) ha i nervi più forti dell'uomo, tanto che riesce a
ballare un carnevale intero senza stancarsi, si spaventa troppo facilmente
all'idea di un piccolo sforzo di attenzione. La sua nativa delicatezza
rabbrividisce all'idea di un quarto d'ora di raccoglimento. E se qualche
lettore non la contenta, generalizza troppo e si sdegna colla instituzione
intera, la sfugge e colla sua assenza la fa morire gelata. Se le signore
sapessero come la loro presenza riscaldi, come i loro begli occhi illuminino
questi convegni, quanto calore e luce e vita diano a tutte le cose umane il
loro aspetto e la benevolenza loro, come voi, egregie Signore, sfiderebbero il
pericolo di qualche momento non perfettamente allegro, mosse dall'idea di far
un'opera bella, utile e veramente degna della fine cortesia femminile. Che se
v'ha certezza di buona riuscita per questa colta società che promove le
letture, essa sta tutta nella felice conciliazione dell'opera intrapresa, colle
simpatie e colla lieta presenza dell'eterno femminino.
Se in Italia
poi è città alcuna più degna di dar vita a simili imprese e dove più fausti
sorridano gli auspici, senza dubbio è questa - la cara e gentilissima Firenze -
dove le conferenze sembrano esser nate, e dove certo per lunghi secoli vissero
prosperamente. Quando la caligine del medio evo cominciò a diradare, e gli
uomini, che tornavano a sentirsi giovani, credettero alla bellezza ed
all'amore, su per questi giocondi colli fiorentini, fuggendo la morìa e lo
spavento, tre giovani e sette fanciulle cominciarono il più lieto corso di
conferenze che sia mai stato. Infatti, che altro è il Decamerone se non una
serie di conferenze amorose, ora geniali, ora brutali, scintillanti ancora
dell'arguzia fiorentina, spiranti ancora l'alito dell'antica vita italiana? Ma
passata la gaiezza della fiorente gioventù, quando la dolce fiamma dell'amore
fu spenta, un'altra illusione sorrise agli ingegni fiorentini, l'illusione
della filosofia. Ed in questa disperata ricerca dell'ideale, in questa speranza
sempre vana di sapere il perchè delle cose, ecco rinascere la conferenza, e il
Ficino negli Orti famosi, parlare ai fratelli in Platone e cercare
affannosamente le prove del Cristianesimo nella filosofia nata già sotto i
platani e gli olivi di Acadèmo. E rifiorirono le beltà dell'arte, frondeggiò
l'albero della scienza in questa Atene italica che dell'antica ebbe tutto, il
genio, la gloria e talvolta anche i vizi.
Caduta la
giovinezza con l'amore, sfiorita colla speranza la virilità, venne il doloroso
periodo della scienza che è fatta di disillusioni e di scetticismo. Già il
Machiavelli leggeva i discorsi sulle Deche negli Orti neoplatonici e cercava,
non più le recondite ragioni dei fenomeni universali, ma il segreto dei fatti e
delle coscienze contemporanee. Il vero, il freddo vero, rimane immobile e
terribile sulle ruine degli ideali e dei sogni caduti. Agli entusiasmi
dell'amore, della fede, della speranza, succedono, come i vecchi ai giovani, i
severi studii della realtà e della esperienza, e in questo radioso e divino
sole di Toscana, Galileo trova e numera le macchie. L'Accademia del Cimento
notomizza la natura, l'Accademia della Crusca notomizza la lingua. Non ci sono
più entusiasmi e tutta una generazione di vecchi frigidi, lavora
matematicamente precisa a scrutare, a compilare, a raccogliere; ma sul suolo
spossato la pianta della conferenza vegeta ancora, diventata scientifica,
erudita o anche pedante, pur tuttavia verde e vitale. Persino gli ultimi e più
cinerei tempi della decadenza la videro trasformata in misere cicalate, ridotta
ai puri lenocinii della lingua, ultimo belletto alla decrepitezza del pensiero;
ma la videro tuttora, quasi a testimoniare della sua tenace vitalità in queste
propizie aure toscane. Le annose radici gettarono polloni ancor verdi fino a
che i tempi furono maturi e compiuti.
Ed ora,
rinnovata ogni cosa nella vita sociale, politica e letteraria, ecco di nuovo la
conferenza antica che, sotto forma di lettura, ringiovanita e rinnovata, si
ripresenta ai colti fiorentini, non immemori delle gloriose loro tradizioni. E
così, uscita dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata il
passato e si propone di dipingervi per ora il lontano periodo delle origini, il
principiare dei Comuni, della Monarchia, del Papato, della lingua e dell'arte.
Eccola, sotto il patrocinio di illustri uomini, col decoro di celebri nomi,
ricordarvi che, nata già in Firenze, a voi, concittadini suoi, spetta il farle
accoglienze oneste e liete ed assicurarle vita duratura. Eccola, per indegno
ambasciatore, rivolgersi fiduciosa a voi, graziose signore, chiedendo la
benevolenza e l'amor vostro che vivifica, riscalda ed illumina. Eccola, infine,
ad implorare la vostra cortese pietà per la vittima della prefazione.
NOTA.
Alle letture
fiorentine doveva preludere l'onor. Ferdinando Martini. Ma l'illustre uomo,
trattenuto a Roma da gravi doveri, non potè, ed io fui chiamato a sostituirlo.
Grato agli
egregi amici che pensarono a me ed a tutti coloro che benevolmente mi accolsero
e festeggiarono, mi è forza però far noto ai lettori come fu fatta questa
conferenza; cioè quasi all'improvviso. Ed essendo prefazione ad un libro ancora
da farsi, non poteva darne che cenni vaghi con parole inconcludenti. Si
trattava di menare il can per l'aia un paio di quarti d'ora, tanto per
cominciare. Il che mi sia di scusa presso coloro che cercheranno qualche cosa
qui, e non la troveranno. O. G.
LE ORIGINI DEL COMUNE DI FIRENZE
DI
Pasquale Villari.
I.
Signori e Signore.
Chiunque sente
annunziare una conferenza sulle origini di Firenze, immagina subito una serie
svariata di avvenimenti fantastici e pittoreschi: castelli feudali;
associazioni di operai, che combattono intorno al Carroccio; poeti; pittori;
l'origine delle arti, della lingua, della cultura italiana. Chi invece ha
l'onore di fare la conferenza, e si pone a studiare coscienziosamente il
soggetto, si trova dinanzi alcuni brani di vecchi annalisti, i quali contengono
una serie scarsa di aride notizie, poco più che dei nomi e delle date: le date
spesso sbagliate, i nomi non sempre intelligibili. È facile immaginarsi come
gli antichi sciupassero qualche volta i nomi, se noi pensiamo che, per esempio,
un cronista quale era Giovanni Villani, nel parlarci di Federico II di Svevia,
di Corradino e degli altri della famiglia Hohenstaufen,
di Casa Sveva, traduce questo nome in Stuffo di Soave. E così avvenne che gli
scrittori moderni, in tanta scarsità di notizie, ricorsero fra di noi al partito
di rinunziare addirittura a discorrere delle origini di Firenze. Basti dire che
l'illustre marchese Gino Capponi, nella sua grande opera, dopo una brevissima
introduzione, fa un salto fino alla morte della Contessa Matilde, e poi in
dodici pagine tratta più di un secolo di storia, arrivando fino al 1215.
Gli antichi si
trovarono dinanzi a questa medesima difficoltà. Ma essi seguirono un metodo
molto semplice. Il Villani ed altri cronisti, non trovando notizie sulle
origini di Firenze, ci dettero una leggenda, che non ha nessun fondamento
storico, e non ha neppure la poesia che si trova nelle leggende che circondano
le origini di Roma e delle città della Grecia. È una leggenda, invece, che
qualche volta manca addirittura di senso comune. Basti dire che in essa (quale
almeno la leggiamo nel Malespini) ci si descrive la moglie di Catilina, che, il
giorno della Pentecoste, va a sentire la messa nella Canonica di Fiesole.
Bisogna quindi
ricorrere ai documenti; ma i documenti fiorentini che noi abbiamo, cominciano
quando già il comune esisteva da un pezzo. È naturale che il Comune non potesse
fare dei trattati, delle leggi prima di cominciare ad esistere. Abbiamo quindi
bisogno d'aiutarci colla storia generale del tempo, coi documenti posteriori, o
di altri luoghi vicini; di interpretare delle frasi; fare delle indagini, per
potere, retrocedendo con la induzione, cercare la spiegazione degli avvenimenti
anteriori. E così è che a voler fare davvero una buona conferenza sulle origini
di Firenze, bisognerebbe farla estremamente noiosa.
Ma si dirà:
perchè scegliere allora un tale argomento? Ve ne sono tanti nella storia
d'Italia meno oscuri e più dilettevoli. Perchè scegliere questo appunto delle
origini? Il vero è che esso ha pure la sua grande importanza, la quale risulta
da più e diverse cagioni. E prima di tutto ve n'è una assai generale. Il Comune
italiano è una istituzione che creò la società moderna. Il Medio Evo non
conosceva lo Stato; l'Europa era divisa in castelli feudali, in associazioni,
quasi in piccoli gruppi e frammenti. Al di sopra di questi frammenti, in cui la
società si era sgretolata, v'erano due grandi, due universali istituzioni:
l'Impero e la Chiesa; l'Impero, che rappresentava il principio giuridico e
politico del mondo; la Chiesa, che rappresentava l'unità del principio
religioso. Ma queste due istituzioni, appunto perchè universali, non potevano
favorire la costituzione dello Stato moderno, nazionale. Il Comune si pose a
tale opera, e gettò le basi dello Stato moderno. Il Medio Evo non conosceva la
civile uguaglianza; l'aristocrazia era una casta separata dal resto della
popolazione; essa in Italia rappresentava il sangue straniero. I lavoratori,
specialmente i lavoratori della terra, non erano liberi, erano attaccati alla
gleba, erano in condizioni servili. Il Comune italiano proclamò l'indipendenza
del lavoro, l'uguaglianza degli uomini. Queste sono le basi su cui si fonda la
società moderna; e così noi, studiando le origini del Comune, veniamo come a
studiare le origini della società di cui facciamo parte, a cercare quasi le
origini del nostro proprio essere civile. Quindi è che tutti i problemi, i
quali si riferiscono alle origini dei Comuni italiani hanno una grande
importanza, destano un singolare interesse. Questa è anche la ragione per la
quale si è tanto disputato, per sapere se il Comune discendeva dalle
istituzioni e dalla cultura romana o doveva invece la sua esistenza ad un
principio nuovo, portato fra noi dai popoli germanici, i quali avrebbero così
avuto il vanto d'aver messo le prime basi alla moderna civiltà. Il patriottismo
si è mescolato in questa disputa, ed ha reso sempre più difficile il trovare
una soluzione imparziale e scientifica.
Ma pel Comune
di Firenze v'è ancora una ragione speciale, che rende maggiore la sua importanza,
e più vivo il desiderio d'indagarne le origini. Esso è il più democratico di
tutti quanti i Comuni italiani, è quello che ha più di tutti lavorato per
l'uguaglianza civile degli uomini. Uno storico, assai celebre, il Thiers,
appunto per questa ragione, aveva deciso di dedicare gran parte della sua vita
alla storia di Firenze. Egli diceva: nessun altro Comune ha, nel Medio Evo,
affrontato tanti problemi economici, politici, sociali, e nessuno s'avvicinò
tanto alla loro soluzione; nessun creò un così gran numero di nuove, ingegnose,
mirabili istituzioni, come il Comune di Firenze. Ed aveva perciò in molti anni
raccolto una vasta serie di materiali, che andarono poi bruciati al tempo della
Comune di Parigi. Ma vi è di più. La storia fiorentina si può dire che sia a
tutti noi notissima. Nessun paese in fatti ha avuto un così gran numero di
sottoscrittori che l'abbiano illustrata. Ogni avvenimento, ogni individuo, ogni
pietra di Firenze fu oggetto di lunghi studi, di dotte ricerche. Le sue
rivoluzioni furono descritte con grande eleganza di stile, ed i personaggi che
si presentano nella sua storia, sono a noi tutti famigliarissimi. Ma, ciò non
ostante, la storia di Firenze apparisce assai spesso come un enigma.
Rivoluzioni succedono a rivoluzioni, senza che noi possiamo capire il perchè di
tanta irrequietezza. Questo popolo sembra non avere e non lasciar mai pace e
nessuno. Per un matrimonio avvenuto in un modo piuttosto che in un altro,
perchè il Buondelmonti, invece di sposare l'Amidei, sposa la Donati, non basta
averlo pugnalato sul Ponte Vecchio, ai piedi della statua di Marte; ma la
cittadinanza intera si divide in Guelfi e Ghibellini, che lacerano la Città per
secoli, e non si acquetano mai fino a che non sorge la tirannide ad opprimerli
tutti. E vien fatto qualche volta di chiedere: che cosa vogliono questi
Fiorentini, che empiono continuamente di tumulto e di sangue le strade della
loro bella città? Perchè non posano mai? Sono essi così assetati di sangue,
così pieni del desiderio della vendetta, da non poter trovare nè lasciare
tregua a nessuno?
Ma quando ci
facciamo questa domanda, il mistero cresce ancora più, perchè in mezzo a tanto
tumulto, noi vediamo fiorire splendidamente le arti della pace. Il commercio,
le industrie dei Fiorentini riempiono colle loro manifatture tutti quanti i
mercati dell'Europa, dell'Oriente e dell'Occidente. E, come se questa
contraddizione fosse poca, a crescere ancora più il mistero, noi vediamo qui
sorgere le più pure, le più ideali immagini che la mente umana abbia mai saputo
creare. La Beatrice di Dante, la Santa Cecilia di Donatello, le Madonne di Luca
della Robbia, i Santi, gli Angeli di Benozzo Gozzoli e di Beato Angelico
sorgono in mezzo a questo tumulto infernale, così splendidi e numerosi, che noi
siamo spinti a domandarci: di dove mai essi vengono? chi li ha creati? Essi
sembrano discesi in una bolgia infernale, come l'Angelo di Dante, che, a piedi
asciutti, sdegnoso, frettoloso, traversa la palude Stige, rimuovendo con la
mano dal viso le ingrate esalazioni. E allora nasce la speranza, che forse,
studiando le origini del Comune, vedendo in che modo esso fu costituito, di
dove questa società è partita, dove si è fin dal principio indirizzata, la
ricerca, per quanto arida, per quanto penosa ed incompiuta, possa gettare una
qualche luce sugli avvenimenti posteriori della storia fiorentina. Ed è perciò
che gli scrittori moderni si sono oggi più che mai rivolti nuovamente a
studiare le origini di questo Comune. Cerchiamo dunque di affrontare l'arido
problema. E qui ho bisogno di raccomandarmi non solo alla vostra indulgenza, ma
anche a tutta la vostra pazienza.
II.
Innanzi tutto,
come ho già accennato, ci si presenta una leggenda. Questa incomincia da Adamo,
poi salta ad Attalante, il quale viene a cercare il luogo più salubre d'Europa,
per formarvi una città. Trova questo luogo sulla collina che è a settentrione
di Firenze, e col consiglio e l'aiuto di un astrologo, vi costruisce una città,
unica al mondo per la sua salubrità, e che perciò vien chiamata Fiesole, Fie-sola. Ciò che vale a darci un'idea
della rozzezza di questa leggenda, si è il modo in cui essa spiega il nome di
quasi tutte le città della Toscana. Lucca si chiama Lucca da lucere, perchè i Lucchesi furono i primi
ad accertare la luce del Cristianesimo. Pistoia si chiama Pistoia perchè in
quella campagna fu già grandissima guerra ai tempi di Catilina, tale che vi
morì così gran gente, che si sviluppò la peste, donde il nome di Pistoia. Siena
è nel luogo in cui i Francesi, andando a combattere i Longobardi, che erano nel
mezzogiorno d'Italia, lasciarono tutti i loro vecchi. Di qui il nome Senæ, Senarum, adoperato in plurale.
Pisa è nel luogo dove i Romani pesavano i tributi dei popoli soggetti. Era
necessario pesare contemporaneamente in due luoghi diversi, e però, Pisæ Pisarum, al plurale.
La leggenda
prosegue dicendo che Attalante ebbe varii figli, uno dei quali, Dardano, andò a
fondare la città di Troia, e quindi narra l'assedio e l'incendio di questa
città, la fuga di Enea, l'origine di Roma. E qui si salta a Catilina, che venne
a Fiesole, inseguito dai Romani, comandati da un generale, il quale si chiamava
Fiorino, e fu disfatto sulle rive dell'Arno. Cesare allora venne a vendicarlo,
e fondò in suo onore, sull'Arno, la città di Firenze, la quale fu costruita come
una piccola Roma, con tutti i monumenti che erano nella Città eterna, il
Campidoglio, l'Anfiteatro, le Terme, il Foro, e fu chiamata perciò la piccola
Roma. Vengono poi i barbari, e Totila distrugge Firenze; ma Carlo Magno la
ricostruisce. E finalmente arriviamo alla guerra che Firenze muove a Fiesole,
distruggendola.
Che cosa
possiamo noi cavare da questa leggenda, la quale fu certo compilata nel secolo
duodecimo, il secolo cioè in cui nacque il Comune fiorentino? Innanzi tutto ne
caviamo, che nel secolo in cui Firenze nasceva, i Fiorentini avevano la mente
piena di idee e di tradizioni romane. Qui noi non troviamo tracce di tradizioni
germaniche, anzi la leggenda sembra respingerle sdegnosamente ogni volta che si
presentano. In una delle sue compilazioni, si ricorda essere stata opinione
molto diffusa, quella che diceva la famiglia Uberti venuta di Germania, discesa
dall'imperatore Ottone. Ma ciò, si aggiunge subito, è un errore, perchè gli
Uberti discesero invece dal sangue di Catilina «nobilissimo re di Roma». Questi
ebbe un figlio, Uberto Cesare, a cui una moglie fiesolana dette 16 figliuoli,
uno dei quali fu mandato da Augusto a sottomettere la Sassonia, che s'era
ribellata, e colà sposò una dama tedesca, da cui nacque Ottone imperatore. E
così non sono già gli Uberti discesi dagl'imperatori tedeschi; ma gl'imperatori
sono discesi dagli Uberti di Firenze, i quali vengono dal sangue di Catilina
romano. La leggenda ci dice ancora che tra Fiesole e Firenze vi fu un
antagonismo perpetuo. Fiesole infatti è città etrusca, Firenze città romana.
Tutti i nemici di Roma sono, secondo essa, nemici di Firenze; tutti gli amici
di Roma sono amici di Firenze; Cesare, Fiorino, Augusto. Carlo Magno è quello
che ricostruisce Firenze, dopo la distruzione fattane da Totila, ed esso è il
restauratore dell'Impero. Totila rappresenta i barbari che lo distrussero.
Catilina, nemico di Roma, è l'amico di Fiesole, il nemico di Firenze.
Se noi
guardiamo alle poche notizie storiche che abbiamo su tutto ciò, vedremo che la
leggenda non fa altro che ripeterle nel suo fantastico linguaggio. Fino dai
tempi di Dante era noto che Firenze discese da Fiesole ab antico, ed il
Machiavelli ci dice che Firenze fu una città, la quale nacque dai mercanti
fiesolani, che vennero a cercare un emporio sull'Arno, là dove il Mugnone si
congiunge con esso. Fondarono delle capanne, le quali divennero case, e le case
formarono più tardi una città. Questa si formò, secondo tutte le notizie che
abbiamo, due secoli circa innanzi Cristo. Era un municipio florido al tempo di
Silla, e gli scavi recentemente fatti hanno confermato tali notizie, essendosi
trovate monete, colonne, ruderi, i quali provano che la Città a quel tempo
aveva già le terme ed un Anfiteatro di pietra. Augusto la restaurò e vi fondò,
secondo alcuni, una colonia, che fu chiamata perciò Julia Augusta Florentia. Secondo altri, la colonia fu fondata
invece da Silla. È certo che Firenze ebbe mura romane, le quali esistevano
ancora a' tempi del Villani, e qualche avanzo se n'è ritrovato ai giorni nostri.
Il suo anfiteatro fu in tutto il Medio Evo conosciuto col nome di Parlascio, e
di esso qualche traccia può vedersi ancora nel Borgo dei Greci. Le Terme erano
presso la strada che oggi porta questo medesimo nome. La città aveva pure il
suo Campidoglio, in Mercato Vecchio, nel luogo dove fu la Chiesa lungamente
chiamata di Santa Maria in Campidoglio. Era nondimeno piccolissima; non
solamente non andava al di là d'Arno, ma anche la strada che ora è chiamata
Borgo Santi Apostoli, rimaneva fuori delle mura. Questo è tutto quello che noi
sappiamo dei tempi più antichi.
Quanto alla
notizia poi che ci dà la leggenda, della distruzione di Firenze per opera di
Totila, essa non è vera che in parte. È certo che Totila coi Goti venne in
Toscana, verso la metà del sesto secolo, la oppresse, la saccheggiò, entrò in
Firenze, e la trattò assai duramente, ma non la distrusse. Se non che Firenze
allora, e durante tutto il dominio dei Longobardi, cadde in una così grande
oscurità, che par quasi scomparsa dal mondo, e nei documenti è qualche volta
menzionata, come se non fosse altro che un borgo di Fiesole. La leggenda
esprime tutto questo, dicendo che Totila distrusse Firenze. E siccome essa
incominciò finalmente a risorgere alquanto al tempo dei Franchi, sotto Carlo
Magno, così la leggenda, seguendo sempre lo stesso metodo, dice che Firenze fu
ricostruita da Carlo Magno. Questi vi si fermò per celebrarvi il Natale nel
786, e dopo di lui molti Imperatori, trovandola sulla via di Roma, dove
andavano a prendere la corona, vi si fermarono del pari. Più volte ci vennero
anche i Papi, quando i frequenti tumulti popolari li cacciavano dalla Città
eterna. Alcuni di essi morirono a Firenze, dove tennero Concilio, ed Alessandro
II vi fu eletto. Certo è che le continue relazioni di Firenze con Roma
cominciarono a farla risorgere alquanto dalla profonda oscurità in cui era
caduta durante il dominio longobardo.
III.
È noto che i
Longobardi per due secoli oppressero duramente l'Italia, ponendo nelle città
principali i loro duchi. A questi i Franchi sostituirono poi i conti. Ma perchè
i Ducati erano assai grandi, e i duchi troppo potenti, i Franchi, non volendo
che questi principi mettessero a pericolo l'unità e la forza dell'Impero,
resero più deboli i conti e più piccoli i loro Comitati. Sui confini
dell'Impero occorreva però aver forza maggiore alla difesa, quindi vi crearono
quello che chiamarono Marche, le
quali erano grossi Comitali, e i conti che le comandarono, furono Mark-grafen, margravi, marchesi. La
Toscana fu uno di questi Margraviati. Il marchese o duca, giacchè qui usavano
allora l'uno e l'altro titolo, aveva il supremo comando, in nome dell'Impero, e
al disotto di lui erano i conti. Al tempo di questi margravi, Firenze rimase
lungamente una città oscura. Pisa e Lucca cominciarono a sorgere più presto, la
prima perchè favorita dalla sua posizione sul mare; la seconda perchè, stata
già sede dei duchi longobardi, era adesso sede principale dei margravii.
Conseguenza di questa forma di governo stabilitasi in Toscana, fu che, mentre
in Lombardia ed in tutta l'Italia settentrionale, gl'Imperatori favorivano i
nobili minori ed i vescovi, a danno dei maggiori, che volevano indebolire,
l'esistenza dei margravii in Toscana portò invece l'indebolimento dei conti
minori, dei vescovi, ed in generale uno svolgimento meno vigoroso del
feudalismo.
Questo stato di
cose durò fino ai tempi della contessa Matilde, la quale comandava nella
Toscana, ed in gran parte dell'Italia centrale. Essa si trovò trascinata nella
lotta fra l'Impero e la Chiesa, fu severa contro quelle città, quei conti e
nobili che non s'univano a lei, ma favorivano l'Impero. È questo il momento in
cui Firenze, stata quasi sempre amica dei Papi, cominciò a prosperare, senza
che però il Comune si fosse ancora formato. Il vederlo così tardi apparire è un
fatto che stimolò continuamente l'attenzione degli storici, i quali non si
seppero rendere ragione del perchè un Comune che poi progredì con tanta
rapidità, dovesse essere quasi l'ultimo a sorgere. Infatti esso ci si presenta,
non solamente dopo i Comuni di Venezia, di Amalfi, delle principali città
marittime, che precedettero tutte le altre; non solamente dopo i Comuni
lombardi; ma anche dopo i Comuni stessi della Toscana. È questo un altro dei
tanti misteri, che troviamo nella storia di Firenze.
Il primo segno,
che incominci a farci vedere come già si formi una cittadinanza fiorentina, e
ci presenta non un Municipio, ma quasi l'ombra lontana d'un Municipio che vuole
apparire, è un fatto assai strano. Nel 1063 il popolo di Firenze si ribellava
contro il suo vescovo Mezzabarba, perchè lo credeva eletto simoniacamente, cioè
per danaro pagato al duca Goffredo, marito di Beatrice, la madre di Matilde.
Volevano che il vescovo si dimettesse, e le passioni si accesero perciò a segno
che centinaia e centinaia morirono senza sacramenti, piuttosto che riceverli da
preti ordinati dal vescovo simoniaco. Il Papa disapprovò questa condotta, ma
invano scrisse e mandò suoi messi a calmare gli animi. Quando il furor popolare
era al colmo, un frate dell'ordine di Vallombrosa, del quale si narra che era
stato guardiano di giumenti, si offrì di passare attraverso al fuoco per
provare che il vescovo non era legittimamente eletto. La prova ebbe luogo
presso la Badia di Settimo e noi abbiamo un documento del tempo, che
minutamente descrive il fatto. In esso si racconta, che il vescovo aveva
minacciato coloro che non volevano obbedirgli, di farli «non condurre, ma
trascinare» dinanzi al Præses dal Municipale Præsidium, e di fare
confiscare i loro beni dal Potestas.
Queste sono le
prime parole che incominciano a farci vedere l'esistenza di alcune
magistrature, magistrature però che esistono prima che il Comune sia nato, e si
connettono ancora con le istituzioni feudali. Il Potestas però qui non ha nulla da fare col Podestà, che si trova
più tardi; non è altro che il margravio, il duca Goffredo. Qui come altrove noi
troviamo nei documenti del tempo nomi romani anche per indicare idee e
istituzioni germaniche. Il Municipale
Præsidium non poteva essere che un presidio, dal duca Goffredo e poi dalla
contessa Matilde tenuto in Firenze. Ma il chiamarlo Municipale fa credere che fosse composto di cittadini, e dimostra
che la Città cominciava a sentire la sua personalità, la sua individualità. La
narrazione degli avvenimenti citati, è fatta in forma di lettera scritta al
Papa, in nome del Clerus et Populus
Florentinus; e le lettere che San Pier Damiano, incaricato dallo stesso
Papa di calmare il furore popolare, mandava a Firenze, sono indirizzate: Civibus florentinis. Noi dunque non
abbiamo ancora il Comune, ma ci accorgiamo che oramai è vicino a sorgere. Pure
esso tarda ancora, e lo vediamo, la prima volta, apparire, quando già altri
Comuni vicini si sono non solamente formati, ma cominciano a prosperare.
E qui si
presenta una prima osservazione, la quale giova anch'essa a spiegarci, perchè
mai il Comune fiorentino nacque più tardi degli altri. La condizione geografica
di Firenze ebbe in ciò una parte grandissima. Se la città si fosse trovata
sulla pianura, come Lucca e Pisa; se si fosse trovata sulla collina, come
Siena, Arezzo, i nobili avrebbero avuto interesse ad entrarvi, perchè i
cittadini, che alla nobiltà erano avversi, avrebbero avuto non piccolo
vantaggio nell'assalire i castelli nella valle o nella pianura. Ma Firenze
essendo invece nella valle, circondata da colline, sulle quali erano moltissimi
castelli che l'accerchiavano, i nobili avevano una posizione vantaggiosa, che
tornava loro conto mantenere, perchè così potevano più facilmente minacciare e
vincere la cittadinanza. Da questo fatto vennero due conseguenze. La prima fu
che il Comune fiorentino, col suo territorio, come dice il Villani, tutto
incastellato, stretto cioè da un cerchio di castelli feudali, non poteva
facilmente espandersi; e così il suo nascere e la sua indipendenza furono da
tali condizioni ritardati. La seconda conseguenza fu, che tra i nobili e gli
abitanti della Città, la maggior parte dei quali erano commercianti o
artigiani, nacque un antagonismo molto più profondo e duraturo, che non si vide
a Pisa, a Siena, a Lucca, in alcun altro dei Comuni italiani. La democrazia e
l'aristocrazia si trovarono di fronte, separate in due campi avversi, senza
potersi fra loro mai conciliare.
IV.
Così noi
abbiamo una spiegazione del perchè il nostro Comune sorse più tardi degli
altri, e la spiegazione del perchè, sin dal principio, esso ebbe un carattere
più democratico. E questo ci viene indirettamente confermato dai documenti
toscani, nei quali, quando si parla di Firenze, non troviamo quasi mai la
parola nobiles, che pure s'incontra
assai spesso quando si parla di Pisa, di Siena, di Lucca. Ma oltre di ciò,
bisogna osservare che questa cittadinanza (se così dobbiamo ora chiamarla) di
Fiorentini, che apparisce già formata prima del Comune, non era costituita
quale noi ce la potremmo immaginare oggi. Essa era divisa in un numero
grandissimo di piccoli gruppi, sopratutto associazioni di arti e mestieri, le
quali erano una trasformazione delle antiche Scholæ romane, quali le troviamo a Ravenna ed a Roma in tutto il
Medio Evo. Queste associazioni primitive, informi di arti e mestieri, noi le
vediamo a Venezia, fin dal nono secolo, ricordate nella cronaca Altinate. E
sebbene i documenti e le cronache di Firenze non ce ne parlino, perchè noi non
possiamo pretendere di trovare nè documenti nè cronisti d'un Comune che ancora
non esisteva, che ancora non aveva proclamata la sua indipendenza, ciò non
basta a negare che la cittadinanza fosse già divisa in gruppi più o meno
ordinati e costituiti. Questa divisione anzi è quella che ci fa intendere come
mai, prima che fosse nato il Comune, la società potesse prosperare di ricchezza
e di forza, tanto da muoversi qualche volta a far guerra per proprio conto. Il
governo locale s'andava formando in queste associazioni embrionali, le quali,
coi loro capi, reggevano la cittadinanza, senza bisogno d'un governo centrale;
così la prosperità poteva crescere e l'indipendenza esistere di fatto, prima
che di diritto, prima che il Comune fosse nato. Di maniera che alla contessa Matilde
bastava avere nella Città un presidio composto di Fiorentini, i quali, in nome
di lei, facevano quello che la Città voleva. Ai Fiorentini non giovava
dichiararsi indipendenti prima del tempo. Quando si fossero allora separati
dalla Contessa, questa, col solo abbandonarli, li avrebbe lasciati in balìa di
tutti quei nobili che d'ogni lato li circondavano. Prima dunque d'arrischiarsi
ad un tal passo ardito, dovevano mettersi in grado di poter combattere e
demolire i vicini castelli, sentirsi forza sufficiente a condur soli una guerra
lunga e difficile. Perciò essi tardarono tanto, e così può dirsi che il Comune
esista già prima che sia nato.
Nel 1081 noi
troviamo che l'imperatore Arrigo concedeva ai Lucchesi di poter liberamente
commerciare nei mercati di San Donnino e Capannori, dai quali esplicitamente
escludeva i Fiorentini. Ciò vuol dire che il commercio di questi era già grande
abbastanza e temibile, in un tempo nel quale noi siamo ancora lontani dal veder
sorgere il Comune. Con gli artigiani v'erano anche delle famiglie di signori,
di grandi, che si chiamavano Sapientes,
Boni homines, i quali a Firenze non erano nè conti nè visconti o duchi;
erano quasi sempre nobili decaduti, che, non potendo vivere nel contado colla
società feudale, s'erano ridotti in Città, o erano nuovi ricchi, saliti su dal
popolo, col quale serbavano sempre stretti legami. Erano anch'essi associati
fra loro, e possedevano in comune delle torri, intorno alle quali cominciarono
a formare le cosidette Compagnie o Società delle torri.
Tali sono le
condizioni in cui noi ci possiamo immaginare Firenze, prima che il Comune
nascesse. E tanto è vero che i Fiorentini avevano già di fatto una indipendenza
reale, prima che avessero una indipendenza legale, che noi troviamo nel 1107,
nel 1110, nel 1113 tre guerre da essi combattute contro i vicini castelli di
Monte Orlando, di Prato, di Monte Cascioli, vincendo i Cadolingi e gli Alberti,
conti allora potentissimi. E queste guerre furono condotte nell'interesse
commerciale delle Città, contro il feudalismo, il che ci riconferma nella
opinione, che le forze crescenti della cittadinanza venivano dal commercio e
dall'industria, e che gli artigiani dovevano formare la parte principalissima
di quella cittadinanza, se tutto si faceva a loro vantaggio.
Un altro fatto
che, in tanta scarsità di notizie, ha pure la sua importanza, si è che nel
1113, quando i Pisani andarono all'impresa delle Baleari contro i Saraceni,
temendo che la loro città potesse essere assalita dai Lucchesi, ne affidarono
la guardia ai Fiorentini. E questi presero subito il loro campo fuori delle
mura, con ordine ai soldati, che nessuno, pena la vita, osasse entrare nella
Città, perchè non volevano che fosse fatto ingiuria ad alcuno, sopra tutto alle
donne: non volevano che la lealtà fiorentina potesse essere neppure un momento
sospettata. Uno solo, violando le leggi della disciplina, osò entrare in città,
e fu messo a morte. I cronisti raccontano tutto ciò con molti particolari che
tradiscono la leggenda. Nondimeno questo ed altri simili racconti ci dicono,
che i Fiorentini erano allora in concetto di una grande lealtà d'animo, di una
grande moralità di costumi, e ciò risponde anche a tutte le descrizioni che i
cronisti ci fanno dei tempi più antichi del Comune, risponde alla descrizione
che ci fa Dante di Firenze, quando viveva sobria
e pudica. Il Villani si ferma con orgoglio a descrivere la semplicità di
quei costumi, e finisce col dirci, che una dote di 100 lire era allora una dote
comune, e una di 300 lire era tenuta dota
isfolgorata. Dal che noi possiamo nuovamente concludere, che nella Città
non potevano esservi ancora nè una vera aristocrazia, nè costumi feudali.
Vediamo semplicemente i costumi dei primi artigiani fiorentini, costumi che
continuarono a durare un pezzo nella loro antica purità.
Ma perchè tutti
questi fatti non hanno grandi narratori, non hanno molti documenti? Torniamo a
ripeterlo, perchè il Comune non era nato, non poteva quindi fare trattati in
suo nome; e se combatteva per proprio conto, lo faceva col consenso di Matilde,
dalla quale tuttavia dipendeva, dalla quale non era e non voleva essere
indipendente, perchè non gli conveniva.
V.
Ed ora, o
Signori, siamo all'anno 1115, anno in cui muore la contessa Matilde, e
l'indipendenza del Comune incomincia. Come incomincia? Prima di tutto
l'esercizio principale del potere di Matilde in Firenze, consisteva nel rendere
giustizia solenne nei tribunali che presiedeva; e noi abbiamo in fatti molte
sentenze da lei pronunciate. Un dotto scrittore tedesco ha esaminato queste
sentenze, ed ha osservato che in esse, a poco a poco, il carattere germanico
margraviale del tribunale si andava alterando, sotto l'azione crescente del
diritto romano. E quale era questa alterazione? Secondo l'antica usanza, il
presidente del tribunale pronunziava solennemente le sentenze, le quali esso
formulava col parere dei giudici. A poco a poco l'importanza dei giudici crebbe
in maniera, che il presidente divenne inattivo,
fece cioè poco più che pronunziare la sentenza da altri apparecchiata. Questo
fatto semplicissimo portò che la presenza di Matilde cominciò a divenire quasi
superflua, a segno che essa di tanto in tanto non intervenne nei giudizii,
lasciando i tribunali a sè stessi. Negli ultimi quindici anni della sua vita,
noi infatti non la vediamo quasi più comparire nei tribunali fiorentini. I
giudici che spesso erano fiorentini, pronunziarono allora essi le sentenze, e
così i cittadini si trovarono già fino dai tempi della Contessa, ad esercitare
uno dei principali attributi della sovranità. Di maniera che, quando essa morì,
restò un popolo, che non era ancora libero e indipendente davvero, ma che aveva
già fatto guerre per proprio conto, e si amministrava da sè stesso la
giustizia.
Quando la
contessa Matilde scomparì dalla scena del mondo, vi fu nell'Italia centrale un
periodo di estrema confusione. Essa aveva lasciata erede di tutti i suoi beni
la Chiesa, la quale perciò voleva assumere il governo della Toscana. Ma il
Margraviato apparteneva all'Impero che voleva riprenderlo. La Contessa poteva
disporre dei soli beni allodiali, non dei feudali. Distinguere gli uni dagli
altri non era facile, spesso non era possibile; e così ne nacque una crisi
economico-sociale-politica. Il Margraviato ne andò in fascio, e le sue varie
parti si separarono, per mancanza di un'autorità superiore che potesse
esercitare il potere. In mezzo a questo stato di cose, Firenze si trovò libera
e indipendente, senza quasi avvedersene, senza quasi sentire il bisogno di
avere un nuovo governo. La società era già tutta quanta in mano delle
associazioni; di un governo centrale v'era appena bisogno. Quelle famiglie che
avevano comandato il presidio, che avevano amministrato la giustizia in nome di
Matilde, continuarono a farlo in nome del popolo, e furono i Consoli del
Comune. Quale è il primo segno di questa indipendenza? La ripresa della guerra
contro il Castello di Monte Cascioli, che fu demolito e bruciato. Questo fatto
ebbe una speciale importanza.
L'imperatore
Arrigo IV aveva mandato un tale Rabodo a restaurare l'autorità dell'Impero in
Toscana. Questi, a San Miniato al Tedesco (che allora cominciò ad essere così
chiamato) raccolse i nobili, per riprendere, in nome del suo sovrano, il
potere; andò poi alla difesa di Monte Cascioli e i Fiorentini, combattendo il
Castello, combatterono il vicario e lo uccisero. Così essi presero finalmente
il loro partito, e dichiarandosi avversi all'Impero, divennero un Comune
indipendente, senza quasi accorgersene. E questa è la ragione per la quale gli
storici rimasero maravigliati e confusi. Come! Firenze la patria di Dante, la
patria di Michelangelo, quella che ha avuto così gran parte nella coltura del
mondo, nasce senza che nessuno se ne avveda? Vi deve essere qualche errore, vi
devono essere stati documenti ora scomparsi, deve essere avvenuta una
catastrofe che è stata dimenticata. Non è avvenuta nulla di ciò. Firenze aveva
cominciato ad essere di fatto indipendente; continuò per la medesima via,
quando scomparve la contessa Matilde. La rivoluzione avvenne senza grandi
scosse, senza quasi che alcuno se ne avvedesse. Ma gli scrittori come Giovanni
Villani non sapevano persuadersi di dover cominciare così modestamente la
storia della Città, essi che vivevano nei giorni in cui la patria loro
primeggiava e risplendeva. E però, quando nel 1300, al tempo del giubileo, il
Villani si trovò a Roma, e ne ammirò i grandi monumenti, «io voglio scrivere,
esso diceva, la storia di Firenze, perchè Firenze è figlia di Roma, ed è ora
nel suo salire, quando invece Roma è nel suo cadere.» Pieno di questa idea,
voleva imitare Tito Livio, e scoprirvi qualche cosa di simile alle origini di
Roma. Trovando invece una città nata modestamente da un gruppo di mercanti,
arrivata alla libertà e indipendenza senza fare alcun rumore, non se ne
contentava, non se ne persuadeva, e ricorreva invece alla leggenda, che
connetteva Firenze con Roma, con Troja, con Enea, e la narrava come se fosse
storia. Per queste stesse ragioni anche i moderni cercarono nella storia quello
che non v'era. I fautori dell'origine germanica dei Comuni non vogliono credere
che questa cittadinanza si sia potuta formare di artigiani, senza che vi sia
entrato elemento feudale germanico; lo cercano, e non ve lo trovano, e non
sanno di ciò persuadersi. Gli scrittori italiani, se sono nemici del Papa, ghibellini,
non si persuadono che questa repubblica, la patria di Dante e del Machiavelli,
sia nata, si sia formata, sotto la contessa Matilde, amica del Papa, e protetta
da lei. E vanno anch'essi in cerca di avvenimenti che non seguirono mai. Gli
scrittori guelfi, è vero, si rassegnano a ciò più facilmente assai; ma non
sanno neppur essi capire come mai Firenze sia potuta nascere dopo di Pisa, di
Lucca, di Siena, di tante altre città. Così tutti cercano quello che non si può
trovare, perchè non avvenne mai, e non vogliono vedere la verità che è chiara e
lampante sotto i nostri occhi, e sta tutta nelle poche notizie certe che
abbiamo. Altre non ve ne sono, altre non sarà facile, non sarà possibile, io
credo, trovarne.
VI.
La Repubblica
si formò dunque come da sè stessa. I capi delle famiglie, i quali avevano
giudicato, comandato il presidio, guidato l'esercito in campo, divennero i
Consoli. I capi delle associazioni, insieme coi loro aderenti, formarono il
Consiglio, che si chiamò anche Senato. Nelle grandi occasioni, quando si
trattava d'affari assai importanti, si sonava la campana e si raccoglieva il
popolo a Parlamento. E questo era il Comune fiorentino. Noi però non dobbiamo
immaginarci che un tal governo avesse l'importanza che hanno i governi delle
società moderne, perchè in Firenze il governo vero restava sempre nelle mani
delle associazioni. Ciò è tanto vero, che nei documenti, nei trattati che si
fanno fra città e città, si dice spesso che saranno eseguiti dai Consoli, se vi saranno, e se non vi saranno, li
faranno eseguire i Boni homines, i
capi delle Arti o altri cittadini. Il governo centrale aveva un'importanza
assai secondaria, il che ci spiega ancora, come mai, in quelle continue
rivoluzioni, in quei continui mutamenti di leggi e di statuti, quando a noi
pare qualche volta che un governo più non esista, le cose potessero nondimeno
procedere secondo il loro ordine naturale e normale. La Città passava di
rivoluzione in rivoluzione, senza che alcuno sembrasse turbarsene, e quando a
noi parrebbe che dovesse seguirne il finimondo, tutto invece continuava secondo
il solito, perchè il governo era sempre restato in mano delle associazioni. Non
era uno Stato accentrato come i moderni, era una specie di confederazione di
arti e mestieri, di consorterie, di società diverse. Questo carattere generale
lo troviamo in tutti i Comuni italiani, ma in Firenze più che altrove. Ciò
spiega in gran parte la prodigiosa attività e intelligenza popolare di quei
tempi. Il cittadino era ogni giorno chiamato a prender parte alla cosa
pubblica; la discussione era continua; continui gli attriti nei quali si
formava e svolgeva una varietà infinita di caratteri, di attitudini morali,
industriali, politiche. E spiega ancora come, in mezzo a così incessanti
tumulti, potessero così splendidamente fiorire le arti della pace: l'industria
il commercio, le lettere, la pittura, la scultura, l'architettura.
La seconda
guerra che fece Firenze, nei primi tempi della sua vita popolare, fu la guerra
contro Fiesole, presa e distrutta nel 1125. E perchè fu fatta questa guerra?
Perchè, ci dice il Villani, Fiesole era divenuta il nido di tutti i cattani
lombardi, cioè i conti che avevano, secondo lui, origine longobarda, e che
veramente avevano la più parte origine germanica. In questo momento, in fatti,
nel quale i messi imperiali sono a San Miniato, i signori feudali del contado
si raccolgono intorno a loro, contro la Città, e nei documenti troviamo spesso
che gli uni e gli altri sono chiamati Teutonici.
La popolazione toscana s'era così come divisa in due. Da un lato si vede un
partito germanico, feudale, imperiale; dall'altro le città, in cui erano
principalmente gli artigiani, gli eredi del sangue romano, che rappresentavano
il lavoro e l'industria, e divenivano ogni giorno più una forza, una potenza
capace di misurarsi col partito imperiale. A Fiesole, per la posizione assai
forte che essa aveva sul monte, resa più forte da una rôcca, s'erano raccolti
molti di questi nobili feudali, e minacciavano la sottoposta Città; ne
devastavano le campagne, ne impedivano il commercio. I Fiorentini perciò
mossero all'assalto. Leggendo la narrazione, che di questa guerra ci dà il più
antico cronista fiorentino, il Sanzanome, il quale era un notaio, par di
leggere la descrizione d'una delle guerre fra i Romani ed i Cartaginesi. Egli
ci presenta un Fiorentino, che si leva in mezzo al popolo e dice: Se siete
veramente i figli di Roma, come pretendete, questo è il momento di mostrarlo. E
subito dopo fu emanato un editto dai Consoli, che dichiararono la guerra. Si direbbe
che il cronista fosse un erudito del secolo XV, tanto le idee, la coltura, la
forma, i pensieri romani erano sin d'allora vivi in quella cittadinanza.
Se dunque noi
troviamo forme e tradizioni romane, prima che il Comune sia costituito, nella
narrazione che descrive la prova del fuoco seguita nel 1068; se troviamo
tradizioni e forme romane, quando il Comune si va costituendo, nella leggenda
che descrive le sue origini; se troviamo forme e tradizioni romane nel primo
cronista che descrive la prima grossa guerra, che fecero i Fiorentini, sempre a
difesa del loro commercio, sempre contro i nobili feudali, ci deve esser lecito
di concludere, che nelle sue mura stava il sangue romano di fronte agli avanzi
delle tradizioni e del sangue germanico, raccolto nei castelli che
l'accerchiavano, e che ritardarono la sua indipendenza. Ritardandola, non
impedirono però l'incremento delle sue forze industriali, commerciali,
militari, e così fu che quando morì la contessa Matilde, Firenze era già di
fatto un Comune indipendente, sebbene tal non fosse ancora legalmente. E dopo
ciò facilmente capiremo che, quando molti non vogliono in nessun modo
persuadersi che la cosa sia così semplice, e vanno cercando astruse spiegazioni
con grande dottrina, questa assai spesso serve solo a rendere difficili fatti
che per sè stessi sarebbero assai facili.
VII.
Ma qui occorre
un'altra osservazione. Se questi concetti sono giusti, se veramente il Comune
fiorentino è nato in tal modo, dovrebbe avverarsi quello che noi accennavamo
sin dal principio, cioè che qualche luce essi dovrebbero gettare sugli
avvenimenti posteriori, e ciò varrebbe anche a confermare la verità di quanto
abbiam detto fin qui. Vediamo dunque se gli avvenimenti posteriori confermano
le considerazioni finora esposte.
Se noi apriamo
il Villani, troviamo che il primo periodo della storia fiorentina è una serie
di guerre continue contro i castelli. Il territorio era tutto incastellato, esso dice, ed i Fiorentini
uscivano ogni primavera a combattere. Quale fu la conseguenza di queste guerre?
I castelli vennero demoliti; ma i conti che li abitavano non si potevano
uccidere; venivano quindi costretti a vivere in Città almeno una parte
dell'anno, il che li sottoponeva alle leggi del Comune. Tutto ciò in sul
principio non ebbe grande importanza; ma a poco a poco alterò la cittadinanza
fiorentina, introducendovi un elemento feudale, che era nuovo, estraneo al
Comune, ed aveva un'origine germanica, rappresentava una società nemica. Così
dentro le mura si troveranno ben presto due società avverse, che non potranno
vivere insieme: l'una dovrà distruggere l'altra; la guerra civile sarà
inevitabile. Questi nobili hanno usi e costumi, tradizioni, educazione diversa
assai da quella del popolo. Essi vengono, si asserragliano, si fortificano nei
loro palazzi, che sono come castelli dal contado portati dentro la Città. Le
stesse ragioni che costrinsero i Fiorentini a combattere i castelli nel
contado, li costringeranno a combattere i nuovi palazzi fortificati, che
sorgono dentro le mura. La guerra civile non ha origine dal fatto del
Buondelmonti; non è conseguenza di odii e vendette personali; è una guerra
fatale fra due razze, fra due civiltà, una delle quali non può vivere insieme
con l'altra: bisogna che l'una o l'altra scomparisca dalla terra. Questa guerra
non è una prova che le passioni individuali dominassero tanto in Firenze da
prevalere su tutto; ma è invece una prova che i sentimenti di quegli artigiani
erano talmente uniti, concordi e tenaci e che essi avevano una fede così
profonda nei loro destini, che si apparecchiavano a combattere dentro la Città,
quel nemico, che avevano combattuto fuori di essa.
Giovanni
Villani, il quale affermava che il fatto del Buondelmonti, nel 1215, aveva la
prima volta diviso la cittadinanza di Firenze, dimenticava di averci
precedentemente detto, che nel 1177 la guerra civile era già cominciata per
opera dei grandi, cioè degli Uberti, che combatterono sin d'allora il governo
consolare. Ciò prova che il fatto del Buondelmonti fu uno di quei tanti
episodii, che seguirono spesso in tutti i Comuni del Medio Evo, ma non ebbe una
vera importanza politica, perchè non fu causa, ma conseguenza della guerra
assai prima incominciata.
Noi abbiamo
dunque un secondo periodo nella storia di Firenze, il quale è una lunga serie
di guerre e rivoluzioni interne, che portano una serie di trasformazioni
sociali e politiche del Comune. Vediamo da una parte i nobili col Podestà alla
loro testa, dall'altra il popolo comandato dal suo Capitano. Scopo e fine di
questa lotta è la totale distruzione del partito aristocratico, il che seguì
nel 1293 con gli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella, i quali
esclusero affatto i Grandi da ogni partecipazione al governo. Tutte queste
rivoluzioni hanno di mira uno scopo costante, hanno un'origine comune, si
seguono con un ordine determinato. Non è il caso che domina la storia di
Firenze, è una legge storica, che risulta dai varii elementi, che costituirono
la società fiorentina nel Medio Evo.
Ma, finita che
fu la prima serie di rivoluzioni, con gli Ordinamenti di Giano della Bella, non
finiva perciò la guerra civile. Come i nobili del contado, demoliti che furono
i loro castelli, non scomparvero affatto, ma entrarono dentro la Città; così,
esclusi ora dal governo, non per questo scomparvero affatto, ma s'unirono ad
una parte del popolo, cioè ai capi delle principali Arti, e si formò il partito
delle Arti maggiori contro le minori, del popolo grasso contro il popolo
minuto. Questo rappresentava ora la democrazia già avanzata, quello che oggi diremmo
il partito radicale: era l'infima plebe, la quale non capiva, perchè essa, che
aveva preso parte alle guerre civili contro i nobili, alle battaglie contro i
castelli, dovesse rimanere esclusa dal governo. E quindi, se la prima guerra
civile era cominciata per escludere i nobili dal governo, la seconda non fu
fatta per escluderne il popolo grasso, ma perchè il popolo minuto voleva
insieme con esso avervi la sua parte. E come nel 1293 vedemmo l'ultima
conseguenza logica del primo periodo, così nel 1378, col tumulto dei Ciompi,
abbiamo l'ultima conseguenza logica del secondo, ed il popolo minuto sale
finalmente anch'esso al governo, rimanendo in continuo contrasto coi ricchi. La
plebe sin dal principio eccedette nei suoi trionfi, ed allora comparvero sulla
scena i Medici, i quali, appoggiandosi ad essa, con accortezza impareggiabile,
s'impadronirono del governo. E così la Repubblica, dopo quasi un altro secolo
di lotte, finalmente cadde.
Questa storia
fiorentina, adunque, non è un mistero, non è una serie di rivoluzioni
sottoposte al caso; essa è invece chiara come una proposizione geometrica. Le
sue rivoluzioni hanno una causa costante; il suo scopo politico è sempre lo
stesso. Dal giorno in cui il Comune ha messo la prima pietra, noi possiamo, se
studiamo quali sono gli elementi che lo compongono, determinare logicamente,
prevedere sicuramente quali saranno le rivoluzioni, cui esso anderà soggetto.
Sotto i Medici noi troviamo che sono scomparse le Consorterie, la cui
distruzione era in fatti cominciata sin dal 1293. Troviamo che le Arti ancora
esistono, ma hanno perduto ogni importanza politica; vediamo un governo forte,
accentrato; una società che par quasi una società moderna. Una grande
uguaglianza civile apparisce per tutto; non più classi, nè gruppi separati ed
ostili; non titoli di nobiltà; non privilegi di alcuna sorte; dagli ultimi si
può salire, a forza d'ingegno, ai supremi gradi sociali. Sotto un tale aspetto
può dirsi che il Comune abbia raggiunto il fine cui aveva sempre mirato, abbia
ottenuto un vero trionfo.
VIII.
Ma questa, pur
troppo, è un'ora funesta per lo spirito italiano; è l'ora in cui incominciano
la nostra corruzione e la nostra decadenza. La società del Medio Evo più non
esiste. Quelle associazioni a cui gli uomini erano stati così affezionati, fra
le quali avevano vissuto, per le quali avevano combattuto ed erano morti, si
sono disciolte; ma la nazione non si è ancora formata. La piccola patria più
non esiste, la nuova ancora non si è formata. L'uomo del Medio Evo è scomparso,
e l'uomo moderno è nato, l'uomo, cioè, che deve fidare nelle sole sue forze,
nel solo suo ingegno, nella sola sua operosità; ma esso è nato prima che si sia
costituita la nazione. La conseguenza è che l'Italiano di questo nuovo periodo,
che si chiama il Rinascimento, si trova come ad un tratto isolato nel mondo.
Egli non può fidare in altri che in sè stesso, egli non ha nessuno per cui
vivere, nè c'è alcuno che viva per lui. Egli si abbandona quindi al suo egoismo
personale, nel momento stesso in cui si aumentano, si acuiscono le forze della
sua attività e del suo ingegno. La decadenza morale incomincia quando il
progresso intellettuale continua più rapido che mai. E noi abbiamo un popolo,
in cui la cultura progredisce, in cui la scienza s'innalza, ma nel quale il
livello morale continuamente, rapidamente si abbassa. La nostra splendida
letteratura rivela anch'essa questa morale decadenza. Noi vediamo apparire
sulle labbra dell'Italiano quel cinico sorriso, che ci è così spesso descritto
nelle nostre commedie, nelle nostre novelle, in cui si beffeggiano le cose più
sante, e l'amore è privo d'ogni sentimento davvero umano, e tutti gli affetti
più nobili sono scomparsi, quando non sono derisi. Lo scrittore somiglia allora
a quei romanzieri moderni, i quali, descrivendo il demi-monde, credono di descrivere il mondo. E noi vediamo quegli
accorti politici italiani, che sono i maestri di tutti in Europa, che
rappresentano la sapienza diplomatica, che dovunque vanno sono ammirati, non
riescire in casa loro ad altro, che a costruire un mondo, il quale cade sotto
il peso della sua stessa corruzione. Vediamo questi uomini, che sono i primi
calcolatori del mondo, calcolar sempre e sbagliare tutti i loro calcoli, perchè
essi hanno dimenticato che nella vita umana v'è qualche cosa che non si pesa e
non si misura, che non si ragiona e non si calcola, ma si sente, ed essi non la
sentivano più. I tiranni italiani di quel tempo ci presentano anch'essi un
singolare spettacolo. Noi li vediamo apparecchiare i loro veleni, affilare i loro
pugnali, ridere di Dio, e tremare dinanzi all'astrologo, da cui aspettano di
conoscere l'ora propizia ai loro delitti.
La storia, o
Signori, non è una filosofia, non è una predica morale, non fa che constatare i
fatti. Ma percorretela in lungo ed in largo, ed essa vi ripeterà di continuo,
che l'egoismo veramente, profondamente umano, è l'abnegazione; che ciò che solo
può rendere l'uomo felice sulla terra, è il vivere per gli altri; che quando le
leggi e le istituzioni ci spingono per questa via a cercare un ideale, cui far
sacrifizio della nostra esistenza, e dal quale solamente la vita può ricevere
il suo valore e la sua dignità, quello è il momento in cui il carattere morale
s'innalza e le nazioni diventano forti. Quando invece gli uomini si rinchiudono,
come gli Italiani del Rinascimento, nel proprio egoismo, la decadenza diventa
allora inevitabile.
Ma vi è ancora
un'ultima osservazione. Gli stranieri, i quali si sono mossi a studiare il
Rinascimento, hanno detto: Ecco una nazione, la quale, nel momento in cui più
le sue arti e le sue lettere fioriscono, nel momento in cui le più nobili
qualità del suo ingegno si manifestano, si corrompe sempre più rapidamente;
ecco una nazione che cinicamente ride sempre di tutto, una nazione che, allora
quando più fiorisce intellettualmente, è priva di ogni fede. Quelle idee
stesse, che saran sempre sua gloria, che essa mise nel mondo con la sua arte,
la sua letteratura, la sua scienza, percorrono l'Europa, e ne fecondano la
civiltà, perchè vi trovano un'atmosfera morale; ma in Italia non riescono ad
impedire la sua decadenza, perchè in essa il senso morale è pervertito. E ne
hanno concluso, che, quasi per legge di natura, nel nostro carattere nazionale
risplendono l'ingegno e tutte le qualità intellettuali, ma sono invece
offuscate le morali. Manca la vera intimità,
come essi dicono, del cuore, dell'animo. E però anche nella loro arte
gl'Italiani vedono più la forma che la sostanza, più il sensibile che
l'intelligibile e l'ideale. Quando si vogliono davvero penetrare i misteri
dell'anima, rappresentare la profondità, la santità degli umani sentimenti,
occorre rivolgersi alle nazioni germaniche, che vi riescono assai meglio,
perchè questo è il loro proprio regno, nel quale agl'Italiani non è dato
entrare. Uno storico tedesco di grandissimo valore, che meglio d'ogni altro
conosce il nostro Rinascimento, il Burckhardt, a questo proposito, osservava:
Ma se fosse proprio vero che il carattere degl'Italiani fu quale voi lo
descrivete; se non fossero allora vissuti altri che i Borgia, gli Sforza, i
Malatesta, e i più corrotti novellieri avessero davvero rappresentato tutto
l'essere morale della nazione, questa sarebbe caduta in un tale abisso da non
poterne mai più risorgere in eterno. Il vostro giudizio deve certamente avere qualche
cosa di unilaterale, di erroneo. È meglio lasciare in pace i popoli, quando non
si è in grado di giudicarli serenamente, sicuramente.
Ed invero
queste condanne nazionali, che pretendono essere giudizii imparziali,
dimenticano prima di tutto, che la storia del pensiero italiano cominciò allora
con Dante e si chiuse con Michelangelo, le due intelligenze, cioè, che hanno in
supremo grado quelle qualità appunto che si vorrebbero a noi negare; hanno
tutta quella così detta intimità,
tutto quel carattere epico, tragico, che nello spirito italiano dovrebbe
assolutamente mancare, perchè manca nel Rinascimento. Dante e Michelangelo, si
disse, furono due eccezioni. Certo i sommi ingegni sono eccezioni; ma sono pur
quelli che meglio rappresentano il paese che li produce. E dimenticano ancora,
che la storia da noi conosciuta, da noi studiata si occupa quasi sempre di quei
soli ordini sociali che, nel Rinascimento italiano, furono primi a sentire
l'azione corruttrice dell'atmosfera politica mutata, e che perciò più rapidamente
si erano corrotti, avendo subito preso parte al nuovo vivere sociale. Che se
quegli scrittori avessero voluto studiare davvero quali erano allora le
condizioni dello spirito italiano, avrebbero dovuto esaminare anche gli ordini
inferiori della società, nei quali, in tutti i tempi, le vecchie tradizioni si
mantengono più lungamente, e vedere quali sentimenti, quali caratteri erano in
essi. Avrebbero allora modificato i proprii giudizii. Una prova sicura di
quanto diciamo si ebbe recentemente in due libri, che furono pubblicati dal
compianto Cesare Guasti, e sono gli epistolarii d'un oscuro notaio fiorentino e
di una gentildonna, che non aveva molta coltura. Ebbene, leggendo tali lettere
(quelle del notaio Mazzei sono della fine del XIV secolo e dei primi del XV;
quelle della Macinghi Strozzi, sono della fine del secolo XV), leggendole, ci
par di tornare quasi due secoli indietro. Noi ritroviamo in esse ancora vivi
tutti quei più puri sentimenti morali, che ricordano i tempi in cui la
Repubblica veniva fondata, quando Firenze viveva sobria e pudica, e possiamo
non solo scoprire un altro lato della società di quel tempo, ma vedere anche
quali furono veramente gli uomini che fondarono la libertà, quali i loro animi
quando essi crearono quelle grandi istituzioni, che i politici e letterati del
Rinascimento cominciavano a disfare. Chi vuole accuratamente conoscere il
Rinascimento e l'opera sua, per cavarne giudizii generali sull'indole del
popolo italiano, dovrebbe pur distinguere ciò che in esso sopravvive del
passato, e dà ancora frutti di cui il solo Rinascimento sarebbe stato incapace.
Nel popolo, negli ordini inferiori della società, questo passato sopravvive
sempre più tenacemente, e si può meglio studiarlo. Anche ai nostri giorni si
ritrovano qualche volta gli avanzi di un passato assai lontano, che non
dobbiamo trascurare nelle società moderne, se vogliamo conoscere bene il tempo
in cui viviamo. A giudicarla tutta, la società bisogna esaminarla da tutti i
lati.
Certo quando
noi guardiamo in Firenze il Duomo, il Palazzo Vecchio e gli altri monumenti che
gli stranieri tanto ammirano e tanto studiano, dobbiamo ammirarli anche noi.
Ma, sebbene assai pochi vi pensino, non meno ammirabile è la condizione in cui
la Repubblica fiorentina lasciò le campagne della Toscana, non per le amene
colline, non per le ricche messi, ma per l'armonia sociale che vi regna, per le
condizioni economiche in cui l'antica Repubblica pose il contadino. Nel 1289 i
Fiorentini fecero una legge, la quale, con un linguaggio che sembra quello
stesso dell'Assemblea Costituente in Francia, dichiarava che la libertà è
sacra, inalienabile, che è voluta da Dio, è necessaria alla prosperità di tutto
il popolo, e liberava perciò i contadini da ogni servitù. E sono questi i tempi
medesimi, in cui s'iniziava quel contratto agrario che fino ai nostri giorni fu
tanto ammirato, che il nobile animo del Sismondi chiamava uno dei grandi
monumenti della sapienza civile degl'Italiani, che gli economisti moderni
dichiarano uno dei mezzi più efficaci a liberare la società moderna dal
pericolo sociale d'un conflitto di classi, da cui essa sembra minacciata. E
questo fu fatto dai Fiorentini nel Medio Evo, quando il dominio della società
spettava alla forza, e per tutto regnavano persecuzione e violenza. Fu quello
il tempo in cui nell'Italia centrale venne trovata quella forma di contratto,
secondo la quale il coltivatore della terra poteva, allora come ora, dire al
proprietario: Tu sei il lavoro accumulato dei secoli, io sono il lavoro
vivente. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, diamoci dunque amica la mano, e
siamo soci. Così si chiamarono allora, e così si chiamano oggi. E allora come
ora, o Signori, il lavoratore dei campi, il quale col sudore della sua fronte
feconda la terra italiana, che produce quella ricchezza, che è tanta parte
della prosperità nazionale, poteva tornare a casa tranquillo la sera, e godere
anch'esso le gioie della famiglia, e sentirsi uomo come noi, e crescere con la
sua la nostra felicità. E questo fu fatto dai Fiorentini quando in Inghilterra,
in Germania, in Francia i contadini erano schiavi, erano servi della gleba.
Quegl'Italiani che emanciparono l'uomo, che emanciparono il lavoro, dovevano
pure avere un alto sentimento morale.
Il marchese
Gino Capponi, l'illustre autore della Storia di Firenze, soleva dire che i
Fiorentini non avevano mai così bene impiegato il loro denaro, come quando
costruirono quel Duomo, che richiamò nella Città tanta gente ad ammirarlo. Ma
si potrebbe aggiungere, che essi non furono mai così profondi calcolatori, come
quando liberarono i coltivatori della terra, in un tempo nel quale erano
schiavi da per tutto. E calcolarono non solo a vantaggio della loro prosperità
economica, ma io credo che calcolassero anche a vantaggio della loro prosperità
intellettuale e morale. Forse anzi in ciò sta una non ultima ragione del perchè
tanto le lettere e le arti progredirono allora in Firenze. Io non credo, o
Signori, che sia indifferente agli alti ingegni, i quali spingono sereno,
profondo, sicuro lo sguardo nella luce del vero, come l'aquila fissa intrepida
il suo occhio nel sole, non credo che sia inutile il non avere lo sguardo
turbato dalle ingiuste sofferenze di coloro che onestamente lavorano. Credo
invece, che giovi assai agli artisti ed ai poeti, i quali si sollevano nel
regno dell'arte; giovi, affinchè le creazioni della loro fantasia serbino tutta
la sacra purità dell'ideale, il serbare, con la mente serena, una coscienza non
tormentata da rimorsi. - Ma allora quelle immagini divine dei poeti, dei
pittori del Trecento e del Quattrocento, di cui parlammo, non ci appariranno
più come l'Angelo di Dante nella bolgia infernale, che traversa sdegnoso,
frettoloso la palude Stige. Esse non vengono di fuori, sono nate nella
coscienza stessa di questo popolo, nei giorni in cui difendeva la libertà e
rispettava la giustizia, sono come la sostanza stessa della sua anima. E così,
o Signori, voi vedete, io spero, come lo studio delle origini possa gettare una
qualche luce o rischiarare anche i fatti della storia posteriore del Comune e
della società italiana.
VENEZIA
E LE REPUBBLICHE MARINARE
DI
P. G. Molmenti
Signore e Signori,
E dove a chi
potrei oggi meglio parlare di Venezia, se non a voi qui in Firenze, in Firenze
così legata alla città delle lagune anche da recenti prove d'affetto? Voi la
conoscete, ma è sempre curioso il ricordarla la storia di codeste genti
veneziane, che non aspettano la loro fortuna, come limosina dal caso, ma la
conquistano colla prodezza e l'accorgimento: si fanno innanzi tra la larva
d'impero dei Cesari bizantini e i rinnovantisi invasori stranieri, divengono
signori di grandi traffichi e conquistatori di vaste provincie, fiaccano
l'orgoglio dei maggiorenti e abbassano l'insolenza del popolo, piantano il
vessillo repubblicano sulle torri del palazzo imperiale di Bisanzio, divengono
i guardiani d'Italia contro gl'infedeli della religione e gli infedeli della
libertà; non s'abbassano mai nè anche quando li stringe da presso il nemico:
passano, a traverso la storia, eroi talvolta, talvolta uomini pratici,
guerrieri e mercanti, statisti e poeti, accorti sempre, sempre ammirabili. Di
questa grandezza, paragonabile nell'antichità alla romana, nel tempo presente
all'inglese, io vi accennerò, o signori, alle umili origini, non toccando delle
altre gloriose repubbliche marinare d'Italia se non per ciò che con Venezia ha
rapporto.
Quella regione,
da una parte racchiusa dall'Adige e dal Timavo, dall'altra lambita dalla curva
settentrionale del golfo Adriatico e difesa dalle Alpi tirolesi e carintie, era
conosciuta dai Romani col nome di Veneto. Le origini degli abitanti si
collegavano ad Ilio, secondo una tradizione non del tutto creata dalla boria
nazionale, ma ravvalorata dai versi dell'Eneide (I, 246). Eneti viene dal greco e vuol dire laudabiles, ma ai veneti cronachisti la nobiltà del cuore non basta
e trovano che la voce enetici viene
da Enea.
La regione era
lieta di città popolose e fiorenti: Padova, Aquilea, Altino, Verona; di paesi
ferventi di vita: Ateste, Monselice, Concordia, Treviso, Vicenza, Oderzo,
Belluno, Ceneda, Acelo (Asolo). Collocati alle porte orientali d'Italia, caddero
primi, nel V secolo, sotto l'impeto delle turbe barbariche, che diruparono
dalle Alpi. Gli abitanti, dinanzi a quelle disperate catastrofi, cercarono
rifugio là dove le acque dei fiumi dell'Italia superiore, giungendo al mare si
fermano, stagnano, si dilatano in lagune. Nulla però in esse d'insalubre. Il
Lido, stretta lingua di terra, che separa dal mare la laguna, è rotto in varie
aperture, in vari porti, che lasciano libero il corso delle acque. Il flusso
marino, che ora copre or lascia a secco quei fondi melmosi, porta via ogni
germe mefitico. Nulla di triste. Il cielo, che non splende del troppo vivo
fulgore meridionale e non ha la fredda vaporosità del settentrione, si
rispecchia nelle acque con quei magici riflessi, con quella smorzatura di toni,
con quelle armonie di tinte, che educarono l'occhio dei pittori veneziani.
Erano isole, se non deliziose e frequenti, come alcuni sognarono, non
abbandonate e squallide, come credettero altri, e abitate e conosciute dai
naviganti del tempo romano. Si può arguir ciò da alcuni passi che a quelle
isole si riferiscono in Mela, in Tacito, in Plinio, nell'Itinerario di Antonino, in Erodiano. I due limiti estremi della
regione insulare, non esposta all'ira degli invasori, cui mancava il navilio,
erano, da una parte Grado, dall'altra, Capo d'Argine.
Chi dirigeva
quei profughi, chi li guidava? Poetiche leggende ci sono tramandate da una
vecchia cronaca, chiamata Altinate, perchè uno degli aneddoti in essa contenuti
e scritti anche prima del secolo X, si riferisce ad Altino, città prospera per
commercio, magnifica per edifici, fra i quali un palazzo imperiale, e per
l'amenità delle ville, degne di rivaleggiare con quelle di Baja, a quanto
afferma Marziale:
Æmula Bajanis Altini litora
villis.
I primi
cronachisti veneti illuminano di luce poetica e religiosa le antiche dimore dei
loro padri. Tutti i grandi popoli, dalla Grecia e da Roma a Venezia, hanno
carezzata la loro origine leggendaria, e più da essa si sono allontanati,
grandeggiando, più si compiacquero non a collegarsi con umili e rozze origini
storiche, sinceramente esplorate, ma con quel vago e indefinito della leggenda,
che ritrova anche nei primi albori della vita la grandezza. Così le città
greche rannodarono le antiche origini con gl'Iddii. Narra la cronaca d'Altino
come agli Altinati e agli Aquileiesi Iddio abbia manifestata l'imminente venuta
degli Unni. Ciò avveniva nel 452, e si sa come siano intimamente collegate
l'origine di Venezia e la leggenda di Attila, intorno alla quale si raccolse
ogni ricordanza di distruzione, di sangue, di stragi. Gli uccelli nidificanti
nelle mura e sulle torri di Altino fuggirono portando nei becchi i loro nati.
Non sapendo una parte di cittadini dove trovare uno scampo, dopo un digiuno di
tre giorni pregarono Iddio di manifestar loro se dovessero affidarsi alla terra
o alle navi. Si udì una voce: Ascendete
sulla torre e guardate verso la parte
australe. Molti montarono sulla torre e videro in vicinanza alcune isole, e
per tali figure s'intese che doveasi andar là ad abitare. Un terzo circa di
cittadini, preceduti dai tribuni e dal clero, si diresse con barche alle lagune
e fondò la celebre Torcello. Due sacerdoti, Geminiano e Mauro, incuoravano i
fuggitivi e gli spiriti atterriti si commovevano, si sublimavano nelle visioni
dell'infinito. Appariva allora a Mauro una bianca nube, dalla quale, insieme
con due raggi di sole, scendea la voce di Dio, che imponeva di innalzare in
quel luogo una chiesa. Alla voce di Maria, che dava, in altro sito, lo stesso
comando, seguiva un prodigioso miraggio: le bianche nubi si squarciarono e
lasciarono vedere lidi fiorenti, pieni di popolo e di gregge.
Altri Altinati
andarono ad abitare Amoriana o Murano.
Una cronaca, di
poco posteriore all'Altinate, quella di Grado, narra che il patriarca Paolo,
ritornando coi profughi all'antica patria, Aquileia, ebbe una visione, dalla
quale apprese come la sævissima
longobardorum rabies avesse distrutto quella città. Egli allora si ritirò a
Grado, divenuta poi la più ricca fra le isole veneziane e la sede principale
della potestà ecclesiastica.
Eraclea,
popolata essa pure da Aquileiesi e dal fiore degli Opitergini, fu sede del
governo.
I profughi di
Asolo e di Feltre ripararono a Jesolo, più tardi chiamata Equilio, per le razze
dei cavalli, che vi si allevavano.
Gli scampati
dalla distruzione di Padova si ridussero a Matemauco, l'odierno Malamocco.
Il popolo di
Concordia cercò riparo nell'isola, dalle capre che vi condussero i pastori,
chiamata Oaprule ed oggi Caorle.
Vissero tutte
la fulgida vita della giocondità e della ricchezza. Ora, dove esse sorgevano,
si è fatto un triste deserto. Qua e là qualche rudero; eco romita dei vecchi
secoli. Vi regnano lo squallore e la malaria.
Esiste ancora
in tutta la suprema bellezza dell'arte e delle memorie, Rivoalto, la più
modesta di tutte le isole, che a poco a poco unita ad Olivolo, indi a Luprio e
finalmente alle Gemine e a Dorsoduro, formò l'odierna Venezia.
L'operosità
rinvigorita della sventura e la forza raddoppiata dagli ostacoli animano quella
moltitudine di persone, varie di condizioni, di costumi, di sesso, di età, e
cento anni circa dopo la distruzione di Attila, i nuovi abitatori delle isole
sono descritti con vivi colori da Cassiodoro, in una lettera magniloquente ai tribuni marittimi delle lagune, probabilmente
ufficiali inferiori goti, ai quali il ministro, a nome regio, ordina di
preparare le navi per trasportare dall'Istria a Ravenna il vino e l'olio.
Provveduti di
navilio, arditi sfidano le tempeste del mare e le correnti dei fiumi: erigono
case, come nidi d'uccelli marini; collegano la terra con fascine e dighe:
ammucchiano sabbia per rompere le onde infuriate: convivono in eguaglianza
poveri e ricchi; non invidia, non vizî li macchiano; ogni loro emulazione sta
nel lavoro delle saline, da cui nasce il frutto al quale ogni produzione è
soggetta e che dell'oro è assai più prezioso.
Nessuna
descrizione più attraente, quantunque il ministro di Teodorico fosse disposto
ad abbellire il quadro, oltre che dall'indole sua, anche dal bisogno che aveva
il suo sovrano di trasportar vettovaglie coi navigli di quei Veneti, i quali
del resto riconoscevano nei conquistatori goti l'alto dominio sulle isole.
Tuttavia in
questo primo accenno storico, quel popolo risorgente dallo squallore dei bassi
tempi alla luce di un'êra novella, si rianima. Noi la vediamo la tranquilla
verdura di quelle isolette, specchiantisi nel nitido specchio delle lagune.
Oltre alle paludi giuncose, l'occhio si posa sul mare romoreggiante. Qui la
pace inconturbata potea destare negli esuli il rimpianto e le memorie delle
città disparite, gli splendori distrutti e i tristi albori della nuova patria;
là, il furiar delle tempeste e il romoreggiar delle onde rendeano l'imagine dei
tumulti della esistenza, di lotte, di pericoli, di gloria. Ma le tranquille
melanconie dell'asilo non cullarono quelle anime, da tanti dolori agitate, in
una pace mesta. Essi allungarono lo sguardo, oltre le paludi, sul verde
Adriatico, e di esso sfidarono le lotte e i pericoli e in esso cercarono la
gloria. - Lotta e gloria - ecco il grido anche dei secoli venturi. L'energia di
quegli uomini si eleva ad eguale misura delle difficoltà e degli ostacoli
naturali: la loro vita tutta si riassume nello scontrar pericoli, domarli,
trionfare; una stessa passione li agita, li comanda, li possiede.
Alla vita
frugale e laboriosa seguono più prospere condizioni. S'interrano dossi
paludosi: ogni prominenza di sabbia, ogni più breve isoletta è abitata; si
regolano i canali tortuosi, si preparano approdi e ripari alle barche, si
arginano saline, si elevano mulini, si scavano cisterne, si riducono prati, si
piantano vigne. Ma anche nel sicuro asilo della laguna giunge l'eco di
battaglie e di stragi, di ribellioni e di lotte. Nella Venezia continentale, da
prima si agitano guerre fra Ostrogoti e Bizantini, fra Bizantini e Franchi e
Longobardi: poi lotte dei patriarchi di Aquileia e Grado e dei vescovi veneti
ora coi Longobardi, or coi Bizantini, e controversie fra il papa e i patriarchi
e i vescovi. In breve la pace incominciò a turbarsi anche nella Venezia
marittima.
La prima
costituzione politica, il reggimento dei tribuni marittimi, fu imitato dai
Bizantini, sotto la sudditanza dei quali, sciolti ormai dalla gotica, passarono
i Veneti. Confermano ciò, tra le fonti più antiche, la Storia gotica di Procopio, le inscrizioni di Grado del secolo VI,
edite dal Filiasi e dal Mommsen, la Storia
dei Longobardi di Paolo Diacono e gli Annali
del franco Eginardo. Allorchè i Bizantini perdettero le città più importanti
della Venezia terrestre e ritirarono anche dalle isole i loro eserciti, gli
abitanti, non più soggetti a un dominio immediato, elessero un libero
reggimento militare di tribuni.
Cessati i
pericoli e la pietà e i ricordi delle comuni sventure, incominciarono le
rivalità fra le isole, più o meno importanti, fra i tribuni maggiori e minori;
poi sorsero contese sui confini o sulla proprietà delle terre coi Longobardi
vicini, si sentì necessario creare nelle isole un capo unico, un duce, che il
popolo, col suo liquido eloquio, chiamò doxe,
titolo ritenuto poi sempre e con lievi mutamenti anche nella lingua e nelle
relazioni internazionali. Al nuovo capo, eletto a vita, podestà quasi da
sovrano, ricchezza di redditi e di insegne, pari alla dignità, spada, scettro e
corona; ei giudice di liti e datore di ecclesiastici benefici: a lui il popolo
richiedeva perfino la benedizione nelle adunanze solenni. Tuttavia le cause
importanti dovevano essere trattate nell'assemblea generale e non già dal doge
come sovrano assoluto.
Il primo Doge,
Paoluccio Anafesto, con l'assenso o almeno senza opposizione della Corte greca,
fu, nel 697, in un'assemblea del clero, dei tribuni e dei più notabili
cittadini, eletto in Eraclea.
Paoluccio
strinse coi vicini Longobardi un patto, il primo, di cui si abbia memoria nelle
storie veneziane, che determinò i confini dei due Stati e le ragioni
scambievoli dei commerci.
In Eraclea, la
vita ci si presenta assai diversa da quella descritta con idillica poesia da
Cassiodoro. Abbiamo accennato come le varie isole dell'estuario fossero asilo
agli abitanti delle desolate città di Altino, di Aquileia, di Padova, di
Oderzo, di Concordia, di Vicenza. Ma una buona parte di quei fuggitivi s'erano
riparati in luoghi, dipendenti anche prima del loro municipio, come Grado, ad
esempio, che aveva fatto parte della dizione aquileiese: altri invece erano
venuti ad occupar terre, sulle quali i padri loro non aveano mai avuto alcun
diritto. Nei primi tempi, la sventura comune non avea lasciato luogo a
discutere i diritti di ciascheduno, e poveri e ricchi, come dice Cassiodoro,
conviveano colà in eguaglianza. Ma quando tacque il timore dei barbari, sorsero
gelosie e contrasti di elementi diversi, tendenti a soverchiarsi a vicenda. Le
ire interne, rinfocolate ora dai Greci, ora dai vicini dominatori della terraferma,
diedero origine alle due parti veneto-greca e veneto-italica. Di qui torbidi
mutamenti di governo. Non più il doge, ma l'annuo governo dei maestri dei
militi. Dopo poco si ritornò ai dogi e per togliere ogni gelosia si trasferì la
capitale a Malamocco. Alle rivalità dei maggiorenti, alle gare delle due
opposte fazioni, s'aggiungeano le discordie e le vendette del popolo, il quale,
specie quando il doge tentava rendere dinastico il potere vitalizio,
associandosi quale il figlio, quale il fratello, si ribellava, uccideva,
incendiava. È un fiero delirar di battaglie e di stragi. Nel 717, Eraclea è
assalita e messa a fuoco dagli abitanti di Equilio, che danno morte al doge
Anafesto e a' suoi fidi. Nel 737 il doge Orso è ucciso a furore di popolo; nel 741,
il maestro dei militi Giovanni Fabriciaco è deposto e abbacinato; nel 755,
Galla si ribella al doge Diodato, lo imprigiona, lo accieca, e usurpa il ducato
per poco più d'un anno, trascorso il quale, il popolo insorge contro Galla e
gli appresta la stessa sorte, ch'egli avea procurata all'infelice antecessore.
Nel 764, i nobili macchinano le fila di una congiura, rompono in furibondo
partito, traboccan di seggio il doge Monegario e gli strappano gli occhi. Nel
801, circa, il doge Giovanni Galbaio, fautore dei Bizantini, manda il figlio a
Grado, con una divisione della flotta, per assassinarvi quel Patriarca, che
inchinava invece ai Franchi. Il figlio di Galbaio prende d'assalto la città,
imprigiona il Patriarca e lo fa precipitare dalla torre più alta del Castello.
Ma, dopo tre anni, il doge Galbaio e il figlio Maurizio debbono fuggir da
Venezia per non cader vittime di una congiura, ordita dal nipote dell'ucciso
patriarca di Grado. Il partito franco riacquista allora vigore ed è eletto doge
Obelerio. Così che non errava il Machiavelli affermando Venezia, forse più
d'ogni altro comune italiano dell'età di mezzo, aver provato il furore delle
fazioni.
Codeste
terribili agitazioni doveano metter capo all'invasione straniera. Ma Venezia,
destinata ad accogliere le fatidiche memorie del popolo italiano, escì salva
dalle turbolenze, che ne comprometteano la libertà e l'esistenza.
Obelerio,
appena eletto al dogato, era andato, insieme col fratello Beato, a Diedenhofen,
dove allora teneva corte l'imperatore Carlo, per rendere omaggio di sudditanza
ai principi franchi, che agognavano il dominio anche del veneto litorale. Ma
ritornato in patria, quando una flotta greca, sotto il comando di Niceta,
approdò alle isole, il doge infido, mutò intendimenti, accostandosi ai Greci.
Allora, il figlio di Carlo Magno, Pipino, con forte esercito e numerosa squadra
di legni, invase e distrusse gran parte del ducato veneziano, minacciando da
presso la capitale Malamocco. Nel supremo pericolo si accetta il consiglio del
nuovo doge Agnello Partecipazio, di rifugiarsi nella umile isoletta di Rialto,
ove erano le offese più pronte e le difese più sicure. Pipino, dice la
tradizione, vuol inseguire i fuggitivi: fa costruire con sassi e fascine un
argine, presso Rialto, e ordina ai suoi cavalieri di avanzarsi. Ma i cavalli
dei Franchi sulla strada malferma, s'impauriscono, balzano di qua e di là
nell'acqua, i Veneti piombano colle loro navi sui nemici sgominati e ne menano
tal strage, che a quelle acque rimase il nome di canale orfano per le famiglie franche private de' loro cari.
L'orgoglio nazionale ha abbellito coi colori della leggenda la vittoria dei
Veneti contro il primo usurpatore, che osasse mettere il piede sul sacro suolo
della patria. Le tenebre di questa età tempestosa son come solcate da un
bagliore dell'antica gloria. E certo, in mezzo alle lotte fratricide di quei
tempi, non ispirate se non all'odio ed alla rapina, questa può anche dirsi la
prima vittoria italiana. E il nome sacro d'Italia, offuscato da tante
ignominie, era raccolto con tanta pietà sul lembo estremo della penisola,
nell'umile isoletta di Rialto. Ed era bene affidato.
Quella stessa
incomposta ardenza dovea, per fatalità storica, mettere capo a leggi di
moralità e di giustizia; quelle lotte erano pur segnale di molta ed esuberante
vita, e per questa via si dovea compire la legge del progresso veneziano.
Quando invece sull'alba della vita popolare il dispotismo di un tiranno mette
il suo volere in luogo della libertà popolana, la quale deve manifestarsi con
tutti i suoi errori e tutti i suoi eccessi, gitta i semi di rivoluzioni, che
scoppieranno più tardi e lascieranno turbamenti perenni. Così nella vita
dell'uomo: alle giovinezze agitate succede la seria virilità, laddove all'età
matura sono riservate le follie, che la gioventù non commise. La vita non
soffre violazioni.
A Rialto
comincia la città nobile e grande, con lei e per lei stanno la forza e
l'avvenire. Rialto, che si denominava così o da un fiumicello Prealto, o
dall'importanza del canale o rivo, divenne il centro della nuova potenza. In
essa la sede vescovile, il porto e i magistrati, officiales de Rivoalto. Per lungo tempo Rialto significò Venezia,
laddove il dogato, l'antico Stato da Grado a Capodargine si chiamò invece Venecia.
Della vittoria
su Pipino manca la certezza storica: certo è che il giovane re, disperando di
soggiogare i Veneti nel sicuro asilo di Rialto, fu costretto a ritirarsi. Da
questo momento cessa nei Franchi ogni idea di conquista su Venezia. Nel
definitivo accomodamento fra Carlo e l'imperatore d'Oriente, nei preliminari
della pace di Aquisgrana dell'810 e nella pace definitiva dell'812, Carlo
rinunzia esplicitamente ad ogni pretensione sulle isole della laguna,
riconosciuta come provincia dell'Impero d'Oriente. Col trasferire la sede del
governo in Rialto non si era voluto soltanto provvedere alla sicurezza dello
Stato, ma s'era anche obbedito all'alto concetto di raccogliere e fondere in
luogo senza anteriore importanza, gli elementi migliori di varia origine,
dispersi per l'estuario. La prima capitale Eraclea avea rappresentato il
predominio greco, poi Malamocco la tendenza verso i Franchi. Rialto significava
l'indipendenza, la patria libera da ogni influsso straniero. E si sentì fin
dalle prime che la nuova patria era stabile e sicura. Bisanzio, è vero,
esercitava ancora una azione su Venezia: i dogi cercavano sempre a quella corte
dignità e uffizî, troppe erano ancora le relazioni scambievoli, troppi
gl'interessi della vita veneziana, maturata al caldo sole d'Oriente. Ma non era
più che un'azione di nome. Che poteva aver di comune, quale autorità esercitare
un Impero, nato nella mollezza, fra le ambizioni delle donne e le basse
adulazioni dei cortigiani, fra le lusinghe e le menzogne, e volgente alla fine,
svigorito dalla decrepitezza, con un popolo fiorente di gioventù, ricco di
giovanile baldanza? La vigorìa e la gioventù non furono contaminate dalla
vecchiezza e dal vizio.
Venezia passa
dall'adolescenza alla giovinezza robusta. Gli stessi scompigli dei primi tempi
fanno prova di eccesso di vigoria, della necessità di azione; di quella
inquietudine che cerca trar fuori l'ordine dalla confusione delle cose. Agnello
Partecipazio (811), primo doge in Rialto, assoda lo Stato, abbellisce la nuova
sede, unisce con ponti i sessanta o settanta dossi che formano la nuova città,
bonifica i terreni paludosi, crea un magistrato per assicurare i lidi
dall'impeto delle acque. Anche qui il primo pensiero è rivolto a Dio, anche qui
intorno alle chiese, quasi a cercare la solenne protezione del cielo, si
fabbricano le case. E le chiese non sono già, come nei primi tempi di tavola e
di canne, fabricæ lignæ, ma si
costruiscono di pietra e si abbelliscono di marmi e colonne. Giustiniano,
figlio di Agnello Partecipazio e collega nel dogato al padre, fra l'813 e
l'820, fondava per incarico dell'imperatore bizantino Leone, un monastero di
donne dedicato a san Zaccaria. L'imperatore mandò da Costantinopoli alcuni
architetti, perchè l'opera fosse condotta a termine il più presto possibile. E,
circa nello stesso tempo, il doge Agnello gettava le fondamenta di quel
palazzo, che dovea servir di dimora ai reggitori del più gagliardo Stato
d'Europa. Ma per mostrare come legami di sudditanza non esistessero più col
decrepito impero di Costantinopoli, la nuova libertà è posta non più sotto il
protettorato dell'antico patrono greco Teodoro, ma di un Santo, congiunto ai
sentimenti e alle aspirazioni nazionali. Narrava una leggenda che l'evangelista
Marco nel suo viaggio da Alessandria ad Aquilea, colto da una bufera, era stato
gettato sulle isole realtine, ove un angelo gli era apparso salutandolo: Pax tibi, Marce, Evangelista meus. E in
suo fatidico accento, il messo di Dio gli annunziava che là fra quelle isole,
chiamate un giorno a meravigliosa prosperità, avrebbero trovato pace le sue
ossa.
La leggenda
servì mirabilmente a quella specie di misticismo ufficiale, che, come ben fu
detto, nessuno Stato ebbe in grado maggiore di Venezia. Tutto ciò che si
riferisce all'innalzamento del tempio, dove, secondo l'angelica previsione,
dovea trovar riposo il corpo dell'Evangelista, è come avvolto da un'aura di
misteriosa poesia. Strano il modo con cui da Alessandria furono trasportati
nelle isole realtine i resti di san Marco. Due mercanti, Buono da Malamocco e
Rustico da Torcello, nell'828 approdavano ad Alessandria, dove i cristiani
erano perseguitati dai musulmani, che spogliavano di quanto contenevano di più
prezioso le chiese, per adornarne moschee. Anche il tempio dove era la tomba di
san Marco dovea essere distrutto. I due mercanti veneziani poterono ottenere
dai sacerdoti greci quelle sacre reliquie, e per sottrarle alle indagini dei
gabellieri musulmani, le coprirono di carni porcine, avute in orrore dagli
islamiti. Recata quindi la salma sulla nave, spiegarono al vento le vele,
approdarono alla patria, fra le festose accoglienze del doge e del popolo. La
santa reliquia fu riposta in palazzo ducale fin che si fondasse il tempio, in
omaggio del nuovo protettore.
Sotto Giovanni
Partecipazio, nella chiesa, ridotta a buon termine e adornata di colonne e
marmi finissimi, spoglie di vittorie sui Saraceni, si trasportò il corpo
dell'Evangelista, il cui nome fu invocato nelle sventure, nelle gioie, nelle
battaglie, nelle vittorie. E Venezia, che diverrà una delle prime potenze
denaresche d'Europa, quasi a bene augurare de' suoi commerci, stamperà il busto
nimbato di san Marco sulle sue monete; e l'animale simbolico dell'Evangelista
diverrà ben presto il segnacolo glorioso della repubblica, e nell'edifizio,
sacro e inviolato sepolcro del Santo, si svolgerà una serie di avvenimenti, nei
quali si riassume quanto v'ha di più glorioso nella veneta storia.
Se Venezia
potea dirsi indipendente dall'Impero bizantino, non avea, d'altra parte, più a
temere le forti razze del settentrione. Colla potenza Carolingia, minacciosa un
dì per la libertà veneziana, la giovane repubblica potea ora trattare da eguale
ad eguale. Lodovico II, nell'855, si reca insieme con l'imperatrice, insino a
Brondolo, presso Venezia, per onorar di una visita il doge Pietro Tradonico,
del quale tiene al fonte battesimale un nipote.
Ma, fra tanta
prosperità, le interne discordie non quetavano, anzi, tratto tratto,
prorompevano tremende, specie fra i maggiorenti. Le famiglie più illustri
vengono fra loro al sangue: i Giustiniani, i Basegi, i Polani da una parte; gli
Istoili, i Barbolani, i Selvo dall'altra. Lo stesso doge Pietro Tradonico è
trucidato, non già in tumulto di popolo, ma per mano di congiurati, i cui nomi
sono fra i più illustri di Venezia: Gradenigo, Candiano, Calabrisino, Faliero.
Nè men sinistra
quella luce di rivolte civili, che circonda la bieca figura di Pietro Candiano
IV, prima esigliato per l'indole fiera e turbolenta, poi con voltabile
giudizio, richiamato in patria ed eletto al dogato. Ma presto, lasciato veder
l'animo suo, prorompente ad ogni maniera di prepotenza, fu fatto nuovamente
segno alle ire di congiurati, che lo assalirono nel palazzo dove trovaron fiera
resistenza nelle soldatesche straniere, messe a guardia del doge. Allora
appiccarono il fuoco alle case vicine. Quando le fiamme minacciavano al palazzo
ducale, Candiano fuggì per l'atrio della chiesa di San Marco, insieme col
figlioletto ancora lattante. I congiurati lo scoprirono, s'avventarono su lui,
implorante la vita, almeno, pel figlio. Risposero col sangue. I corpi degli
uccisi, lasciati per ludibrio insepolti, furono raccolti e seppelliti da un
Giovanni Gradenigo, uomo pio, aborrente da quei furori.
Altre contese
sanguinose sorgono fra le due famiglie dei Morosini e dei Caloprini. Un
Morosini, mentre esce di chiesa, è trafitto da un Caloprino. I servi, percossi
d'orrore, non pensano a brandire le armi, ma raccolgono il ferito e lo
trasportano in un monastero, dove spira fra le lagrime e i propositi di
vendetta dei parenti colà riparati. I Caloprini fuggono, chiedono asilo alla
corte di Ottone II, che coglie tale pretesto per assediare Venezia da ogni
parte, perchè non le giungessero vettovaglie e dovesse arrendersi. Venezia
resiste e nel 983 si viene alla pace di Verona.
Più tardi, i
Caloprini per intercessione dell'imperatrice Adelaide, ottengono il perdono e
il ritorno in patria. Ma gli odî non sono spenti nei Morosini. Una sera, seduti
in una barca, tornavano dal palazzo ducale alle loro case, tre giovani
Caloprini, allorchè, d'improvviso, assaliti dai Morosini son trucidati con tal
furore da farne schizzare il sangue sulle rive vicine. I corpi sanguinosi dei
trafitti furono portati da un servitore fedele alla povera madre e alle vedove
mogli.
Strano tempo e
strane antitesi! L'odio a canto all'amore, la ferocia alla mitezza; e
sconsigliati impeti di plebe a canto a sottili e accorti provvedimenti; e qui
levarsi su nel limpido azzurro le bianche chiese e là intorbidar l'aria il fumo
degli incendi vendicatori; e dotar monasteri dopo esser corsi alla rapina; e
appendere a piè degli altari le spoglie dei nemici; e innalzar preci dopo
uccisioni e stragi. Ma sol che lo straniero minacciasse ed offendesse la
patria, le discordie tacevano e tutti insieme i cittadini correvano alle armi,
animati da un volere comune.
È di questo
tempo il celebre ratto delle spose veneziane, che ispirò la poesia e le arti. È
leggenda, è storia? I più vecchi cronachisti, l'Altinate e il diacono Giovanni,
vissuto tra il cadere del secolo X, Martino da Canale, che narrò nel XIII, non
ne parlano. Certo, a quell'avvenimento vero e leggendario si dee l'origine
d'una delle più pittoresche feste veneziane. Non la storia soltanto, anche la
fantasia ha i suoi diritti: e l'indagine fredda non ha potuto cancellare dalle
pagine della storia questa tradizione di coraggio e di valore. Era costume
veneto, l'adunarsi delle fidanzate nella chiesa di Olivolo, il dì secondo di
febbraio, perchè dal vescovo fossero le loro nozze benedette. Biancovestite,
coi capelli disciolti, ornate di molti gioielli, tenevano in mano una cassetta
(arcella), contenente la dote. I
pirati slavi approdarono di soppiatto in Olivolo, irruppero nella cattedrale,
rapirono le donne, gli uomini e, secondo alcuni, anche il vescovo e i preti, e
si diressero verso Caorle, a un porto, chiamato ancora delle donzelle, per dividersi le fanciulle e la preda. Ma i
Veneziani, rimessi dal primo sbigottimento, armarono in fretta alcune barche e
guidati dal doge, raggiunsero a Caorle i corsari, li assalirono, li sconfissero
e ritolsero loro le spose e il bottino. In memoria di questo avvenimento fu
instituita la festa così detta delle Marie. Singolarissima e fastosa. La
descrivono, tra altri, un documento del 1142 e la Cronaca di Martino da Canale.
Quei documenti parlano di ricche compagnie di damigelle portanti vassoi e fiale
d'argento, e precedute da trombettieri, di lunghe file di chierici vestiti di
sciamiti d'oro e di damasco. Insieme col doge si recavano tutti al tempio di
Santa Maria Formosa. Dodici fra le più belle e le più giovani donzelle, le
Marie, acconciate molto riccamente con drappi d'oro e corone di pietre
preziose, erano presentate al doge e festeggiate poi lungo il Canal grande. La
festa durava dal 25 gennaio al 2 febbraio, fra baldorie, regate e spettacoli
d'ogni maniera. Così una delle prime e più solenni feste civili dei Veneziani
fu un omaggio alla donna.
Meno gentile,
ma non meno singolare sarà la festa commemorante la vittoria sopra Ulrico
patriarca d'Aquileia. I Veneziani vittoriosi trassero prigione il patriarca con
dodici de' suoi canonici, avendoli,
dice Marin Sanudo, il principe dei veneti cronisti, a farli tajar la testa. Ma, ad istanza del papa, furono rimandati,
pur che il patriarca dovesse inviare ogni anno, nel giovedì grasso, un toro e
dodici maiali - simbolo di scherno del patriarca e de' suoi canonici - per
servir di spettacolo alla moltitudine. E la festa del Giovedì grasso, in cui si
uccidevano il toro e i maiali, si rinnovò ogni anno con grandi allegrezze e
matte baldorie.
Il sommo della
veneta potenza, nel periodo delle origini, fu raggiunto sotto il dogato di
Pietro Orseolo II. Ei ricondusse la quiete nella fervida città, aggrandì, non
impetuosamente, ma per gradi, lo Stato, riescì, col valore, colla sagacia,
colla costanza, ad accrescere e consolidare la propria potenza. La mente avea
fine ed aguzza nel trovare ingegni a tenersi bene in arcione tra il Cesare
bizantino e l'Imperatore tedesco. Trionfò dei pirati narentani, guerreggiò gli
Slavi, conquistò la signoria delle città marittime della Dalmazia, tramandando
ai successori il titolo di doge della Dalmazia, liberò l'Adriatico dai
Saraceni, che l'infestavano. A buon dritto potè il doge, in appresso,
commemorando tali conquiste, sposare il mare con la cerimonia più splendida di
tutte le feste veneziane. Nè le arti della pace erano trascurate dal gran doge.
Compì una parte della basilica di San Marco nel 1006, e quel turrito palazzo
ducale, dove ospitò l'imperatore Ottone III, che ammirò, a quel che ne dice il
diacono Giovanni, cappellano del doge Pietro, la bella e decorosa fabbrica.
Dopo un secolo, sotto Ordelafo Faliero, si gettavano le basi di quell'Arsenale,
che fu il più vasto d'Europa, e che ricordano tutti, più ancora che pei suoi
fasti, per la stupenda descrizione di Dante - tanta è la potenza dell'arte.
Nel secolo XI,
può dirsi veramente fondata la marittima signoria di Venezia, e l'Adriatico
incominciò da questo tempo a considerarsi come un lago della repubblica. La libertà e il vero spirito dell'antica
Roma qui continuavano in tutto il loro vigore. Questo giudizio non è di
qualche storico piaggiatore, ma d'una delle anime più nobilmente fiere, che
sieno mai passate pel mondo: Ildebrando. Di tanto fe' degna Venezia ardor di
speranze e tenacia d'intendimenti. E il meraviglioso espandersi della possanza
guerresca e civile si accompagna all'avanzamento dei commerci. Alle
inquietudini interne, alle agitazioni civili succede la forte serenità.
Vivissimo il commercio. Nelle vecchie carte si parla sovente di carichi di
mercanzie pel valore di 150,000 ducati d'oro, di navi cum raxon de drapi, telle et altre cosse de valor de ducati 200,000.
E si noti che erano in gran parte piccoli legni, perchè tutti voleano
trafficare, tanto che il governo prescrisse con decreto le proporzioni più
piccole di uno scafo per avventurarsi in mare.
Nè men fiorenti
le arti e le industrie. - Venezia ha, fin dai secoli più remoti, fonderie di
metalli, fabbricatori d'organi, officine di tessitura, di tintoria, di
vetreria, fabbriche di sete, lini, velluti, broccati. Le antiche chiese, specie
quelle di Grado e di Torcello, scintillavano di mosaici. Negli Annali di
Eginardo, si ricorda, all'anno 826, Giorgio, prete veneziano, chiamato in
Aquisgrana, per la sua abilità nel costruire organi. Orso I Partecipazio,
asceso al trono dogale nell'864, mandò in dono a Costantinopoli dodici campane,
e Pietro Orseolo II, fatto doge nel 991, fe' regalo a Ottone III di una tazza
di fino lavoro di due troni rivestiti di lamine d'avorio e di una tazza
d'argento. Non si può dire che in egual fiore fosse la cultura letteraria, se
due documenti sono da due dogi, Pietro Tradonico e Tribuno Memo, firmati così: Signum manus domini excellentissimi Petri
ducis e Signum manus Tribuni ducis.
Ma fra quel pratico e operoso popolo di navigatori e di trafficanti non potevano
aver culto se non le arti, che al dolce unissero l'utile. E tali arti andarono
a mano a mano meravigliosamente avanzando.
Martino da
Canale, narrando l'incoronazione di Lorenzo Tiepolo, nel 1256, descrive con
pittoresca efficacia la sontuosa processione delle Arti veneziane: primi
venivano i fabbri col loro gonfalone e con ghirlande in capo: poi i pellicciai
riccamente addobbati di armellino e vaio, di sciamito e zendado. Seguivano,
cantando, accompagnati da trombe, portando coppe d'argento, i tessitori; i
sarti in veste bianca a stelle vermiglie: i fabbricanti di drappi d'oro e di
porpora, con cappucci dorati in testa e belle ghirlande di perle; e via via i
lanaiuoli, i barbieri, i vetrai, gli orefici. Gli orafi specialmente
raggiungeano la dignità d'arte più squisita in quei piccoli capilavori di
imagini, imitate dai bizantini, in quegli ornamenti d'oro e perle, di cui è
perfino menzione nel testamento del doge Giustiniano Partecipazio dell'829, e
in quelle catenelle d'oro, preferito ornamento sì delle gentildonne come delle
popolane venete. Cito questo lieve, ma non insignificante particolare. Nel
1225, Federico II, il grande sovrano e il grande artista, ordina a un orafo di
Venezia una zoia, un gioiello.
In questo
periodo delle origini, la città ha un aspetto singolarissimo. Questa
maravigliosa zattera di sabbia e di fango è indefinibilmente strana per forma e
non rassomiglia ad alcun altro paese. Il Sannazaro, nel tempo in cui Venezia,
un po' invecchiata, incominciava a porgere ascolto benigno alle bugie dei
poeti, scrisse un epigramma, che gli fruttò cento scudi per ciascun verso (i
versi erano però sei soltanto) e nel quale, comparando Roma a Venezia,
conchiude col dire che quella fu fabbricata dagli uomini, questa dagli dei.
Illam homines dices, hanc posuisse deos.
Nulla di più
poeticamente menzognero. Venezia fu fatta dai Veneziani. Il nume indigete erano
la forza, l'operosità, il vigore, il coraggio, l'ardore di quei profughi
intrepidi. Per voi, ad esempio, o signori, la patria è un dono, uno splendido
dono di Dio - pei Veneziani è l'opera dell'industria umana. Entro questo vostro
divino anfiteatro di colline, rigate dai canali freddi e molli, fra la
magnifica pompa della verzura e dei fiori, palpita una dolce vita, dove hanno
sorrisi tutte le cose, viventi nella felicità di un'armonia serena, armonia dei
colori e della luce, del suolo e dello spazio. Qui l'opera dell'uomo è un
sublime commento all'opera della natura, e l'arte temperata al sentimento
dell'aere circostante, assume una elegante semplicità e compostezza di linee,
una nobiltà morale di forme che riposa l'animo e contenta l'occhio. La cupola
del Brunelleschi, il campanile, la loggia dei Lanzi, Orsanmichele sono come il
compimento di Bellosguardo, di Fiesole, di Monte Oliveto, di San Miniato, e le
linee del paesaggio con quelle degli edifizî si fondono nel comune accordo.
Venezia invece, eretta sur un labirinto di secche e di paludi, sovra un piano
di acque e di alghe, dovea rispecchiar nell'aspetto, fin dall'origine sua, i
capricci imaginosi dell'uomo, non già l'impero della natura esteriore. Guardate
San Marco, il prodigio dell'architettura veneziana! È una sublime bizzarria. I
rosoni, i rabeschi, gli intrecci, i pinacoli slanciantisi al cielo, presentano
l'aspetto di una lussureggiante vegetazione di pietra. Le arcate a trifoglio,
le aguglie traforate, l'innesto dell'arco acuto sul bizantino, tutta l'opera
fine, con la sua ricca veste di sculture e di cesellature, colle sue armonie e
co' suoi disaccordi, sembra una vasta sinfonia nel marmo. Nessuna licenza è
vietata; simboli di tristezza macilente e di florida giovinezza, figure
misticamente rigide e mondanamente voluttuose, vergini e martiri assorti in
visioni serafiche, e angeli e beati, vivificati da idee terrene, mostri e
chimere del paganesimo a canto ai santi del cattolicesimo. - Tale Venezia. -
Percorrendo il Canal grande, ci passano dinanzi fantastiche architetture
bizantine, palazzi di stile arabo-archiacuto simili a trine di marmo, edifici
del Rinascimento corretti e severi, moli maestose della decadenza dalle bugne
massicce, dalle cornici ponderose. Qui l'architettura non ha tradizioni e, tra
gli splendori del cielo e le iridescenze delle acque, cresce mobile, varia,
fantastica, come le tinte dei tramonti, come i riflessi delle lagune. Nessuna
città è passata per più diverse forme.
L'imaginazione
può compiacersi senza allontanarsi dal vero, a raffigurarsi così l'aspetto di
Venezia adolescente. Quelle sporgenze dal fondo lagunare, su cui era sorta la
città, si chiamavano con varî nomi: dossi,
scanni, barene, tombe, velme. Eretta una casa sopra una palude, si chiedeva
al governo di estendervisi con interrimenti. E il tributo per la concessione,
era alcune volte un bel paio di guanti di camoscio pel doge. I canali (rivuli), che s'incrociavano in ogni
parte e si chiudevano per sicurezza con catene, erano fiancheggiati da alberi.
Si attraversavano i ponti di legno di brevissimo arco, senza gradini, si
seguivano strade lungo i canali, chiamate fondamenta
o junctoria, si entrava in certe
piazzette anguste (campielli), per
certi chiassuoli stretti (calli) e si
riesciva all'aperto dinanzi a qualche largo specchio d'acqua (piscina), a seni, a sbocchi, oppure fra
verdi prati (herbidi piani), dove
pascevano armenti, o in mezzo a folti boschetti. La piazza di San Marco si
chiamava brolio, ossia orto, perchè
ricoperta d'erba e piantata d'alberi. Apparivano qua e là saline in muratura, e
incassati tra argini e canali stendevano i raggi delle loro ruote i molini,
chiamati acquimoli. Si camminava sul
nudo terreno: i cavalli correvano per la città, e i porci dei monaci di
sant'Antonio grufolavano continuamente per le vie - sub specie et reverentia Sancti Antonii vadunt per civitatem -
diceva un decreto del Maggior Consiglio. Le case erano, nei primi tempi,
coperte di tavolette di legno o di paglia e alcune non aveano altra via che
d'acqua. Ogni magnificenza era riservata ai pii edifici e alla dimora del capo
dello Stato. E fra le case e sopra i tetti, nettamente intagliate nel pieno
azzurro, vele, antenne, cordami. Poi prospetti lontani di altre case e di altre
vele, e sullo specchio tranquillo della laguna le svelte navi - le zalandrie, i dromoni, le galee - il cui solo nome, il solo ricordo, ci svegliano
nella mente la visione della gloriosa epopea marinaresca delle città italiane.
Squadre intere di navigli, che toccavano i porti dell'Asia e dell'Africa e
scorrevano i mari del Nord; naviganti che, con la sicurezza della forza e il
presentimento della gloria, spingeano la prora così fra le acque su cui si
riflette il sole d'oriente, come fra le sconfinate solitudini brumose del
settentrione; marinai che passavano a traverso mari inesplorati e toccavano
terre ignote, fra gli ostacoli della natura e i più perversi ostacoli degli
uomini, fra grida alzantisi nello spazio a osannare al trionfo e urla
imprecanti inutilmente alla morte - intrepide avanguardie del progresso umano,
della civiltà moderna, della gloria italiana.
Una sola città
avrebbe potuto rivaleggiar con Venezia e metterne in dubbio il primato: Amalfi.
Alla città surta là dove il monte cala, lieto di verzura e fiorente di messi,
al mare, accorrevano d'ogni fatta stranieri. La descrizione di Amalfi fatta da
uno scrittore, a cui la poesia non fa velo alla verità del giudizio, Guglielmo
Apulo, non ha nulla da invidiare alle condizioni di Venezia nei tempi più
prosperi. Straricca di tesori e frequente di popolo: le case piene d'argento,
di stoffe d'oro, di tessuti di seta. I suoi marinai, noti in tutto il mondo,
san farsi strada sulle onde, in mezzo ai venti e alle tempeste. Le merci che
escono da Alessandria d'Egitto e dalla città d'Antioco sull'Oronte, affluiscono
tutte alla spiaggia d'Amalfi. Non v'ha porto in Arabia, nella Libia, in Africa,
o nei paesi della Sicilia, che non sia stato visitato dall'Amalfitano. Ma fu
luce rapidissima, come fu passeggero lo splendore di Napoli, Gaeta, Sorrento,
signore dei mari, ben prima che dalle ruine dell'antica grandezza greco-romana
risorgessero le repubbliche di Pisa, di Genova e di Venezia. In sui primordi del
secolo XII, la libertà e la prosperità amalfitana furono spente dalla violenza
di quegli eroici avventurieri normanni, a cui nulla omai più resisteva in
Italia, nulla, tranne Venezia, la quale con la giovanile energia delle sue
forze, dopo una fierissima guerra, durata tre anni con varia fortuna e finita
nell'agosto del 1085 colla presa di Durazzo, salvò dai Normanni il decrepito
Impero bizantino, ottenendone in compenso privilegi importantissimi, nuovi
possedimenti, libertà assoluta di traffico e perfino un quartiere distinto in
Costantinopoli stessa.
Qui Venezia si
trova di fronte ad altre due città marittime, che andavano anch'esse crescendo
in potenza, e alle quali la fortuna della rivale non poteva non destare
sospetti e antagonismi, scoppiati poi in sanguinose discordie.
Pisa non era
una nuova venuta. I documenti della sua nobiltà risalivano all'antica civiltà
etrusca, alla grandezza romana. Risorta dopo l'invasione barbarica, ebbe a
combattere i Saraceni. Ma il valore delle armi non si scompagna agli accorti
maneggi del commercio e ai provvidi ordinamenti civili. Il dominio della
contessa Matilde fu più di nome che di fatto e non impedì il libero svolgimento
della libertà, fecondatrice di ricchezza e benessere materiale. E quanta fosse
la sua floridezza commerciale, provano le parole del monaco Donizone, il quale,
nel suo ascetico fanatismo, vede i navigatori pisani trasformati in mostri
marini e la città insozzata da male generazioni di Pagani, Turchi, Libici,
Parti, e le sue spiaggie corse dai Caldei.
Dopo aver
combattuto contro la vicina Lucca, Pisa combattè pel possesso della Sardegna
contro Genova.
Difficili i
primi passi di Genova, umili le origini: trafficare coi porti vicini,
combattere i predatori saraceni e normanni. A poco a poco, a nuovi commerci
nuovi lidi. Fin dal 958, essa gode della sua libertà, non funestata mai da
capricci superbi di conti, di marchesi, di duchi, ai quali tutti il trattato di
Berengario II e di Adalberto vietano di porre piede nella città. Prosperano le
compagnie cittadine belligere e trafficanti. Da prima, insieme coi Pisani,
Genova strappa ai Mori la Sardegna, ma ben presto le armi consociate diventano
fratricide, e la guerra fra le due città dura sessant'anni.
Ad accrescere
la ricchezza e le rivalità delle città marinare d'Italia giungono le crociate.
È opinione
comune che tra le prodezze irreflessive, ma generose delle crociate, Pisa,
Genova e, in ispecie, Venezia, non abbiano cercato che l'interesse ed abbiano
fatto servire una grande idealità religiosa ad ottener dovizie materiali, ad
aprir nuovi scali al commercio. Certo, fra quei tre popoli non apparve
l'ascetismo feroce, nè il principio di autorità dogmatica, soccorritore del
feudale e del dinastico, ma la religione fu sentita e intesa fra quelle genti,
nè fu ipocrito pretesto di mercantili speculazioni. Vi sono popoli credenti e
pratici a un tempo, come l'inglese e il veneziano. Sono sinceri in tutti e due
gli atteggiamenti della loro esistenza, e perchè sinceri colgono i frutti di
ambedue queste attitudini dello spirito. Il missionario inglese, quando con la
Bibbia, tradotta in tutti gli idiomi asiani e africani, s'avanza in regioni
ignote a spargere la santa semente del verbo di Dio, è profondamente sincero e
devoto al suo ideale fino a rifiutare per esso la vita. Ma, superate le
difficoltà, egli è egualmente convinto di servire alla sua patria mutando
l'evangelista in negoziante, segnando la via ai cotonieri del Lancashire e
qualche volta, e Dio gli perdonerà, ai fabbricatori di brandy del suo paese. Così Venezia: devota a Cristo, si sentiva
bensì accesa di zelo religioso per la liberazione del Santo Sepolcro, e,
all'infuori di ogni pensiero mondano, palpitava nella isoletta di Rialto, come
il grande signore di Francia e di Lamagna nel suo maniero. Ma a canto all'imagine
di Gesù crocifisso, i signori dei mari intuivano tutti i nuovi orizzonti di
traffichi e di colonie e vi si fisavano con amoroso zelo. E in quel connubio di
palpiti cristiani e di mercantili disegni, si accordavano la religione con
l'industria, l'ascetico col mercadante, e l'imagine di Gesù liberato si
adornava di tutte le opulenze della nuova vita economica. Così erano, o
signori, anche i vostri antenati. Credenti, mercadanti e diplomatici a un
tempo, mistici e positivisti, i lucri guadagnati negli arditi commerci
consegnavano alla divinità e dai banchi uscivano gli artefici, che erigevano i
vostri insigni monumenti. Così la nostra storia prova come sia vano, sterile e
oseri dire irreligioso, un ascetismo monastico orientale, che si consuma ne' suoi
malaticci idealismi, e come, alla sua volta, conduca a ruina una sete di lucro,
che non si temperi, non si legittimi e direi quasi non si purifichi in queste
aure salubri della idealità. Quanto diversi, o signori, dai coloni italiani del
nostro tempo, i quali, senza ideali religiosi e senza disegni di utili
operosità, si avventurano in luoghi, che nè i nostri antichi apostoli, nè i
concittadini di Marco Polo e di Colombo avrebbero eletto a sede di colonie. Il
che dimostra appunto, perchè ci fa difetto il modo di scegliere con infallibile
rettitudine di giudizî, quanto ci manchi e quanto siamo lontani dalla sana
idealità e dall'avveduta operosità dei nostri maggiori. Oh! non disputavano a
Venezia sulla fecondità e sull'avvenire delle grandi colonie che occupavano,
come non disputavano a Genova su quelle del mar di Marmara e del mar Nero. Le
opime spoglie che ne traevano non consentivano i dubbi dolorosi, che s'odono
nei nostri parlamenti.
Ma, siamo
giusti, ciò che ai nostri maggiori mancava era il senso della concordia. I
vicini interessi e le comuni imprese fecero scoppiare più fieri i dissidî fra
Pisa, Genova e Venezia.
Intanto da una
straordinaria impresa era agitata quest'ultima città. Quando Innocenzo III
tentò ravvivare la santa guerra, i crociati francesi si rivolsero, per ottenere
il navilio, a Venezia. Era allora doge Enrico Dandolo, vecchio ottuagenario, a
cui gli anni e la debole vista accresceano l'ardimento e l'energia; indole
tenace e impetuosa e nello stesso tempo astuta e dissimulatrice. Egli accettò
le proposte, ma prima di accingersi all'impresa, volle avere l'approvazione del
popolo, ch'ei fe' radunare nella chiesa di San Marco, la plus belle que soit, come la chiama Goffredo di Villehardouin,
uno di quei crociati. I cavalieri di Francia dalle armi corrusche, i veneti
patrizî dalle vesti gravi e maestose dell'Oriente, il popolo dalle fogge
variopinte, si adunarono sotto le cupole dorate dai scintillanti mosaici, fra
quella strana architettura di colonne superbe sovrapposte a colonne, tra le effigie
mirabili e i marmi preziosi.
Il vecchio
doge, in luogo eminente, indossava una tunica purpurea, un manto affibbiato con
borchia d'oro e un corto bavero d'ermellino. Parlò Goffredo di Villeardouin
pregando Venezia ad accompagnare i baroni francesi a vendicare l'onta di Gesù.
La voce di quel guerriero entusiasta si alzava trionfante come un inno,
ricercava le fibre più intime di quei cuori, finiva addolcendosi in una prece,
nella quale passava il puro alito della fede. Allora da più di diecimila petti
un grido s'alzò sotto le vôlte dorate della chiesa e il doge e i legati
francesi giurarono sulle loro spade. Ma quando furono pronte le navi, non
trovando i baroni di Francia, tutta la somma stabilita pel passaggio, Enrico
Dandolo propose loro, in luogo di soddisfare intero il debito, di riconquistare
insieme coi Veneziani la città di Zara ribellata. La proposta fu accettata, e,
dopo poco tempo, Zara cadeva. Durante l'assedio si presentava ai crociati
Isacco, imperatore di Costantinopoli, spodestato da un usurpatore, chiedendo
aiuto per ricuperare il trono. Papa Innocenzo, che avea con ogni possa cercato
d'impedire l'impresa di Zara, scagliando perfino i fulmini apostolici, ora
secretamente favoriva la spedizione di Costantinopoli, vagheggiando l'unione
della Chiesa anche in Grecia. Avea finito col trovare gli opportuni ripieghi
sacerdotali, concludendo con un pensiero degno della politica odierna: necessitas, maxime cum insistitur opere
necessario, multum et in multis excusat. E poi troppo recenti erano le greche
perfidie contro la repubblica di San Marco, perchè ogni veneziano non sentisse
in cuore il desiderio della vendetta. Non erano ancor vive le generazioni che
aveano veduto il fedifrago imperatore gettar un giorno in carcere tutti i
Veneziani, che avea potuto prendere ne' suoi stati? E il valore dei Veneti,
condotti da Vitale Michiel non era stato reso impotente dalle inique arti dei
Greci? E non si era tentato di perdere coll'inganno più infame lo stesso Enrico
Dandolo, che in Costantinopoli avea tentato di salvare l'onore della patria?
Non erano le leggi e i trattati arbitrariamente violati dalla corte bizantina?
D'altra parte, e i documenti attestano ciò, il Pontefice e il Doge si
accordavano nel pensiero che la sommessione di Costantinopoli potesse agevolare
il conquisto di Terrasanta. Fu stabilita l'impresa e compiuta; ma poco stante,
in seguito a nuove rivoluzioni e intrighi di palazzo, i crociati vennero a
rottura coi Greci, e Costantinopoli fu presa per la seconda volta. Quando il
gonfalone di San Marco sventolò sulle mura di Costantinopoli, i Greci fuggirono
spaventati, fra il confuso rumor d'armi e di grida, unito al frastuono orrendo
di urla, di gemiti, di pianti. E il Papa, plaudendo agli eventi fortunati,
scriveva ai vescovi, abati e duchi dell'esercito: sane a domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris. E
dimenticò Terrasanta.
«Dalla
creazione in poi non v'ebbe più larga preda» scrisse il Villehardouin. Immense
ricchezze e preziosi oggetti d'arte furono salvati nella generale rapina, e
trasportati in patria dai Veneziani: quadri, statue, gemme con cui arricchirono
la pala d'oro e il tesoro di San Marco, e i quattro celebri cavalli di rame
dorato che, trasportati da Chio, dall'imperatore Teodosio II, a ornare
l'ippodromo di Bisanzio furono posti sul pronao della basilica veneziana.
La forza di
Venezia imperava ormai sull'Oriente. All'interno potea dirsi secura, coi nuovi
ordinamenti politici, per mezzo dei quali si svolgeva la sua attività, colla
legge che impera e custodisce, colla concordia che fortifica e rafferma.
Sottratta già da lungo tempo al popolo la dogale elezione, chiuso a chi non
fosse nobile, il governo, s'era consolidato quel reggimento di ottimati, grande
anomalìa fra due cose normali, il governo cioè di tutti e quello di un solo che
tutto eguaglia in una comune tirannide, quel reggimento di ottimati che salvò
l'indipendenza veneziana. Costituzione non certo desiderabile oggi, ma per quei
tempi ammirabile, e che illuminò del suo raggio uno dei periodi più gloriosi della
libertà fiorentina, quando, tenendo gli occhi fissi a Venezia, fra Girolamo
Savonarola, Paolo Antonio Soderini, Francesco Valori e altri magnanimi volevano
garantire la nuova indipendenza, affidando la somma delle cose ai migliori dei
cittadini, ai benefiziati, e
instituendo il Consiglio grande. Il tentativo fallì, poichè la tenacia del
volere non fu pari all'altezza degli intendimenti.
Delle due forti
rivali di Venezia, Pisa in breve non fu più da temersi. La sua potenza
s'infranse allo scoglio della Meloria e sulla bella e sventurata città aleggiò
l'arte, supremo conforto. Quando l'età delle forti imprese si oscura, s'inalba
luminosa quella delle arti.
Restava Genova,
nè il vessillo di San Giorgio volle per lungo tempo e a niun patto piegare
dinanzi a quello di San Marco. Lunghe e accanite le guerre, brevi le tregue,
per ripigliar lena a nuove battaglie, combattute con varia fortuna.
Nel 1256, i
Liguri spogliano le navi veneziane nel porto d'Acri e saccheggiano il quartier
veneziano. Lorenzo Tiepolo corre alla vendetta, con gran numero di navi e
coll'aiuto dei Pisani, spezza la catena del porto, preda e arde le navi
nemiche, penetra nella città, incendia il quartiere dei Genovesi ed espugna il
castello di Mongioia. Invano i Genovesi tentano riannodare le forze: il
Tiepolo, presso a Tiro, li sbaraglia una seconda volta; poi non lungi da Acri
stessa, li sconfigge nuovamente con più sanguinosa battaglia.
Nel 1261, la
gelosia ligure rialza il trono greco a Costantinopoli. Vi si oppone Venezia e
ne vien nuova guerra, finita colla rotta dei Genovesi nelle acque di Trapani.
Una fiera
rivincita prese Genova a Curzola, quando, sotto il comando di Lamba Doria, un
minor numero di galee vinse i Veneti condotti da Andrea Dandolo. Il Doria
trasse seco a Genova 5000 prigioni. Marco Polo fra questi. Lo sfortunato
ammiraglio di Venezia die' di cozzo nell'albero della sua nave e morì....
Ma a che oggi
riandare la serie di questi gloriosi delitti? Nel camposanto di Pisa, in quella
dimora di morti, dove palpita tanta parte di storia italiana, stanno appese,
non già trofeo di ire fraterne, ma segno perenne di fraterno affetto le catene
del porto di Pisa, dai Genovesi prese e donate ai Fiorentini. Nell'affetto
sereno della patria unificata, Firenze e Genova vollero restituite a Pisa
quelle catene, come augurio d'invitta concordia fra le città italiane, pegno e
segnacolo di un'êra novella.
Ora una luce
irradiano quei torbidi ricordi di storia italiana, luce di fraternità e di
pace.
LE ORIGINI DEL COMUNE DI MILANO
DI
Romualdo Bonfadini
Lo studio delle
origini - è bene saperlo prima di mettersi in via - rappresenta per lo spirito
piuttosto una fatica che un diletto.
La scarsità
delle fonti, la cronologia difficile, l'ermeneutica capricciosa obbligano a
lunghe indagini, a laboriose induzioni, per istabilire quello che si suole
chiamare la verità storica e che, nella maggior parte dei casi, si limita ad
essere la congettura più verosimile. E d'altra parte, urtano così fieramente
coi nostri i costumi, i sentimenti, le leggi di quell'epoca buia, che il
piacere dei paragoni scompare, e la stessa immaginazione si stanca a cogliere e
ricomporre la continuità dei contorni in quelle figure, di cui la storia non
può dare generalmente che tratti incompleti, interrotti, sfumati nel tipo morale
e nelle particolarità dell'azione.
Però, v'è un
aspetto del problema che può mitigar la fatica di questo studio. È una
soddisfazione di pensiero che non può sembrar vana al filosofo, se anche lascia
indifferente l'artista. Poichè nello studio delle origini assai più che nello
spettacolo delle decadenze l'orgoglio dell'umanesimo trova ragion di
affermarsi.
Le origini non
sono altro, storicamente, che i periodi nei quali le istituzioni umane, di
qualunque natura, passano dallo stadio anarchico ad una forma organica. Ora,
difficilmente questa trasformazione si manifesta, senza l'impulso della virtù.
Virtù d'uomo o virtù di popolo; genio di individui o istinto di moltitudini;
energia d'iniziative, quand'anche macchiate dalla fatalità del delitto, o
devozioni di concordia, quand'anche rese inefficaci da difetto di previdenza.
Il fenomeno può
dirsi costante, in quanto si riferisca alle origini dei poteri pubblici, siano
monarcati, comuni e repubbliche. Sembra quasi che la Provvidenza abbia voluto
imprimere a questi periodi, che rasentano in certo modo lo sforzo della
creazione, quel carattere di grandezza che necessariamente segue o circonda i
creatori. Così, non si può pensare alle origini della monarchia francese senza
risalire a quel Carlo Martello, che rimane nelle fantasie popolari come il tipo
del guerriero nazionale invincibile. Ruggero il normanno e Umberto Biancamano
dominano della loro fiera e simpatica personalità le origini dei due maggiori
principati italiani. Nè la fondazione della monarchia spagnuola può
disgiungersi da quel generoso nucleo di patrioti, raccoltisi con Pelagio sui
monti baschi a costituire il battaglione sacro della resistenza nazionale. Nè
la storia grande della repubblica di Venezia può farci obliare quell'energico
esodo di pescatori che giurano di mantenere, sulle palafitte di Rialto, la loro
libertà insidiata dalle orde conquistatrici della terra-ferma.
È sopratutto
nel secolo undecimo che l'Italia vede sorgere a vita organica parecchie delle
sue agglomerazioni politiche. Prima del mille, qualche tentativo di
ricostituzione serve quasi unicamente a confermare lo stato di dissoluzione in
cui langue tutta la penisola. Non s'è ancora dimenticata l'ultima violenza
delle invasioni barbariche ed ecco sopraggiungere a disgregare ogni compagine
sociale la preoccupazione del finimondo. Le lotte civili, accanite negli ultimi
tempi, vanno perdendo d'intensità, non perchè scemi l'abitudine delle offese,
ma perchè tutti sono intenti al pericolo della fine suprema, che le profezie
popolari hanno segnalato.
Come il feudo
era stato lo strascico della conquista, così il beneficio ecclesiastico diventa
lo strascico lasciato dalla paura del finimondo. Le autorità secolari, che non
possono garantire la vita eterna, perdono d'influenza; ne acquistano a dismisura
le autorità chiesastiche, nelle cui mani stanno le chiavi del perdono e della
salvezza. Così il potere politico viene a poco a poco assunto dagli
arcivescovi, contro i quali non hanno più forza i conti e i duchi, lasciati dai
conquistatori stranieri a rappresentanti dell'impero feudale nelle città. Le
donazioni arricchiscono preti e monasteri, che dalla ricchezza traggono facile
stimolo alla corruzione. Ed ecco preparate le due questioni che nel secolo
undecimo agiteranno l'Italia. La lotta per le investiture e la riforma
disciplinare del clero. Nè dal mille è lontano Gregorio VII, che di entrambe le
questioni sarà nel tempo stesso il più formidabile campione e la più illustre
vittima.
Senonchè il
pauroso millenio è superato senza catastrofi e il mondo comincia ad acquetarsi
nel pensiero della propria continuazione. Che cosa accade? che i pochi, fatti
potenti dalla superstizione, mirano a rassodare e rendere più completo il loro
dominio; che i molti, costretti a vivere dopo aver creduto di morire, rimpiangono
la cecità loro e le sostanze stremate; che il disagio turba profondamente le
classi popolari, le quali escono dalla crisi, sentendosi sul collo il giogo
rinnovato di due tirannie. Intanto ricompaiono le discordie intestine, le lotte
feudali, che soltanto il timore della distruzione universale aveva frenate. Le
ingordigie e le violenze si danno ad eccessi tanto maggiori quanto più lunga è
stata l'epoca della loro forzata inazione. In questa ridda di passioni scompare
ogni benessere di plebi, ogni generosità di ottimati; la legge è fatta ludibrio
nelle mani di ogni forte; e il forte di oggi diventa lo sconfitto del giorno
dopo. Tutto questo ha un solo risultato, una sola caratteristica, un solo nome:
è l'anarchia.
Di qui nasce,
nel secolo undecimo, quella reazione salutare che dà vita ai principati
ereditari ed alle repubbliche comunali. Così l'una come l'altra forma organica
è accetta alle moltitudini, delle quali ordinariamente soltanto il caso
dispone. Poichè non bisogna illudersi che alle costituzioni cittadine del
secolo undecimo abbia spinto un prepotente bisogno di libertà. Il bisogno
prepotente era l'ordine, era la fine dell'anarchia. Dove il genio o la
prepotenza d'un uomo bastasse a dare questa sicurezza di governo organico, le
popolazioni accettavano anche la tirannia d'un solo, purchè le liberasse dalla
tirannia dei molti. Se l'uomo mancava, o il genio non faceva perdonare la
prepotenza, le moltitudini cercavano alla libertà il modo di vincere
l'anarchia. Ma ci sono voluti dei secoli - forse ce ne vorranno ancora - perchè
la libertà, accettata come il veicolo di un beneficio, diventasse un beneficio
per sè. Quelle moltitudini, che nel secolo undecimo avevano saputo disciplinare
gli ordigni della libertà, non esitarono a romperli, quando appena
un'impressione momentanea portava verso altri orizzonti l'animo loro. La storia
può essere interpretata, ma alla storia non può sostituirsi il desiderio. Il
vero è che nei nostri grandi Comuni, se della libertà mancò rare volte
l'intelligenza, quasi sempre mancò l'amore. Il vero è che nel sagace desiderio
dell'ordine, le moltitudini italiane oscillarono spesso e spontaneamente fra i
poteri autonomi e i principati sovrani. Poichè non sempre furono i tiranni che
strozzarono le libertà; qualche volta le libertà si sono umiliate ai tiranni.
Una riprova di
queste induzioni la si troverebbe con poco sforzo nella storia di uno dei
maggiori municipi d'Italia; di quello che per la sua giacitura ha subìto prima
degli altri, e forse più gravemente d'ogni altro, lo storico avvicendamento
delle invasioni, delle liberazioni e delle tirannidi.
Intendo parlare
di Milano.
Al principio
dell'undecimo secolo Milano era forse una delle più popolose città d'Europa, e,
senza forse, la più popolosa d'Italia. Era già stata a quell'epoca due volte
nella polvere e due volte sugli altari. Nel secolo quarto, come sede del
Vicario d'Italia, era considerata la seconda città dell'impero Romano. Il
ferocissimo Uraja, condottiero dei Goti, vi sterminò più di 30 mila abitanti e
fece della marmorea città un mucchio di rovine. Per tre secoli Milano sparisce
quasi dalla storia e perde quei privilegi, che invece usurpano, come più
floride, Pavia e Monza. La sola influenza che vi rimane grande è quella
dell'arcivescovo; influenza che, per l'indole sua, subiva poco le fluttuazioni
della prosperità materiale, conservando quel principato diocesano che si
estendeva sopra 24 vescovati suffraganei e sopra un territorio che andava da
Genova a Coira, da Mantova a Torino.
Ed è un
arcivescovo, che nel secolo nono ritorna a floridezza e splendore le condizioni
di Milano, venute lentamente migliorando sotto il regime dei Longobardi e dei
Franchi. Ansperto da Biassono, probabilmente uscito dall'antichissima famiglia
dei Gonfalonieri, governò per tredici anni, dall'868 all'881, la sede milanese;
vi esercitò potere largo e benefico; mantenne contegno vigoroso contro le
pretese di un pessimo Papa, Giovanni VIII; e rialzò, completandola, l'antica
cerchia murata, già eretta dall'imperatore Massimiliano e demolita dai Goti.
Questo bastò perchè fra gli abitanti della Lombardia, atterriti dalle frequenti
scorrerie degli Ungheri e dall'imperversar dei banditi, si determinasse un
vasto moto di emigrazione verso la città, dove quelle nuove e solide difese
garantivano la vita e gli averi. Rapidamente la popolazione di Milano aumentò;
sicchè nel secolo undecimo poteva calcolarsi, secondo il Cibrario, a
trecentomila abitanti.
Questa però era
prosperità materiale; che non toglieva l'anarchia delle prevalenze politiche,
il mutabile avvicendarsi degli ordinamenti, la moltiplicità dei despotismi e
delle giurisdizioni, la tradizione ostinata delle civiche turbolenze.
Cominciava
l'incertezza nella stessa persona del sovrano legale. Ogni morte di principe
dava occasione a più guerre, ed ogni volta si mutava la base elettorale o la
forma di consacrazione del nuovo Re.
Dopo Carlo il
Grosso, la successione dinastica di Carlo Magno in Italia era finita. Con un
po' di concordia, le conseguenze della conquista avrebbero potuto mitigarsi e
dar luogo all'instaurazione d'una monarchia nazionale. Invece, due Berengarj,
un Guido, un Rodolfo, un Ugo, un Lotario, un'Ermenegarda, riempiono di lotte e
di supplizi un secolo intero; dopo il quale, invitati dagli stessi pretendenti,
i Re di Germania scendono a rioccupare il feudo italico. Nell'888 Berengario
era stato coronato in Pavia, nel 961 Ottone I si fa coronare in Milano.
Questa
mutazione di famiglia dinastica non impedisce che rimangano, sotto i nuovi
principi, cogli antichi poteri, i rappresentanti degli antichi regimi.
Già i
Longobardi avevano destinato un Duca a governare la città; e questo teneva il
suo tribunale in un palazzo apposito, che si chiamava la curia del Duca, il cui
nome, corrotto, vive ancora in una delle località milanesi più note, il Cordusio. I Franchi vi sostituirono un
Conte, o piuttosto dei Conti, poichè sminuzzarono il territorio milanese e
divisero dalla città i circondari rurali, di cui ciascuno ebbe il suo Conte, e
si chiamarono a poco a poco il contado.
Poi venne l'epoca della maggiore preponderanza degli arcivescovi; i quali,
assenziente l'imperatore Germanico, si sostituirono ai Conti nel governo
temporale delle città murate e degli abitanti immediatamente finitimi, distinti
allora, per rispetto a quella sacra dominazione, col nome di Corpi santi.
Senonchè
l'appetito veniva anche allora col cibo. L'arcivescovo di Milano, vistosi
divenuto quasi un monarca, lottò coi monarchi, e pretese aver egli facoltà di
consacrare quei principi da cui veniva poi investito dell'autorità sua. Indi la
ragione di nuove lotte e di nuove incertezze nella sovranità. Si cominciò a
distinguere, nella stessa persona, la qualità d'Imperatore Romano da quella di
Re d'Italia. A Roma si otteneva la corona imperiale dal Papa; la corona reale
doveva ottenersi a Milano dal successore di Ambrogio. Naturalmente, se questi
Imperatori erano forti, combattevano le pretese dell'arcivescovo; se erano
deboli, le subivano. E vediamo infatti che nell'876 Ansperto da Biassono
presiede in Pavia una Dieta di vescovi e di conti, che elegge a re d'Italia
Carlo il Calvo, già incoronato a Roma. E nel 1027, Corrado il Salico riconosce
esplicitamente questo nuovo diritto, dicendo in Roma ai prelati che assistevano
all'incoronazione: «sicut privilegium et Apostolicae Sedis consecratio
imperialis, item Ambrosianae Sedis privilegium est electio et consecratio
regalis[2].»
A Milano poi -
come, del resto, in ogni altra città considerata sotto l'alto dominio feudale -
la giurisdizione del principe si esercitava a periodi intermittenti, mediante
magistrati speciali, eletti in ogni occasione dal principe stesso, e che
passavano sotto la comune denominazione di missi
dominici. Era specialmente affar loro amministrar la giustizia, sedere
arbitri fra le contese private dei cittadini, reprimere i violenti, difendere,
dicevasi, i deboli. In ciò la loro autorità s'intralciava con quella dei duchi,
dei conti, dei vescovi, e le decisioni contradditorie aumentavano le amarezze e
gli sdegni. Nè questi missi dominici scendevano
sempre dalle Alpi a portare la parola imperiale. Più volte quest'autorità si
delegava dall'Imperatore a un conte, all'arcivescovo, a questo o quell'altro
patrizio importante della città.
Che poi questi
giudici avessero, indipendente da ogni altra, la forza necessaria per far
eseguire i loro giudicati, non appar chiaro dai documenti dell'epoca. Se le
parti s'acquietavano, il giudice imperiale poteva dirsi fortunato; se non
s'acquietavano, chi aveva più forza si sottraeva agli obblighi imposti, e la sentenza
non eseguita diventava un disordine, qualche volta un tumulto di più. A buon
conto, per le uccisioni, che erano pur troppo allora i delitti più frequenti e
più comuni, durò lungamente in vigore una legge di Carlo Magno, conservata dai
successori, mediante la quale l'uccisore poteva liberarsi da ogni noia, col
tribunale, pagando il vidrigildo (wehrgeld),
ossia l'ammontare del valore, a cui era stimata la persona uccisa. È facile
vedere a che conseguenze poteva tirare una disposizione di così ingenua barbarie.
Non erano i ricchi quelli che valevano meno, e non erano i popolani quelli che
potessero permettersi il lusso di simili pagamenti.
Si aggiunga a
queste cause di profondo turbamento materiale e morale l'organismo interno
delle classi nobili, dei discendenti dall'antica razza conquistatrice.
Passato il
primo ed aspro periodo dei duchi, di
fattura longobarda, e a potere interamente dispotico, i Franchi, ai quali era
toccato in sorte regno più vasto e dominazione quasi europea, dovettero
moltiplicare i loro conti, e
tollerare necessariamente quella maggiore suddivisione di territori e di
attribuzioni che corrispondeva alla minore intensità del dominio.
Elettivi
dapprima, per sola e mutevole volontà del principe, come furono generalmente
tutti i titolari feudali, fino alle leggi di Corrado il Salico, i più potenti
cominciarono a poco a poco a rendere la carica ereditaria nella loro famiglia.
Così a Milano s'era insediata la famiglia d'Este, i cui antichi progenitori
rendevano giustizia, di padre in figlio, nel palazzo ducale longobardo, la Curia ducis. E questi, o mossi da
precoce sentimento d'italianità, o, più verosimilmente, dal desiderio di
aumentare, a spese di un sovrano più debole, la loro autonomia, s'erano fatti
sostenitori, dopo la morte di Ottone III, di quel valente e infelice Ardoino
d'Ivrea, che fu, prima di Vittorio Emanuele II, l'ultimo personaggio italiano,
sulla cui fronte si sia posata una corona di re d'Italia.
Così la
famiglia dei conti di Milano provocò le ire di Enrico II, re di Germania,
debellatore di Ardoino. Parecchi membri di essa furono arrestati e trasportati
in Germania, dove seminavano germi di nuove dinastie; ed essendosi
contemporaneamente innalzato il potere degli arcivescovi, questi trasmisero ad
altra famiglia di loro fiducia la gerenza degli affari spettanti alla contea.
Indi, l'istituzione e l'aumento di dignità dei vice-conti o Visconti, che pure
a quell'epoca appaiono nella corte arcivescovile e che, succedendosi
ereditariamente essi pure nell'alta intimità coi sommi prelati milanesi,
mettono le basi a quella potenza che, trecent'anni dopo, manderà così estesi e
così tetri bagliori.
Senonchè nè il
re, nè l'arcivescovo, nè il conte avrebbero potuto reggersi frammezzo a tante
incertezze di eventi e di plebi, se ai loro privilegi non avessero cercato
appoggio - oseremo quasi dire complicità - nei privilegi di quella classe
nobiliare, che ripeteva l'origine sua dall'aristocrazia barbarica e dal primo
spartimento delle terre, fatto in odio degli antichi elementi romani.
Di lì un primo
strato di altissima nobiltà cittadina, che nelle storie è chiamata dei
Capitani. Non molti e potentissimi, possedevano nella città vasti palazzi e
torri merlate, munite a difesa e ad offesa. Avevano clientele assai numerose,
vassalli dentro e fuori le mura, tenevano squadre di armigeri, s'erano
addossata la custodia delle varie porte della città. Anche in essi il feudo era
divenuto ereditario, o per concessione di principe o per lunga tolleranza di
usurpazione.
Ma col rapido
movimento della popolazione, specialmente dopo la riforma edilizia di Ansperto,
quel primo strato di aristocrazia apparve insufficiente alla sicurezza dei
privilegiati. Trecentomila popolani, ormai fattisi agiati colle arti e coi
commerci, non subiscono impunemente la dominazione di trecento ottimati. Questi
sentirono dunque il bisogno di allargare ad altre famiglie discendenti dagli
antichi conquistatori una parte dei vantaggi fino allora esclusivamente goduti
dai Capitani. Il feudo aumentò di estensione, perdendo d'intensità. E così
vennero costituendosi i Valvassori; nobiltà intermedia fra la plebe e i
feudatari maggiori; che stavano coi Capitani, quando il popolo romoreggiava
contro questo eccesso di privilegiati, ma che ai Capitani tennero più volte il
broncio, perchè non potevano ottenerne quella concessione che i Capitani stessi
avevano per sè carpita al supremo signore feudale, cioè la trasmessione
ereditaria del beneficio. Nè qui si fermava lo sminuzzamento della classe
nobiliare; poichè tra i Valvassori e la plebe sorsero i Militi; un altro stato
di popolazione che s'imbrancava fra i minori privilegiati; tratti dall'amor
dell'ozio che genera la prepotenza verso le classi inferiori e che di solito
s'allea mirabilmente colla servilità verso le superiori.
Qual fosse, in
tanto viluppo di arbitrii e di diritti, la confusione delle cose in allora,
potrete agevolmente desumerla dalla confusione d'idee ch'io cortamente ho
provocato nelle vostre menti con questa faticosa esposizione di poteri, di
vincoli e di magistrature. Nessun altro nome infatti adopera un biografo
contemporaneo, Vippone, per dipingere in pochi tratti quella situazione: «eodem
tempore magna et modernis temporibus inaudita confusio facta est Italiæ....»
Pure, è proprio
da quella confusione che venne una reazione di bene, od almeno di quel bene che
nel più cupo medio evo era possibile sognare per popolazioni laboriose e
tranquille.
Una serie di
eventi, succedutisi in un periodo di dieci anni, valse a togliere Milano dalla
lunga inerzia di servitù e prepararle quel regime di comunale indipendenza che
un secolo dopo doveva mostrarsi, colla Lega Lombarda, così maturo e robusto.
L'uomo che a
siffatto movimento diede l'impulso primo e che seppe per alcun tempo
vigorosamente capitanarlo - forse inconscio delle sue ultime conseguenze - fu
il celebre arcivescovo Ariberto d'Intimiano, probabilmente rampollo della
illustre famiglia De' Capitani d'Arsago.
Piccolo di
statura e grande di animo, coltissimo pe' tempi suoi, d'un intelletto audace,
d'una volontà ferrea e di smisurata ambizione, Ariberto d'Intimiano fu eletto a
governare la diocesi milanese, dopo la morte di Arnolfo, nel 1018. E subito
apparve quello che era, un uomo determinato a tenere un gran posto nella storia
del suo paese; avido di lotte e pronto a sostenerle energicamente contro tutti;
atto al comando e desideroso di esercitarlo senza colleghi; innovatore audace e
profondo, che a sostegno della propria tirannia non esitava ad impugnare le
armi della libertà, ma che di questa tirannia propria aveva così alto concetto
da non permettergli di sopportarne alcun'altra, venisse da Imperatori o da
Papi.
I Papi, egli li
accetta, purchè non si mescolino agli affari della sua Diocesi. Quanto agli
Imperatori, vuol farli lui. E però, quando si estingue, colla morte di Enrico
II, la famiglia imperiale di Sassonia, e fra i principi italiani ricomincia una
gara di ambizioni e di candidature dinastiche, egli si reca difilato in
Germania, dove quegli elettori avevano acclamato a loro sovrano Corrado di
Salico, duca di Franconia; e, ricevuto a Costanza cogli onori dovuti alla sua
dignità, senz'altro riconosce il nuovo principe e lo incorona colle sue proprie
mani come re d'Italia[3].
Con sì altera
disinvoltura non si era usato mai fino allora nominare dei re. Pure, quando
Ariberto ritornò, ed in un'assemblea di notabili italiani, convocata nei prati
di Roncaglia, diede notizia della nomina così fatta da lui, nessuna voce si
alzò a mettere in dubbio il diritto dell'arcivescovo o quello del re. I popolani
milanesi riconobbero in Ariberto un padrone, e lo accettarono con gioia,
pensando ch'egli avrebbe saputo liberarli dall'unica tirannia lontana e dalle
molte vicine. Gli ottimati videro con qualche amarezza che un uomo della loro
schiatta e da essi sollevato al principato ecclesiastico facesse così buon
mercato delle tradizioni e dei privilegi loro. Suum considerans, non aliorum animum, scrive indispettito il
cronista Arnolfo, che ai nobili apparteneva.
Nondimeno,
quando Corrado scese nel 1026 in Italia, Milano lo accolse splendidamente,
malgrado o forse anzi perchè Pavia gli aveva chiuso le porte in faccia.
Ariberto rinnovò in favor suo la cerimonia dell'incoronazione, nella basilica
di Sant'Ambrogio; lo accompagnò a Ravenna ed a Roma, dove il Papa gli pose in
capo una terza corona, quella dell'Impero; e, sopravvenuta un'estate di
straordinario e micidiale calore, lo ospitò largamente per due mesi, con tutta
la sua corte, nelle fresche villeggiature episcopali dell'alta Lombardia.
Partito
Corrado, e rimasto Ariberto più che mai potente e popolarissimo nel paese,
incominciò a svolgere quello che ora si direbbe il suo programma politico; vale
a dire un'azione personale piena di scatti, di audacie, di prepotenze; diretta
ad abbassare le influenze limitrofe per estollere gigante la propria;
oscillante fra Cesare e la democrazia; ma coll'evidente promessa che le due
potestà non dovessero avere altro rappresentante, altro programma, altri
interessi che i suoi.
Perciò assume
contegno di provocazione contro le città vicine, Pavia, Lodi, Cremona;
usurpando loro diritti e terre; battendone le forze e umiliandone
l'indipendenza. Per ciò largheggia di conforti e di grani, durante una
terribile carestia; e visita, con amore e con affettazione, i tuguri popolari,
dove lascia elemosine e semina gratitudine. Per ciò offre aiuti militari a
Cesare, ingolfatosi in una guerra di successione per la Borgogna; e si unisce a
Bonifacio, marchese di Toscana, per ispingere attraverso le Alpi un contingente
italiano, che Umberto Biancamano guida su per la valle d'Aosta, e che, sceso
nella valle del Rodano, decide efficacemente la contesa in favor di Corrado.
Per ciò si bilica fra le parti cittadine, sostenendo i Capitani contro i
Valvassori, e Cesare contro i Capitani, e i plebei contro Cesare. Per ciò
protegge l'autonomia del clero ambrosiano contro le velleità unificatrici del
pontefice romano; e, scomunicato per le sue resistenze, egli, arcivescovo, si
ride della scomunica, in un tempo in cui a quest'arma, di mistica onnipotenza,
non osavano resistere i maggiori principi della cristianità.
In ogni
questione dell'epoca, Ariberto d'Intimiano porta l'elemento delle sue passioni,
del suo spirito battagliero, del suo intelletto sovrano; ogni evento pubblico
sente le traccie di quella personalità romorosa, inquieta, assorbente; che ha
inspirazioni spesso alte e virili, ma che non esita a mutare alleati, principii
e combinazioni, secondo le necessità di quella preponderanza individuale, che è
la base della sua azione politica, la meta a cui tutto subordina.
Di questo
sistema si svolgono intere le fasi nel decennio corso fra il 1035 e il 1045,
chiudendosi con un risultato che nè a Cesare, nè ai Capitani, nè ad Ariberto
era balenato nell'animo.
Era infatti nel
1035 che i discordi interessi dei Valvassori e dei Capitani scoppiavano ad
aperta ostilità. Reduci dalla guerra di Borgogna con maggior sentimento delle
proprie forze e dei proprii diritti, i Valvassori accentuarono più vivaci
contro i Capitani le loro pretese alla trasmissione ereditaria dei loro feudi.
Alle ripulse altere opposero altera resistenza e insorsero armati per le vie.
La plebe stette cheta od aiutò mollemente. Sicchè i Capitani ebbero per loro le
formidabili influenze dell'arcivescovo e riuscirono a cacciare i Valvassori
fuori delle mura. Ma lì il pericolo, invece di cessare, divenne più grave.
Afforzati cogli aiuti del contado,
pronto sempre a reagire contro la tirannide cittadina, i Valvassori ottennero
anche il concorso dei Lodigiani, indispettiti contro Ariberto per le
usurpazioni dei loro diritti. Bisognò dunque combattere in aperta campagna, e
in soccorso di Ariberto venne con forte schiera il vescovo di Asti, Olderico,
zio della famosa contessa Adelaide, che al figlio di Umberto Biancamano avrebbe
poi data la gloriosa discendenza della dinastia di Savoia. La battaglia ebbe
luogo a Campo Malo, fra Milano e Lodi; la strage fu grande d'ambo le parti e il
successo indeciso; ma, essendo rimasto trafitto il vescovo Olderico, la
confusione fu tale che i combattenti ritornarono tutti nella città, rioccupando
Valvassori e Capitani le loro case, e rimanendo coll'armi al braccio, senza che
l'antico dissidio fosse placato o risolto.
Per placarlo o
per risolverlo, Ariberto invitò allora l'imperatore Corrado, del quale
supponeva l'animo a sè favorevole, pei ricordi dell'incoronazione e pel valido
aiuto prestatogli nella campagna contro i Borgognoni.
Corrado scese
infatti in Italia, ma con altre idee. Questa Milano, sempre irrequieta e
ribelle, voleva domarla. Udita la querela sorta fra le varie classi dei nobili,
aveva detto ai suoi cortigiani in Germania «se l'Italia è così affamata di
leggi, coll'aiuto di Dio, io la sazierò[4]».
Ed entrava in Milano, deliberato a fondarvi dominio nuovo, mediante il duplice
abbassamento dei grandi vassalli e del potere vescovile.
Ma del mutato
animo suo ebbe sentore Ariberto; e gli si rivelò subito potente avversario,
quanto gli era stato dapprima efficacissimo amico. Aveva Corrado manifestato il
proposito di emancipare la diocesi di Lodi dalla sovranità che su essa
esercitava l'arcivescovo di Milano. D'altra parte, una vaga tradizione, creata
da secoli, dava privilegio al popolo milanese di non ricevere nelle sue mura
nessun sovrano, fuorchè per causa d'incoronazione.
Fosse l'una o
fosse l'altra ragione, - o fossero entrambe, - o fosse, abilmente lumeggiata,
la paura della comune oppressione, certo è che il giorno dopo l'ingresso di
Corrado cogli armigeri suoi, un tumulto popolare scoppiò improvviso a Milano.
Più che
tumulto, bisognerebbe dire rivolta; giacchè proprio contro la persona
dell'imperatore s'acuirono le minaccie e gli sdegni; ed egli fu costretto,
dissimulando l'ira, ad uscire dalla città, recandosi nel suo campo presso
Pavia.
Lì, con
proposito di violenta reazione, convocò la Dieta del Regno, e si pose ad
amministrare la giustizia; il che voleva dire, il più delle volte, ordinare
supplizii[5].
L'arcivescovo
di Milano non volle sembrare intimidito dai precedenti, e si recò audacemente a
prendere il suo posto nella Dieta. Ma l'agguato non si fece aspettare.
Investito violentemente da un feudatario tedesco per non so che ragioni
concernenti la corte o borgata di
Lecco, Ariberto chiese tempo a rispondere, probabilmente per raccogliere
documenti; ma essendogli negato l'indugio, ricusò fieramente di giustificarsi;
e l'imperatore, che altro non aspettava, ordinò senz'altro l'immediato arresto
dell'arcivescovo. Non fu senza esitazione - pel rispetto inspirato dall'uomo e
dalla carica - che quest'ordine venne eseguito. E Ariberto, dato in custodia a
Poppone, patriarca di Aquileia, e a Corrado, marchese di Verona, fu condotto a
Piacenza, dove restò prigioniero.
Credeva
l'imperatore di avere fiaccata l'insolenza dei Milanesi, ma si accorse presto,
con danno suo, di avere semplicemente posta la mano in un nido di vespe.
Incredibile fu
la commozione che produsse in Milano la notizia di questo fatto. Le divisioni
di parte scomparvero quasi per incanto. La rottura dell'alleanza fra Cesare e
l'arcivescovo, fece di quest'ultimo il rappresentante naturale
dell'indipendenza. Milano cessò da quel momento di essere città ghibellina.
Diventò guelfa, e rimase tale, con poche alternative, fino al 1859.
I due cronisti
milanesi dell'epoca, Arnolfo e Landolfo, descrivono colla stessa foga,
quantunque appartenenti ad opposte opinioni, il dolore e l'indignazione della
loro città.
Furono due mesi
di lutto, durante i quali le gentildonne e le popolane si stemperarono in pianti,
in elemosine, in preghiere, in processioni; mentre gli uomini ordinavano in
fretta le pubbliche cose, scombuiate dalla mancanza della mano che era solita a
muoverle.
Pensarono
dapprima a trattare collo stesso imperatore, offrendogli ostaggi per la liberazione
dell'arcivescovo; ma Corrado, poco suscettibile di scrupoli, trattenne gli
ostaggi senza liberare Ariberto. Allora i Milanesi spedirono legati in Francia
per suscitare nemici a Corrado ed offrire la corona d'Italia a Oddone di
Sciampagna. E intanto altri fra i più nobili cittadini s'erano diretti ai conti
e ai vescovi delle altre parti d'Italia, sollecitando una lega che avrebbe
avuto per iscopo immediato la liberazione del grande arcivescovo, e per iscopo
ultimo l'emancipazione dei comuni italiani dall'alto dominio germanico.
S'era nel più
fitto di queste pratiche, quando, con immensa gioia del popolo milanese,
ricomparve Ariberto, libero in mezzo a' suoi. Gli era bene riuscito uno
stratagemma. Per mezzo d'un monaco, suo fedelissimo, Albizzone, s'era fatto
inviare nel carcere dall'abbadessa d'un monastero di San Sisto, consacrata da
lui, gran copia di provvigioni e di ghiottornie. Posta ogni cosa a disposizione
de' suoi custodi, questi, com'era facile prevedere, s'ubbriacarono
saporitamente; e, durante il loro sonno, potè Ariberto, aiutato dal previdente
Albizzone, uscire dal carcere, attraversare il Po in una barca, e giungere,
fanatizzando tutti, a Milano.
Qui comincia
l'epoca più pura e più grande nella vita di Ariberto da Intimiano. La lotta che
Milano sostenne nel 1037 contro Corrado il Salico, lotta di cui Ariberto
capitanò tutto lo svolgimento e quasi tutti gli episodî, non è inferiore nè di
magnanimità nè di gloria a quella che sostenne un secolo dopo contro Federico
Barbarossa. Direi anzi che in questa furono più alti gli animi, più compatte le
volontà. E se di quella i risultati politici furono italianamente maggiori, non
bisogna dimenticare che a Legnano ed alla pace di Costanza avevano contribuito,
oltre Milano appena rifatta, le forze della Lega Lombarda, gli aiuti dei
marchesi di Dovara e di Romano, le influenze di papa Alessandro III e della
repubblica di Venezia. Nulla invece di tutto ciò confortava Milano nel 1031.
Quando Corrado, irritato per la fuga del suo prigioniero e sitibondo di
vendetta, venne a porre il suo esercito intorno a Milano, aveva per sè quei
contingenti delle città lombarde e quelle influenze papali che triplicavano
l'isolamento materiale e morale della minacciata città.
Questa però,
piena di fede nell'uomo energico che governava nel tempo stesso i suoi
interessi materiali e i suoi sentimenti religiosi, si atteggiò a disperata
difesa contro un'offesa implacabile.
Le mura di
Ansperto, e le trecento torri da cui facevano buona guardia i suoi difensori,
impedirono che i nemici penetrassero nella città; ma Corrado, in ciò non
peggiore de' suoi precursori e dei continuatori suoi, fece il deserto nei
sobborghi e nel contado. «Eo tempore» scrive Vippone fedelissimo suo «imperator
Mediolanenses nimium aillixit; et quoniam urbem antiquo opere et maxima
multitudine munitam capere non poterat, quod in circuito fuerat igne et gladio
consumpsit.»
Il 19 maggio,
Corrado tentò l'assalto. Non solo fu ributtato, ma i Milanesi, uscendo
audacemente dai terrapieni, si azzuffarono coi Tedeschi in una battaglia
campale, dove si distinse pel suo coraggio un Eriprando Visconti.
Riuscitagli
male la violenza, l'imperatore sperò nell'insidia; e, senza convocare nessuna
Dieta, promulgò dal suo campo quelle leggi che da Germania aveva promesse;
mediante le quali, emancipando i piccoli feudi dai maggiori vassalli, gettava
un tizzone di discordia fra gli alleati dell'arcivescovo, i Capitani e i
Valvassori.
Il tizzone si
spense senza dar fiamma. Il sentimento patriottico, quantunque allora si
trattasse di patria piccola, era già più forte d'ogni seduzione straniera.
Ariberto rispose a quei decreti, mutando radicalmente le basi della pubblica
difesa; disciplinando al servizio delle armi i popolani; i quali trassero dalla
nuova dignità del combattere gli elementi di una virtù civile, ormai da secoli
soffocata nei loro animi.
L'imperatore
cercò allora, contro l'indomito prelato, l'appoggio della tiara pontificale; e
si abboccò a Cremona con papa Benedetto IX, di sciagurata memoria. Da quel
convegno uscirono per Ariberto due fulmini; la sua deposizione dalla sedia
arcivescovile alla quale fu nominato un prete Ambrogio, e più tardi la
scomunica pontificia: l'affetto dei Milanesi mantenne ad Ariberto la dignità
episcopale, che invano Ambrogio cercò carpirgli; e la pessima riputazione di
Benedetto IX impedì che alla sua condanna ecclesiastica si attribuisse il
consueto prestigio. Quanto a Corrado, si trovò pagato della stessa moneta. Chi
lo aveva di moto proprio incoronato, di moto proprio lo scoronò. Ariberto fece togliere
dagli atti pubblici ogni data imperiale, dichiarò Corrado decaduto dalla
dignità regia in Italia, ed invitò Oddone di Sciampagna ad assalire
l'imperatore in Germania.
Questi allora,
imbestialito per un'audacia che si sentiva impotente a punire, e costretto a
ricondurre oltre l'Alpi un esercito stremato dalle battaglie, dalle epidemie e
dalle faticose marcie lungo la penisola, radunò tutti i principi vassalli
dell'Italia settentrionale e fece loro giurare di devastare ogni anno il
territorio milanese, affinchè la ribelle città, non domata dalle armi, dovesse
arrendersi per la sofferenza e per la fame.
I principi
giurarono; e nel successivo anno 1039 mantennero la parola, presentandosi con
forze nuove e imponenti nelle vicinanze della città. Ma Ariberto non aveva
perduto il suo tempo. Durante i mesi d'inverno, la riforma politica e militare
da lui ideata s'era svolta in maggiori proporzioni. Ai popolani del contado
aveva fatto balenare quelle stesse idee di patria, di resistenza e di
emancipazione, colle quali aveva affascinato i popolani della città. Armi ed
ordigni di difesa s'erano fabbricati in gran numero, e l'arcivescovo ne
distribuiva a tutti, disciplinando, come oggi si direbbe, a leva in massa tutta quella moltitudine,
chiamata dalla voce di un forte, che era nel tempo stesso Davide e Samuele, a
riacquistare quella libertà che gli avi imbelli avevano perduta: «pro libertate
aquirenda præliante, quam olim parentes ejus ob nimiam hominum raritatem
amiserant»[6].
Nè bastava.
Poichè Ariberto, profondo conoscitore dei suoi tempi e del popolo suo, comprese
che a radicare l'idea nuova ed astratta della patria in quelle menti avvezze a
forme simboliche, era mestieri identificarla in un simbolo nuovo. Ed inventò il
Carroccio; singolare e primordiale
istromento di guerra, destinato a diventar subito popolare in tutte le italiane
città; curioso emblema di superstizione, di fede, di poesia popolare e di
disciplina guerresca; immagine fantastica della religione e della patria, strette
a comune difesa; carro di vittoria e altare di pace, intorno a cui si
combatteva con energia, si moriva con entusiasmo.
Così
risollevati a nuova vita materiale e morale, i popolani lombardi provvidero
energicamente alla difesa dei loro abituri; e la sconfitta dei grandi vassalli
imperiali sarebbe stata disastrosa, se non fosse giunta notizia della morte
dell'imperatore Corrado in Utrecht; notizia che bastò a far cessare la lotta ed
a sciogliere l'esercito dei coalizzati feudali.
Qui comincia la
terza ed ultima fase del rinnovamento politico milanese.
L'insurrezione
dei Valvassori aveva scosso nel sentimento pubblico il prestigio del
feudalismo; la difesa contro l'Impero aveva reso popolare il bisogno
dell'indipendenza; non mancava che un movimento diretto ad assicurarsi
l'esercizio delle libertà comunali. Questo movimento tardò tre anni, ma dal
1042 al 1045 mutò radicalmente la costituzione politica di Milano.
Un valvassore,
per privata contesa, aveva ucciso un plebeo. Non era fatto strano, e novanta
volte su cento, prima d'allora, sarà rimasto impunito. Ma la plebe non era più
il gregge pauroso e servile, che accettava la sferza del padrone, chiunque si
fosse. Aveva combattuto insieme ai nobili contro Cesare, e acquistato quindi un
certo sentimento di eguaglianza civile. Non sopportò più di riconoscere in
tanti concittadini quel diritto di oppressione che negli antichi Duchi le era
parso quasi legittimo[7].
Aveva imparato tre anni prima l'uso delle armi; le impugnò nuovamente, e scese
nelle vie, deliberata a combattere le classi nobiliari e mettere fine alla loro
anarchica prepotenza[8].
Fu una lotta
epica; durata tre anni, e che finì, dice Arnolfo, «con una profonda mutazione
nello stato della città e della Chiesa.»
La guerra
civile non era mai apparsa in Milano così feroce, col suo sinistro codazzo di
stragi, di vendette e di devastazioni. Fino dai primi giorni, il furore fu tale
che non si dette quartiere. I popolani dovevano essere certamente dieci volte
più numerosi dei nobili; ma questi avevano per sè le armature complete, i
cavalli in assetto di guerra, le feritoie dei loro palazzi di pietra, la più
profonda cognizione degli ordini militari. Sicchè, malgrado la sproporzione
numerica, i primi combattimenti non erano riusciti favorevoli all'insurrezione;
la quale probabilmente sarebbe stata repressa e domata, se un uomo, uscito da
tutt'altre schiere, non le avesse dato il potente aiuto del suo valore e della
sua virtù.
L'uomo si
chiamava Lanzone; non è facile darvene notizie maggiori, per quanto si tratti
di uno dei più grandi caratteri del secolo undicesimo.
S'è saputo, o
s'è congetturato solamente dugent'anni dopo, che appartenesse alla famiglia Da
Corte, famiglia prolungatasi nell'aristocrazia lombarda fino all'epoca degli
Sforza. Un solo cronista s'è occupato con qualche precisione di lui;
fortunatamente è un cronista vissuto a Milano nella seconda metà del secolo
undecimo, Landolfo il Vecchio; ed è su quelle indicazioni, confermate nelle
particolarità sostanziali dal cauto e severo linguaggio di Arnolfo, che una
critica perspicace e affettuosa ha potuto, negli ultimi tempi, trarre l'uomo
dal mito e riprodurre, innanzi ai contemporanei, che le potrebbero utilmente
copiare, le fattezze di questo magnanimo del tempo antico.
Può dunque
ritenersi per assodato:
Che Lanzone
apparteneva alla più alta nobiltà feudale (nobilis et Capitaneus altus) ed alla
più importante magistratura del Ducato, come giudice del sacro palazzo;
Che,
determinato a impedire lo sterminio di cui la parte aristocratica minacciava,
vincendo, la plebe ribelle, si gettò nel tumulto contro i proprî amici, assetati
di vendetta, e fu eletto per unanime fiducia Capitano del popolo;
Che,
riprendendo l'offensiva, seppe guidare le schiere insorte con tanto vigore e
tanta sagacia da obbligare i nobili, di qualunque grado, ad uscire
nascostamente colle loro famiglie, dalla città;
Che avendo i
nobili fuorusciti, coll'aiuto dei conti della Martesana e del Seprio, posto
l'assedio intorno a Milano, questa sotto la guida di Lanzone, resistette per
quasi tre anni a tutti gli orrori della guerra e della carestia, combattendo
quasi ogni giorno ed opponendo ad offese formidabili sapienti difese;
Che, mosso da
un duplice concetto, militare e politico, Lanzone si recò, sullo scorcio del
1043, in Germania, dove stipulò coll'imperatore Enrico il Nero un trattato
d'alleanza, basato sopra un eventuale intervento di milizie tedesche in Milano;
Che, ritornato
fra i combattenti e ripensando al pericolo di questo intervento, aperse
trattative coi nobili fuorusciti, comunicando loro il patto di alleanza e
persuadendoli della impossibilità in cui si sarebbero trovati di resistere ad
un duplice assalto;
Che, avuta
facoltà da entrambe le parti, di proporre condizioni di pace, esortò i nobili a
rinunciare per sempre al dominio della città, a rientrare pacificamente nei
loro palazzi, accordando e ricevendo ampia amnistia per le reciproche violenze
di guerra, e impegnandosi a discutere tranquillamente con tutti gli altri
cittadini i comuni interessi;
Che, accettate
queste condizioni, i nobili si rassegnarono a smettere le loro pretese alla
supremazia politica e ritornarono, in dimessa attitudine, nella città;
Che, per
iniziativa di Lanzone, furono subito discussi, in un comitato di arbitri, gli
ordinamenti necessari per attivare, sulle nuove basi, il governo della città;
ordinamenti che poterono essere intralciati, interrotti e ripresi, ma che
finirono per ottenere la formale adesione dell'imperatore Enrico III; il quale
li sanzionò e li fece entrare nel diritto pubblico del Regno alla solenne Dieta
che tenne nei prati di Roncaglia il 5 maggio dell'anno 1055.
Così sorse in
Milano il comune autonomo, che ebbe poi non breve e non ingloriosa esistenza.
Certo, istituzioni consimili non hanno mai una data precisa di battesimo
storico. Ned io vorrei discutere se proprio l'anno di nascita del comune milanese
sia il 1042, nel quale i nobili furono cacciati dalla città, o il 1045, nel
quale rientrarono, assoggettandosi ai nuovi patti, o il 1055, nel quale gli
Statuti comunali furono riconosciuti dalla suprema rappresentanza del Regno, o
magari il 1066, nel quale pare che questi statuti fossero pubblicati.
Se non
vivessimo noi in tanta luce di pubblicità multiforme, forse fra dieci secoli i
nostri posteri disputerebbero se l'anno del risorgimento italiano sia stato il
1848 o il 1859 o il 1860 o il 1866 o il 1870. Le grandi mutazioni organiche
hanno fasi e fremiti e oscillazioni, che abbisognano di tempo per tradursi
nella soluzione tranquilla. Ma nè dieci, nè venti, nè trent'anni rappresentano
in questi casi più che un momento storico. E quando dall'unità dei pensieri e
degli sforzi si rileva chiaro uno di questi momenti, poco importa se la loro
durata non coincide esattamente col numero dei giorni nei quali la terra suol
compiere la sua evoluzione intorno al sole.
Nel fato di
Milano, oltre il momento storico, anche il processo storico appare evidente.
Dapprima la
conquista barbarica, che distrugge lo Stato e vi sostituisce il regime
anarchico della feudalità.
Poi, con Ottone
I, il despotismo intelligente, che è il periodo primordiale del rinascimento
politico. Il popolo vede un tiranno solo più forte dei molti di cui si lagnava;
e ingenuamente gli batte le mani, come ad un liberatore. È il trionfo della
politica ghibellina.
Succede, con
Ariberto, il potere arcivescovile. Il despota v'è ancora; ma, oltre ad essere
intelligente, è indigeno, è vicino, è mite per l'indole sua, comincia a trarre
dalle forze e dalle volontà popolari elementi di amministrazione e di governo.
E il popolo accetta il dominio di Ariberto con entusiasmo, persuaso che valga,
più di quello del lontano imperatore, a frenare le intemperanze rinascenti dei
vecchi despotismi feudali. È il trionfo della politica guelfa.
Ma ad Ariberto
non basta l'animo di continuare l'iniziata opera di emancipazione; e, dopo la
vittoria contro Corrado, ricade nella tradizionale alleanza coi feudatari
maggiori.
E allora il
popolo, fatto maturo dall'esperienza e dai casi, reclama la libertà come unica
guarentigia di ordine e di benessere. Compare Lanzone, che non è nè guelfo nè
ghibellino, che nell'ordine dei progressi politici è più grande di Ariberto e
di Ottone, e che della sua immensa popolarità si giova per annullare sè stesso
e per sostituire al potere personale l'universalità dei cittadini, disciplinati
a comune sovrano. Il genio sparisce; ma la sua necessità è minore, perchè è
sorta l'istituzione. L'emancipazione civile ha raggiunto la sua ultima formola.
Che poi,
malgrado questa e malgrado la magnanimità di Lanzone, periodi di anarchia o di
dominio personale abbiano ancora turbata per qualche tempo la risurrezione
politica della cittadinanza milanese, ciò non basta a sfatare la benefica
rivoluzione compiutasi in quel momento istorico. Il diritto è stato
riconosciuto; la legge è stata promulgata. La violenza, dopo ciò, rimane, se
anche vincitrice, un fatto transitorio, di cui la legge e il diritto non
tardano a ottenere riparazione. Anche il ladro ruba; ma il giudice che lo
condanna dimostra come la proprietà fosse inviolabile prima del furto e tale
rimanga dopo.
Più di otto
secoli sono corsi dagli avvenimenti che vi ho ricordato, ed è lecito chiedersi
se a quelli proprio risalgono gli albori della moderna vita italiana.
A me pare
indubbiamente che sì.
Il carattere
italico, la reazione del romanesimo contro la lunga iliade di spogliazioni e di
umiliazioni inflittegli dalle razze teutoniche, appare evidente, a misura che
gli antichi servi, assaporando nuove forme e nuove ragioni di vita, si
raccozzano dappertutto per iscuotersi di dosso il giogo degli antichi padroni.
Ogni comune è una patria; ma da ogni comune si sprigiona un sentimento nuovo,
che vorrebbe quasi trarre dal ricordo del potente organismo a cui tutti avevano
appartenuto, gli elementi d'una solidarietà che ancora non s'è fatta nazionale,
ma che già respinge e sconfessa dominî non nazionali.
Già ad Ariberto
era parso e giustamente un principio di rivincita, che armigeri italiani si
recassero oltre l'Alpi a spiegare vittoriose quelle bandiere che erano state
tante volte calpestate al di qua. E Lanzone, ai nobili che vuol convertire
all'idea comunale, parla addirittura «dell'esempio che dovrebbero dare ai loro
eguali in tutta l'Italia». Qui, il
discendente dei conquistatori goti o longobardi è già divenuto civis romanus e sente l'orgoglio di
essere figlio e difensore di quella terra che i suoi avi hanno riempiuto di
desolazioni e di stragi.
Un passo di più
ed avremo Cola da Rienzi, sublime fantastico, che purga Roma di baroni, e di
banditi, ricostituendo, nel più fitto delle tirannidi indigene, il Tribunato
dell'antica Repubblica. Poi, dugent'anni dopo, vedremo un gran politico
fiorentino ritornare al sogno del desposta intelligente, purchè si chiuda nel
pugno tutta l'Italia e spenga, con milizie italiane, i principotti indipendenti
innalzatisi sugli indipendenti comuni. Passeranno altri cent'anni, e udremo la scuola
politica dei letterati inneggiare all'Italia coi sonetti del Filicaja e colle
canzoni di Gabriele Chiabrera. E ancora dugent'anni dopo, il Mazzini scriveva
al discendente di Umberto Biancamano: «Fate l'Italia, e saremo con voi.» Sarà
toccato in sorte alla nostra generazione di vedere il meriggio di quegli albori
del mille; Vittorio Emanuele II che ricompone in Roma l'asse ereditario
usurpato da Odoacre; Lanzone, che rigetta ad un tempo l'autorità di Cesare e
quella di Ariberto, e chiama il popolo italiano a ricostituirsi in comune
indipendente.
Questo filo
conduttore di una italianità, che attraverso i secoli viene sempre più
accostando fra loro gli uomini d'azione e gli uomini d'intelletto, ci aiuta a
difenderci dalle eccessive induzioni di una scuola storica, di cui Carlo Hegel
è il più formidabile campione.
Secondo i
critici di siffatta scuola, non è dall'idea romana, o latina, o italica che è
sorto il comune lombardo del secolo undecimo; bensì da una evoluzione intima
del concetto germanico, che a poco a poco innalza le plebi romane,
beneficandole coll'autonomia.
Non è qui nè da
me che può essere utilmente discussa una questione così profonda. Però mi sia
lecito dire che il voler attribuire propositi di emancipazione popolare a
quegli stessi elementi dominatori che dieci anni prima avevano promulgato il
codice del feudalismo, addita piuttosto lo sforzo dell'ingegno che la severità
della logica. Queste lancie d'Achille, atte a guarire le piaghe che cagionano,
perdono un po' di fede al difuori della poesia mitologica.
Sarà meno
scientifico, ma è certo più semplice il criterio che attribuisce ordinariamente
agli oppressi qualche merito nella sconfitta degli oppressori.
E la Germania
ha una parte troppo gloriosa nella storia del mondo perchè non debba permetterci
di ascrivere a virtù di resistenza italiana piuttosto che a virtù d'iniziativa
tedesca una rivoluzione comunale che si è manifestata collo sgominare due
eserciti tedeschi, quello di Corrado il Salico e quello dell'imperatore
Barbarossa.
LE ORIGINI
DELLA MONARCHIA IN PIEMONTE
DI
Romualdo
Bonfadini
Chi volesse
trovare in Europa qualche analogia possibile, in qualsivoglia argomento, tra le
condizioni odierne e quelle di nove secoli fa, si accingerebbe a ben duro e
disperato mestiere.
Mutata l'indole
dei governi e dei sodalizi religiosi; rinnovate le teorie del diritto e le basi
della legislazione; divenuti predominanti migliaia d'interessi, onde allora non
si sospettava pur l'esistenza; capovolte addirittura le fondamenta del
consorzio civile, ci abbisogna uno sforzo gigantesco d'immaginazione per
riprodurre anche in minima parte, dinanzi al nostro sguardo intellettuale, i
fenomeni di una umanità, che sembra avere coll'umanità contemporanea quella
stessa parentela, di cui una scienza evoluzionista moderna si compiace trovare
le traccie, per esempio, fra un chimpanzé ed una bella signora.
Non parliamo
poi dello stato territoriale, della geografia politica dell'Europa. Appena si
salvano i nomi grossi e complessivi d'Italia, di Germania, di Britannia. Regni
sostituiti a repubbliche e repubbliche a regni; città non ancor nate e città da
un pezzo sparite. V'era una Spagna senza Spagnuoli, v'erano degl'Ungheri senza
un'Ungheria, v'erano i Franchi prima che la Francia apparisse. I popoli, così
teneri ora dei loro confini e dei loro territori, erano qua e là sbalestrati da
convulsioni capricciose; i Normanni diventavano Siculi; i Saraceni
s'appollaiavano sulle creste degli Abruzzi e delle Alpi Cozie. Cento
rivoluzioni hanno scombuiato conquiste e conquistatori, hanno menato nella loro
rapina Stati, famiglie e dominii; sicchè oggi, quasi nel 1900, nulla appare più
falso di ciò che era l'unico vero nel mille.
V'era però una
stirpe, che ha resistito all'onda dei secoli e al vituperio dei nomi. V'è una
famiglia sovrana - l'unica in Europa - che ha questo privilegio di poter
guardare da qualcuno de' suoi castelli reali il territorio circostante, e di
poter dire che dal mille in poi hanno continuato ad esercitare su quello
autorità principesca i suoi antenati, legittimamente succedutisi colla propria
discendenza e col proprio nome.
Questa famiglia
- l'avete senz'altro indovinato - è la famiglia dei principi italiani; i quali
non trovano, nelle valli di Susa e di Aosta, nessun nome che rompa, fosse per
un giorno, l'eco tradizionale del loro grido dinastico; i quali firmano nel
1890 Umberto di Savoia come firmavano
nel 1003 Hubertus comes «in agro
savogensi»; i quali, con privilegio sovrano, battevano moneta nel mille ad
Aiguebelle, come battono moneta a Roma nel 1890.
È forse questa
antichità e continuità di dominio che ha fatto delle origini della dinastia di
Savoia l'argomento caro ad un nugolo di scrittori, impeciatisi nell'esame di
pergamene, che a ciascuno parevano conferma di sistemi diversi e di induzioni
opposte.
Io non
trascinerò - non temete - le vostre mani gentili entro i polverosi scaffali
dove quelle pergamene hanno riposato per tanti secoli inesplorate. Ma,
costretto dalla fatalità mia e dalla vostra a sostituire qui il brillante
oratore[9]
che avrebbe dato ai suoi veri tutto il fascino dell'estetica e della poesia,
cercherò di non dare alla storia maggiore severità di quella che si accompagna
necessariamente alla fisonomia dell'epoca ed alla precisione dei fatti.
Fra i popoli
migratori che, nella prima metà del medio evo, scesero da regioni ignorate nel
mezzogiorno d'Europa, i Borgognoni furono senza contrasto i meno numerosi e i
più miti. Guerrieri per difesa, piuttosto che per conquista, la sorte li aveva
spinti nel grande bacino del Rodano dove s'erano acclimatati. In lotta coi
Franchi e più volte sconfitti, non lo furono però mai tanto compiutamente da
far perdere al territorio da essi occupato il nome della loro razza e
l'impronta delle loro leggi. Fra queste, una specialmente apparve mirabile per
ispirito di politica tolleranza e fu la legge
Gombetta (Gundobada), che pare sia stata liberamente discussa in pubblica
assemblea[10].
Per quella legge, nessun vinto era obbligato ad accettare il diritto pubblico
dei vincitori. Ciascuno dichiarava di voler vivere sotto la legislazione che
preferiva; sicchè i giudici erano obbligati, prima di pronunciare sentenze, a
chiedere ai convenuti sotto che rito intendevano di essere giudicati.
Questa
larghezza di regime civile, di cui non appare nessun esempio nei paesi caduti
in balìa dei Longobardi o dei Franchi, permise alle popolazioni di razza
italica, rimasto sui versanti alpini della Savoia e della Provenza, di
stringere con invasori così moderati rapporti assai più amichevoli di quelli
che permetteva agli abitanti della valle del Po il ferreo regime sotto cui
erano mantenuti.
Così si spiega
una certa fusione fattasi più presto che altrove, fra gli antichi elementi
romani e i nuovi elementi della stirpe borgognona. La feudalità fu istituita
anche in Borgogna, come dappertutto dove passarono gli eserciti dei Carolingi;
ma non ebbe lì quel carattere acerbo di sovrapposizione dei conquistatori sui
vinti. Sicchè la diversità di razza non impedì che sorgessero a potenza e
dignità feudale anche famiglie discendenti da stirpe italica; le quali
continuavano a reggersi in ogni altra parte dei diritti civili e pubblici,
secondo la legislazione romana, garantita dalle istituzioni organiche del
popolo borgognone.
Fra queste
famiglie, una appare già illustre e potentissima alla corte di Borgogna, negli
ultimi anni del decimo secolo e nei primissimi dell'undecimo. E di questa
famiglia i più antichi documenti dell'epoca ci rivelano capo e personaggio
preponderante negli affari politici del Regno un conte Umberto, che la cronaca
di Hautecombe designa coll'aggiunta blancis
manibus; vuoi perchè una speciale gentilezza fisica distinguesse il gran
gentiluomo; vuoi perchè, secondo la versione, forse un po' cortigiana, di
alcuni scrittori, la sua indiscutibile riputazione di onestà fosse così alta da
doverlo celebrare come bianco e puro di mani in mezzo a tanti potenti che le
macchiavano nella preda o nel sangue.
È da questo
Umberto Biancamano che discende, per genealogia accertata e non interrotta più la
famiglia di principi, che ci onora della sua rettitudine e che noi onoriamo del
nostro affetto.
Che se voi
desideraste sapere intorno a siffatto capostipite, più antiche notizie; se mi
chiedeste, come Farinata all'Alighieri: chi
fur li maggior sui, potrei rispondervi con cinque congetture, non vi darei
una sola certezza. Al di sotto del Biancamano, tutto a poco a poco diventa
facile, chiaro, ricco di particolari e di prove; al di sopra tutto è buio,
ipotesi, immaginazione. Come il Nilo, la casa di Savoia nasconde le sue
scaturigini in una regione fantastica, dove i nuovi Argonauti non giungono a
penetrare. Però ciò non impedisce al gran fiume di versare, innanzi alla sua
foce, i larghi beneficii del suo limo fecondatore; come non ha impedito alla
nobile dinastia di avvincere a sè stessa col prestigio del bene quei «volghi
dispersi» che non avevano un nome, e che non le chiedono d'onde venga, ma sanno
dove va.
Non mancarono
gli storici cortigiani. Alcuni, pur di trovare un re ed un eroe al vertice
della piramide, fecero risalire gli antenati del Biancamano a quel sassone
Vitichindo, che mise per un istante in forse la gloria di Carlo Magno. Altri si
fermarono al re, se non all'eroe, e innestarono la casa di Savoia su quel
tronco laterale della dinastia franco-borgognona, che ebbe in Lodovico il Cieco
un così inetto e così infelice imperatore. Altri finalmente posero ad
obbiettivo delle loro ricerche un'origine nel tempo stesso regia ed italiana,
facendo discendere il conte Umberto da quella razza dei Berengari d'Ivrea, che
furono, per la loro violenza, così disformi dal tipo umano e leale dei principi
di Savoia.
Oggidì tutte
queste opinioni sono sfatate. E non è neanche necessario, per esserne persuasi,
di svolgere i cinquanta volumi, in cui queste ipotesi sono discusse, affermate
ed escluse. Il che prova, per incidenza, come non debba temersi quel pericolo,
che fra alcuni anni non basti la vita di uno studioso ad approfondire neanche
uno dei rami dello scibile umano. No, la scienza è rimedio a sè stessa; ricerche
nuove, pur di piccola mole, bastano a rendere inutili i volumi, farraginosi di
ricerche antiche; sintesi logiche e verità elementari si sostituiscono con
autorità indisputata alle faticose lungaggini di analisi non ravvivate dal lume
critico. Basta ai nostri contemporanei - e i nostri posteri saranno in ciò più
fortunati di noi - assai meno tempo di quello che dovessero impiegarvi gli
antenati nostri, per accertare storicamente la verità e le proporzioni dei
fatti. Ogni scrittore coscienzioso abbrevia la via; sicchè la scienza che è
stata aristocratica fino ai padri nostri, potrà essere democratica fra
cinquant'anni.
Ecco perchè
quattro o cinque volumi pensati, dei più moderni, bastano a sostituire, in
questo argomento, le voluminose compilazioni dei tempi andati, e a persuaderci
che, fino a nuove scoperte di documenti difficili a presagire, il padre di
Umberto Biancamano resterà, come Giove, col capo avvolto fra le nubi.
Nè di questa
relativa impotenza dell'indagine storica possono sembrare eccezionali i motivi.
A buon conto,
quanto più ci avviciniamo all'epoca delle invasioni barbariche, tanto più scema
il numero degli scrittori e la probabilità che le carte siano sopravvissute
alle ingiurie del tempo. Appena si riesce ad accertare l'ordine cronologico dei
Papi e dei Sovrani, intorno ai quali si concentrava l'attenzione e l'adulazione
dei cronisti. Di Umberto Biancamano anzi si conosce assai più che non si
conosca di personaggi anche maggiori dell'epoca sua.
D'altronde,
nell'incendio di Susa, avvenuto per opera del Barbarossa nel 1174, si vogliono
distrutti gli archivi privati della casa di Savoia[11],
nei quali stavano probabilmente i pochi documenti autentici e gli alberi
genealogici della famiglia. Costretti a rifare questi ultimi per debito
d'ufficio e per vanità di dottrina, i cronisti famigliari non poterono
raccogliere carte equipollenti che fino ad Umberto I e dovettero ricorrere, per
completarli, al metodo pericoloso delle induzioni. Ma allora si trovarono di
fronte alle difficoltà ermeneutiche ed alla confusione dei nomi. Gli Umberti,
gli Adalberti, gli Oddoni, gli Amedei, i Rodolfi, le Adelaidi e le Ermengarde
suonavano frequenti al di qua come al di là delle Alpi. Uno storico che
s'aggiri in mezzo a questi nomi per trarne identità di personaggi e di epoche,
ci arieggia troppo quel Polifemo cieco, che palpa il vello dei montoni, sotto
il cui ventre s'è rattrappito Ulisse. Le probabilità d'ingannarsi sono
infinite; perchè nessun cronista credeva importante di dare intorno al proprio
personaggio particolari di date o di parentele o di età, che naturalmente non
erano ignote al piccolo numero di uomini pei quali scriveva. Ogni cronista
chiudeva le proprie aspirazioni e le proprie indagini nei confini del proprio
Stato; parlava de' suoi Umberti e de' suoi Oddoni, come se altri non ne
esistessero sulla superficie del globo. Tra quei piccoli principati v'erano
relazioni di commercio o di violenze, non ve n'erano di indole intellettuale o
letteraria. Sicchè nessuno pensava di identificare con particolari estrinseci
personalità notissime nell'ambiente in cui si scriveva, a beneficio di
ragionamenti, di paragoni o di ricerche future, di cui non si poteva neanche
sospettare la possibile utilità.
È perciò che
quei rispettabili eruditi, a cui duole di non poter ispingere più in alto la loro
curiosità genealogica, arrivano talvolta agli assurdi ed agli anacronismi,
brancicando fra i montoni senza mettere la mano sul mitico Ulisse. Ed è ciò che
voi ed io fortunatamente eviteremo; persuasi che oggimai troppo onore viene dai
fatti certi alla famiglia di cui studiamo i primordi, perchè si possa sperare
di accrescerlo, tuffandoci nelle ipotesi.
Torneremo
dunque, se non vi dispiace, al conte Umberto dalle bianche mani. E lo vedremo,
in cinquant'anni di storia, crescere di riputazione, d'autorità e di fortuna,
senza potergli rimproverare nessuna di quelle azioni, che sarebbero giudicate
riprovevoli dal nostro criterio morale, tanto più austero di quello che allora
prevaleva.
Alla corte di
Rodolfo III re di Borgogna teneva l'ufficio di Conestabile; forse la più alta
carica militare e politica che i tempi permettessero ad un vassallo feudale.
Nel 1003 lo vediamo conte di Salmourenc nel territorio viennese; nel 1017
possiede la contea di Nyon sul lago di Ginevra; nel 1024 è già conte di Aosta,
valle cisalpina che però apparteneva in supremo dominio ai re transalpini di
Borgogna.
Questa marcia
ascendente del conte Umberto verso gli onori e i possedimenti non si deve a
nessuna di quelle violente occupazioni, così consuete ai forti dell'epoca sua;
ma unicamente a vincoli di parentaggio, a donazioni reali, giusta ricompensa
della sua condotta, che fu in ogni occasione leale e vigorosa.
Lo dimostrò
sopratutto nella crisi dell'anno 1032, in cui avvenne, per la morte di Rodolfo
III, privo di prole, la dissoluzione del vecchio reame di Borgogna.
Rodolfo III,
detto l'Ignavo, per rendere giustizia alle sue qualità intellettuali e morali,
aveva regnato per circa 38 anni, ed aveva sposato in seconde nozze una regina
Ermengarda, che pare fosse donna degna di più virile consorte.
La storia di
questo regno non è infatti che una lunga lotta fra il debole monarca e la folla
dei suoi baroni, che, prevedendo la fine della dinastia, volevano trarne
partito per affrancarsi da ogni vincolo d'investitura.
In una
situazione di questa fatta, sarebbe stato facile al conte Umberto di volgere le
influenze dell'alta sua carica contro Rodolfo e convertire in un principato
indipendente e più vasto i possedimenti che a titolo feudale teneva. Invece
stette egli risolutamente dalla parte del debole. Il Conestabile di Borgogna fu
il più assiduo compagno di Rodolfo III, il più fedele e il più energico
consigliere della regina Ermengarda. E quando il vecchio sovrano morì nel 1032
e il suo nipote Oddone di Sciampagna sorse a reclamare l'invidiato retaggio[12]
il conte Umberto rispettò il testamento, che chiamava al trono di Borgogna il
re di Germania, stretto parente di Rodolfo III; e scortò personalmente la
vedova regina, insidiata nella sua libertà, fino a Zurigo, dove l'imperatore
Corrado accolse entrambi con grande effusione e splendidi donativi.
Alla guerra che
mosse allora Corrado contro l'usurpatore dell'eredità di Rodolfo, non è certo
che il conte Umberto abbia partecipato. Ben vi concorse, e con altissimo grado,
nel seguente anno 1034, in cui Oddone, rotti gli accordi, riprendeva le armi e
raccoglieva contro il successore imperiale tutte le forze de' suoi congiunti e
dei baroni alleati suoi.
Fu allora che
Umberto Biancamano, già illustre sul versante borgognone delle Alpi per gli
alti fatti e le regie parentele, apparve anche sul versante italiano
personaggio di molta autorità e di intera fiducia.
Poichè a lui,
come al più rinomato capitano d'allora, affidarono il comando di un forte nerbo
di truppe i due potenti alleati dell'imperatore in Italia, Bonifacio marchese
di Toscana ed Ariberto arcivescovo di Milano.
I quali pare
che conducessero personalmente il loro esercito fino ad Aosta, ai piedi del
Gran San Bernardo, e che lì ne assumesse il conte savoiardo la direzione.
Certo, capitano e soldati si condussero, in quella guerra, con molto e
fortunato valore. Se dobbiamo credere ad uno storico non italiano, il signor
Frézet[13],
fu anzi in una battaglia comandata dal conte Umberto che Oddone di Sciampagna
restò prigioniero e fu condotto a' piedi dell'imperatore Corrado, il quale
generosamente gli perdonò.
Ciò non tolse
che poi, con una seconda slealtà, questo Oddone scendesse in campo nuovamente
contro Corrado, approfittando dei torbidi scoppiati tre anni dopo in Lombardia.
E qui si trovò a fronte di Gozelone, duca di Lorena, il quale lo affrontò e lo
uccise. Ma da questa lotta per la successione borgognona uscì Umberto
Biancamano con altro e largo aumento di gloria e di potere.
La parte
ch'egli sosteneva aveva trionfato. La Borgogna era divenuta ciò che il
testamento di Rodolfo III aveva ordinato, un dominio aggiunto ai re di
Germania. Ma questi, in continua lotta cogli Slavi, cogli Ungheri e coi Comuni
italiani, non potevano dedicare troppo tempo alla pacificazione ed
all'ordinamento del nuovo dominio. Dovettero quindi affidare ad altri
l'importantissimo ufficio, e nessuno parve a ciò più adatto del conestabile
Umberto, l'intelligente e fedele amico della regina Ermengarda, nel quale gli
avvedimenti politici s'equilibravano colle virtù militari. Così il valoroso
conte, che era già stato il consigliere di Enrico II per gli affari di
Borgogna, divenne co' suoi successori, Corrado II ed Enrico III, il depositario
della loro autorità, quasi l'alter ego
del principe nei territori del regno aggiunto. Non si vede infatti che, fino
alla sua morte, altri personaggi esercitino in Borgogna azione delegata eguale
o maggiore della sua. Soltanto dopo che il suo nome scompare dalle carte e
dagli eventi dell'epoca, s'istituisce in Borgogna un organismo nuovo di
Rettorato o Vicereame, il cui primo titolare politico nell'anno 1057 è Rodolfo,
conte di Reinfelden.
È in questo
ventennio, fra il 1035 e il 1055, che la casa Umbertina grandeggia e comincia a
pigliare andamenti e diritti di sovranità indipendente. I favori imperiali
piovono su di essa, a misura che il loro capo consolida, colla sua forte e
savia amministrazione, la riunione della Borgogna all'Impero. Quindi, l'alto
dominio sulla valle di Maurienne, la contea di Belley, il Chiablese, la
Tarantasia, i castelli di Morat e di Chillon, una gran parte del basso Vallese
vengono ad aggiungersi, per donazione di principe, agli antichi possedimenti
del conte Umberto. La famiglia savoina viene sempre più risalendo i versanti
occidentali delle Alpi; pensiero giusto e politico dei re di Germania, i quali,
avendo più volte a combattere nemici così nella valle del Rodano come in quella
del Po, sentono l'utilità di lasciare le chiavi del passaggio fra queste due
valli nelle mani d'un custode fedele e potente, che non se le lascerà togliere
nè da insidie nè da minaccie.
Assicurato da
questa fiducia, il Biancamano non ha più che a lottare contro giurisdizioni
vescovili, per lo più sprovvedute di titoli legittimi, e usurpate durante il
lungo e fiacco dominio dell'ultimo re, ed egli le combatte in due modi:
mostrandosi più forte dei vescovi, allorchè questi spingono l'audacia fino ad
assumere contegno di ribellione; mostrandosi più generoso di loro, nei territorî
dove la doppia giurisdizione coesiste.
Così egli è
costretto a combattere colle armi Everardo, vescovo di San Giovanni nella
Morienna, che aveva chiuso in faccia alle milizie imperiali le porte della
città. Questa venne presa d'assalto e data alle fiamme; ma, temperando gli
ordini crudeli ricevuti dall'imperatore, Umberto non permise che l'onore e la
vita degli abitanti restassero in balìa della soldatesca sfrenata, come allora
avveniva regolarmente dopo ogni successo di questa natura.
Contemporaneamente
egli largheggiava in beneficenze, in erezione di chiese e di conventi, in
donazioni a monasteri e a comuni; e siccome i prelati dell'epoca erano
d'ordinario più tenaci nell'acquistare che nel donare, la popolarità di Umberto
si veniva fondando sopra due fra i sentimenti umani più universali: il rispetto
che impone la forza, la simpatia che inspira la generosità.
Anche ne' suoi
concetti di governo, il Biancamano mostrava una larghezza d'intelletto, che
lascia presagire l'avvicinarsi della civiltà. Quel suo rispetto per la vita e
per l'onore dei vinti lo stacca nobilmente da tutta la tradizione
contemporanea, che pur troppo avrebbe trasmessa ad altri secoli la crudele
indifferenza dei Principi verso i più sacri diritti dell'umanità. E già si
affaccia alla mente di Umberto il germe prezioso della pubblica economia;
perchè appare mescolato alle trattative condotte qualche anno prima fra la
Borgogna e il savio re Canuto di Danimarca, per istringere fra i due paesi un
trattato che guarentisse ai commercianti libertà di passaggi e di scambî.
Queste le
glorie, le fortune, le opinioni del conte Umberto dalle bianche mani. Senonchè
finora sul nostro personaggio non vediamo scendere quel fato che lo farà
progenitore della dinastia italiana. Egli possiede bensì in Italia, ma
infinitamente meno che nella Savoia e nella Borgogna. Egli è soprattutto un
alto rappresentante dei re di Germania nella valle del Rodano. È un principe
borgognone ed ha sposato Ancilia, una figlia dei principi del Vallese. Occupa
la sommità delle Alpi e dispone dei tre passaggi allora più facilmente usati,
il Moncenisio, il piccolo San Bernardo e il gran San Bernardo. Ma nulla addita
che il suo avvenire lo porti a scendere piuttosto il versante orientale che il
versante occidentale di queste cime. Finalmente nel 1045 il fato smaschera le
sue batterie. Cupido s'incarica di combattere, e, come al solito, di battere
Marte. La guerra di Borgogna avrebbe potuto determinare una dinastia francese:
un matrimonio determina la dinastia italiana.
Tra le famiglie
giunte rapidamente a grande Stato sul versante alpino opposto a quello così
largamente dominato dal conte Umberto, era la più illustre, per vastità di
possessi e rinomanza di imprese, quella di cui era capo Olderico Manfredi,
marchese di Torino.
A differenza
della famiglia Umbertina, era di origine forestiera, poichè discendeva da un
soldato germanico, Arduino, venuto a cercar fortuna in Italia sui primi anni
del secolo antecedente. E la fortuna era venuta, insieme all'onore, poichè la
famiglia Arduinica era stata fra le più risolute nel combattere e nello
scacciare dalle Alpi i Saraceni: impresa che creava in quel tempo, e
giustamente, la nobiltà delle stirpi e l'aureola degli eroismi.
Alla fine del
900 troviamo già Olderico Manfredi, signore di Torino e di Susa, proprietario,
per eredità materna, di vasti dominî, posti nel marchesato di Mantova, e sposo
a Berta, figlia di un altro marchese, Oberto d'Este, signore di Genova.
Vent'anni dopo, la fine drammatica del re Arduino mette a disposizione del re
di Germania il vastissimo marchesato d'Ivrea; e questo, per singolare
benevolenza di Corrado il Salico, viene aggiunto ai dominî di Olderico
Manfredi, il quale si trova così divenuto il maggior proprietario delle valli
insubri e probabilmente l'unico personaggio investito di due marchesati in
Italia.
Poichè non era
piccola dignità nè piccola cura in quei tempi l'essere marchese.
Più dei duchi e
più dei conti, dei quali ho avuto occasione d'intrattenervi a proposito di
Milano, i «marchesi» rappresentavano quella massima forma di sovranità che era
possibile esercitare, dopo e sotto l'autorità suprema dell'impero feudale.
A Milano, e in
genere nelle città di pianura, prevalevano i conti; ma alle falde delle Alpi e
degli Appennini, d'onde calavano d'ordinario i nemici, prevaleva l'istituzione
dei marchesati, i quali raggruppavano sotto essi parecchie contee, ed erano
propriamente grandi autorità militari, destinate a contenere, a frenare o a
respingere i primi assalti di nuovi invasori. Perciò la dignità marchionale,
pur essendosi tramutata in ereditaria, come le altre dignità feudali, non era
però mai trasmessa alle donne, nelle quali non si supponeva sufficiente il
genio militare. E infatti, non sono marchese, ma contesse, quell'Adelaide e
quella Matilde, alla cui grandezza ed autorità politica s'inchinarono in quel
tempo i più potenti uomini dell'Europa.
Non erano stati
che tre in origine i marchesati istituiti da Carlo Magno in Italia: quello del
Friuli, quello di Spoleto e quello di Toscana. A dieci erano saliti verso la
fine del secolo decimo; e di questi il territorio corrispondente al Piemonte
odierno ne comprendeva soli quattro: quello di Torino, quello d'Ivrea, quello
di Genova, affidato agli Obertenghi, e quello di Savona, occupato dagli
Aleramici, intorno alla cui leggenda ha scritto un dramma così soave quel
simpatico ingegno di Leopoldo Marenco.
È facile dunque
immaginarsi che potenza e che riputazione dovesse avere il capo di una
famiglia, nella quale si trovavano congiunti due marchesati. Senza notare che
fratello ad Olderico Manfredi era il signore del potente comitato di Asti, quel
vescovo Alrico, che doveva più tardi mescolarsi nelle guerre civili di Milano e
perire fra quelle stragi.
Per Ivrea e per
Susa i dominî di Olderico Manfredi si riattaccavano, al di qua e al di là delle
Alpi, con quelli del conte Umberto Biancamano; sicchè poco dovettero tardare le
due illustri famiglie a stringere fra esse rapporti amichevoli; i quali, per fortuna loro e nostra, riuscirono ad un
matrimonio fra Oddone, quarto figlio del conte Umberto, ed Adelaide,
primogenita del marchese Olderico.
Questa unione,
avvenuta, pare, nel 1045, pose il suggello alla grandezza politica della casa
Umbertina. Questa cominciò a poco a poco a staccarsi dalle sue valli indigene
per salire alla sommità delle Alpi e di là scendere, come disse il poeta, colle
onde del Po. Da conti in Borgogna preferirono diventare marchesi in Italia;
vuoi perchè l'antica tradizione romana flagellasse involontariamente il sangue
di chi era diventato borgognone solamente a metà; vuoi perchè il sorriso del
nostro cielo e la speranza di più gentile dominio traessero quei robusti
guerrieri verso ipotesi del futuro, che il futuro non ismentì.
Dal matrimonio
di Oddone colla contessa Adelaide, rimasta erede del vasto dominio della sua
famiglia, uscirono tre figli e due figlie. Uno dei primi andò vescovo e si
appartò dalle famigliari vicende. Pietro ed Amedeo governarono dopo la morte
del padre; ma, premorti entrambi alla madre, la loro fama rimase assorbita
dall'attività e dall'autorità personale che questa seppe esercitare fino alla
morte.
Le due figlie
furono entrambe imperatrici di Germania e destinate a combattersi. L'una, Berta
di nome, sposò quell'Enrico IV della casa di Franconia, che doveva giungere a
celebrità piuttosto per la sua abbiezione a Canossa che pe' suoi trionfi a
Roma. L'altra, Adelaide, impalmava quel Rodolfo di Rheinfeld che abbiamo visto
succedere a Umberto Biancamano nella somma autorità di Borgogna, e che appunto
i ribelli tedeschi, impauriti dalla scomunica di Gregorio VII, acclamarono per
qualche tempo imperatore, contro Enrico IV, ramingo e scoronato.
Bastano questi
eccelsi parentadi a dimostrare che importanza avesse già raggiunta in
quell'epoca la famiglia dei conti di Savoia.
Il vecchio conestabile
era ancor vivo, quando la piccola Berta, nipote sua, fu promessa al fanciullo
erede del trono germanico. Nessuno dei due sposi aveva ancora raggiunta l'età
di sei anni; sicchè il matrimonio effettivo non ebbe luogo che dodici anni
dopo, nel 1067. Ma allora il Biancamano era già sceso nella tomba, che vollero
sicura ed onorata nella loro cattedrale i cittadini di Saint-Jean di Maurienne.
Singolare omaggio reso al capostipite dei Savoia da quella città che, per
ordine suo, aveva dovuto essere pochi anni prima presa d'assalto! Omaggio che
vale da solo parecchi di quei monumenti, nei quali non è riconoscenza o perdono
di popoli, ma lusso di marmi e vanità di artisti!
Il secondo eroe
della casa di Savoia è certamente la contessa Adelaide; che, in nome dei figli,
e più dei figli, e senza i figli, governò il vasto Stato fino al 1091, nel
quale anno, quasi ottuagenaria, mori. Donna di alti spiriti, di fermo consiglio
e di virile risolutezza, che assai rassomiglia all'amica ed emula sua, la
contessa Matilde di Toscana. Cara ai maggiori prelati dell'epoca, come
Ildebrando e san Pier Damiano, che le scrivevano affettuosissime lettere,
mescolava ai terreni interessi la pietà religiosa, in quella misura soltanto
che non turbasse l'intera guarentigia dei primi. Delle libertà comunali non
ebbe il sentore; anzi, non esitò a far scempio della città di Asti, appena le
parve che questa mirasse a scuotere l'alto dominio della famiglia sua. Ma in
verità, richiedere dai principi d'allora incoraggiamento ad emancipazioni
politiche sarebbe una esigenza che nessun salto storico potrebbe giustificare.
Bastava che allora i principi fossero giusti, umani, generosi, e ad Adelaide
queste virtù non mancavano. Sarebbe poi toccato all'erede e nipote suo, Umberto
II, di aiutare, alcuni anni dopo, la costituzione di comuni indipendenti; ed è
ancora una gloria per la casa di Savoia, che, nel corso dei secoli, sia stata
in Italia la prima famiglia sovrana a mettersi per questa via.
Adelaide era
già vedova da sedici anni, e da altrettanti governava, in nome de' suoi figli,
lo Stato, quando scoppiava acuta nell'alta Italia la crisi delle relazioni fra
il Papato e l'Impero.
Gregorio VII,
spinto dalla logica della sua dottrina, aveva scomunicato l'imperatore Enrico
IV, e con fiera novità, prosciolto i sudditi suoi dal loro giuramento di
fedeltà. Dal canto suo, Enrico IV, spinto dal desiderio di conservare il suo
trono, aveva fatto manifestare al terribile Pontefice il suo desiderio di
trattare con lui in qualche città di Germania.
I Papi allora
erano grandi, ma non esitavano a viaggiare fuori del loro Stato.
Gregorio VII
era già arrivato nei dominî della contessa Adelaide, diretto alle Alpi, quando
udì che l'Imperatore s'era mosso egli pure per varcarle nella direzione
opposta. Incerto sulle intenzioni imperiali, retrocedette e venne a chiudersi
nel castello reggiano di Canossa, che la contessa Matilde aveva posto a sua
disposizione. E intanto la contessa Adelaide riceveva i messaggi dell'imperiale
suo genero, coi quali la supplicava a concedergli il passaggio attraverso alle
Alpi, di cui essa era signora.
L'Imperatore
infatti, traccheggiato da' suoi rivali tedeschi, s'era visto chiusi i passi
delle Alpi elvetiche e carniche; aveva dovuto scendere a sghembo nella
Borgogna; e di lì era stato costretto a chiedere l'assenso della nobile
suocera, che poco innanzi egli aveva fieramente offesa co' suoi tentativi di
divorzio dalla virtuosa Berta.
Questa però
rimase anello di conciliazione fra il marito e la madre, come la madre stette
poco dipoi autorevole mediatrice fra l'Imperatore ed il Papa.
L'incontro
degli eccelsi congiunti ebbe luogo sulle rive del Lemano verso gli ultimi
giorni del 1076. E furono giornate terribili per geli e tormente quelli in cui
la splendida comitiva superò il Gran San Bernardo per giungere a Torino.
Parecchi servi perirono assiderati; e perchè lo stesso destino fosse
risparmiato alla contessa ed alla imperatrice sua figlia, dovettero entrambe
essere avvolte in pelli di buoi appena uccisi, e portate in siffatto abbigliamento
al piede della montagna.
Enrico IV aveva
fretta di abboccarsi col suo formidabile antagonista; sicchè non tardò a
partire per Canossa, accompagnato dalla moglie Berta, dalla suocera Adelaide,
dal cognato Amedeo, dal conte Azzo d'Este e dall'abate Ugo di Cluny.
L'episodio che
allora si svolse nel famoso castello non ha d'uopo d'essere per la centesima
volta raccontato. Rimane nella memoria dei posteri come un duplice eccesso,
che, secondo l'indole degli eccessi, non giovò a nessuno e nessun bene fruttò.
Un immenso orgoglio a fronte di una immensa umiliazione: ecco lo spettacolo che
diedero di sè ai contemporanei i due uomini che avrebbero dovuto, in tanto
infuriare di passioni e di eventi, mantenere al loro dissidio le forme austere
della dignità.
Più degli
uomini furono in quell'episodio prudenti e savie le donne; Adelaide
specialmente, che usò di tutta la sua autorità sull'imperatore di cui era madre
e sul pontefice, a cui come figlia era cara, per attutire gli sdegni,
sollecitare gli accordi e preparare riconciliazioni durevoli.
Non riuscì a
quest'ultimo scopo, poichè l'indole umana si ribella ai ricordi della violenza.
Enrico IV e Gregorio VII, si separarono col bacio sulle labbra e col fiele nel
cuore. Entrambi finirono la loro vita, lontani da quel potere che per entrambi
era stato cagione di tanto eccesso. Gregorio VII moriva a Salerno, ospite d'uno
fra quei Principi temporali[14],
sui quali egli aveva preteso di esercitare così orgogliosa supremazia. Enrico
IV moriva di crepacuore a Liegi, deposto e perseguitato dal figlio suo; triste
vendetta delle ingiurie e dei patimenti, fra cui aveva vissuto Berta di Savoia,
moglie dell'uno e madre dell'altro!
Così accade ai
violenti, sui quali, presto o tardi, scende quella giustizia, riparatrice, che
non teme nè le tiare nè le corone.
E che ai
violenti non piegasse la fronte Adelaide di Savoia, memore forse o forse
presaga della fierezza che alla sua stirpe incombeva, lo dimostra un altro
episodio, che precedette di pochi anni la sua morte.
Mentre Enrico
IV, vincitore a sua volta di Gregorio VII, occupava Roma e v'insediava un altro
Papa, s'era recata la contessa Adelaide a fargli visita; e al seguito suo s'era
aggiunto, cercando protezione, un monaco, Benedetto, abate di San Michele alla
Chiusa, che aveva tenuto nell'Alta Italia contegno favorevole al Papato contro
l'Impero.
Caduto questo
monaco, per insidie tesegli, nelle mani degli sgherri imperiali, si stava per
farne strazio, coll'esplicito assenso di Enrico, quando Adelaide, saputo il fatto,
si presentò immediatamente all'Imperatore, reclamando la libertà dell'abate
ch'essa aveva guarentito contro ogni offesa. Le prime ripulse del genero non
iscoraggiarono la contessa, che dalle preghiere passò alle minaccie. E
l'Imperatore, il quale conosceva più che altri la potenza della suocera sua, e
temeva di vedersi impedito il cammino da un esercito ch'essa avrebbe potuto
radunare al piè delle Alpi, non osò prolungare la resistenza e fece restituire
al monaco la sua libertà.
Con questi modi
e con questa indipendenza Adelaide regnava; e seguiva in ciò scrupolosamente le
tradizioni del conte Umberto, che ai deboli ed agli oppressi era stato sempre
largo del favor suo. Le stirpi hanno come i paesi, una costante fisonomia; e
come non riuscireste a trovare, fra tutti gli Stuardi, un filantropo, non vi
sarebbe possibile scovare un tiranno, fra tutti i principi di Savoia.
Quando la gran
contessa morì, una specie di guerra di successione scoppiò fra gli eredi,
presunti o legittimi, e mise a brani lo Stato.
È un fatto che
la storia non può dissimulare e che produsse conseguenze durate per qualche
secolo.
Ma ho già avuto
qui l'occasione e l'onore di dire che nei fenomeni storici di lunga evoluzione
non è già qualche soluzione di continuità che possa scemarne la verità o la
logica. La vita umana è continuamente interrotta dal sonno; eppur si ritrova,
alla fine d'ogni intervallo, piena di unità e di efficacia. Nè la vita dei
popoli è in ciò diversa dalla vita degli individui. Subisce alternative di
stanchezza o di sconfitta, dopo le quali il pensiero direttivo o l'istinto
ripigliano lo svolgimento di prima. Se ciò non fosse, sarebbe disperato lo
sforzo di cercare nella storia virtù di esperienza o insegnamenti di civiltà.
La storia diventerebbe un tumulto di fatti, una successione di violenze, in
mezzo alle quali nessun pensatore potrebbe trovare barlume di una legge
progressiva dell'umanità.
Chi pensa, per
esempio, che la storia di Roma antica non abbia uno svolgimento di mirabile
continuità, perchè i Galli poterono spingere il loro Brenno entro le antiche
mura, ed accamparvisi come padroni?
Chi crede che
non cominci da Rodolfo d'Habsburg la stirpe imperiale d'Austria, perchè dopo
suo figlio, un'altra casa di Lussemburgo ha potuto dare due o tre sovrani alle
popolazioni germaniche, lacerate dalla guerra civile?
Lo stesso fato
dominò nei primi tempi la casa di Savoia; ma essa afferrò il fato con robuste
braccia e lo vinse.
Morta Adelaide,
parve per qualche tempo che la fortuna avesse abbandonato al di qua delle Alpi,
la casa Umbertina.
Il marchese
Bonifacio del Vasto, lontano parente di quella casa, mosse subito le sue forze
contro Asti ed Albenga. Corrado, figlio dell'Imperatore e nipote della defunta
Adelaide, occupò le migliori terre della contea di Torino. Lo stesso Enrico IV
varcò le Alpi e scese con un esercito sopra Montebello. E, incuorati da
siffatte usurpazioni, alcuni fra i maggiori Comuni, come Torino e Chieri,
innalzarono bandiera d'autonomia e cercarono ritornare al dominio nominale dei
vescovi, che non sempre rispettavano le libertà onde erano proclamati custodi.
Contro queste
usurpazioni e queste riscosse era solo a lottare Umberto II, figlio di Amedeo,
rimasto giovanissimo a governare quegli Stati, retti fino allora da mani così
gagliarde e da esperienze così provette.
E cominciò
allora un secolo di contestazione e di lotte, nelle quali la casa di Savoia,
ora avanzando, ora retrocedendo, non perdette mai il rispetto alle sue
tradizioni e la fede nel suo avvenire cisalpino. Non abbandonò le prische sedi,
poichè nelle valli savoiarde e svizzere battagliò lungamente, mutando ed
acquistando terre e castella; ma tenne l'occhio fiso al dominio italiano, che
dopo il matrimonio con Adelaide Manfredi, era diventato il pernio della potenza
e la seconda patria della dinastia Umbertina.
Per molti
lustri, il successo rimane dubbio, i contrasti son fieri; v'è un'epoca, in cui
la famiglia si spezza in due rami, e sembra che scompaia l'unità della
tradizione dinastica. Ma la virtù e la sagacia suppliscono a qualche difetto di
fortuna o di energia. Non sempre giova affrontare la bufera alpina a viso
eretto. Questa vi avvolge e vi trascina giù pei burroni. Se invece, curvandovi,
lasciate passare l'uragano, rimanete al vostro posto e potete rizzarvi più
forte e più sicuro di prima.
È quello che
hanno fatto tante volte i principi di Savoia, riprendendo, da Susa o da Ivrea,
il cammino verso quelle pianure che l'uragano flagellava innanzi al loro passi.
Finchè poi, una serie di principi vigorosi e fortunati, Tommaso I, Pietro II,
Amedeo V ricuperavano, aumentandolo, l'antico patrimonio della contessa
Adelaide; preparando quella grandezza militare e politica, di cui toccò il
vertice più tardi il grande Emanuele Filiberto.
Fu però negli
anni più aspri e più laboriosi di questa fondazione politica che si svolsero i
primi germi del programma, a cui la casa di Savoia avrebbe dovuto i suoi
trionfi italiani. Vi sono in ciò dei presagi storici, che possono sembrare
combinazioni all'osservatore superficiale, ma che forzano il pensatore alla
meditazione.
È infatti
Umberto II, che, proprio nel più fitto della guerra di successione, riconosce
l'indipendenza di Asti e stringe accordi con essa per combattere predominî
feudali. È Amedeo III che, dopo il 1130, concede a Susa il primo statuto di
franchigie comunali. È Umberto III che, nel 1175, prepara i primi accordi tra
Federico Barbarossa e le libere città lombarde. Poi, nel 1215, Tommaso I
stringe, per la prima volta, accordi politici con Milano contro il marchese di
Monferrato. E finalmente, cinquant'anni dopo, Pietro II si trova in Svizzera di
fronte a Rodolfo, allora semplice conte di Habsburg, e duramente lo batte;
singolare e provvidenziale contesa, che cominciava proprio tra il primo
fondatore della casa d'Austria e il ristauratore della casa di Savoia, quella
secolare rivalità di cui abbiamo visto forse l'ultimo atto nella guerra del
1866.
Vanti non
piccoli questi, della dinastia che ci regge; poichè, se è facile mostrare
generosità e benevolenza, durante i periodi in cui la fortuna accarezza, lo
accentuare, nell'epoca dei pericoli, quelle idee e quei propositi che poi
governeranno l'epoca della prosperità, è previdenza che non a tutti sorride, -
è saviezza che molti avrebbero dimenticata, sotto il pretesto della sventura.
Ora, è proprio
la sventura il crogiuolo in cui s'affinano le anime grandi. Ed è questa
l'aristocrazia specialissima della famiglia, di cui studiamo le origini;
aristocrazia che innalza il carattere di Umberto Biancamano quando s'incammina
a Zurigo, custode della detronizzata Ermengarda, e che innalza il carattere di
Carlo Alberto, quando s'incammina ad Oporto, per salvare colla dignità della
stirpe l'avvenire d'Italia.
Quelle
disposizioni dei primi Umberti a favore dei Comuni, appena usciti dall'infanzia
feudale; quel desiderio di creare in pieno medio evo solidarietà politiche
colla Lombardia o colla Toscana; quell'istinto che metteva contro Rodolfo
d'Habsburg i soldati d'un principe di Savoia, preannunciano fin dai secoli
oscuri le qualità che renderanno popolare, nei tempi moderni, la dinastia: vale
a dire, la fede nei principi liberali, l'accortezza nelle alleanze, il
proposito dell'indipendenza, la virtù militare, che non odia i nemici, ma non
li conta.
Se questa non è
legge istorica, non sappiamo qual sia; e in verità è difficile pensare che
altri istituti, altre compagini umane possano vantare fra le loro origini e la
fine dei loro svolgimenti eguale coerenza di tradizioni.
Umberto
Biancamano, nel secolo XI protegge i suoi nemici contro l'abitudine del
saccheggio. Pietro II nel secolo XIII adotta per motto suo: la sovranità viene da Dio, quando è
esercitata a beneficio dei popoli. Vittorio Amedeo II nel secolo XVII
spezza il suo collare dell'Annunciata per dividerne i brani fra il popolo
afflitto dalla carestia. Umberto I nel secolo XIX si tuffa nei contagi omicidi
per dare ai popolani sofferenti quel conforto che viene dalla calma, dal
coraggio, dalla fiducia.
L'unità dei
pensieri e l'unità d'istinti non potrebbero avere, io credo, più perfetta
dimostrazione.
Del resto, ad
altre dimostrazioni e ad altre unità si presterebbe l'argomento, se volessimo
discendere dai primi agli ultimi della famiglia Umbertina, o risalire dagli
ultimi ai primi.
Ma, dopo avermi
tollerato come istorico, non vorrei mi accusaste di scendere a cortigiano. Ora,
i cortigiani che sono ordinariamente accaniti ad inventare le origini delle
dinastie, sono, anche più ordinariamente, accaniti a parteciparne le decadenze.
Dio mi tolga
dunque, ora e sempre, dal numero e dall'abbiezione.
Discorrere
delle Case sovrane è stato difficile, finchè le ragioni dell'intelletto erano
soverchiate dalla prepotenza dei privilegi. Allora, nessuna logica correggeva
gli eccessi; poichè il mondo si divideva in dominati e dominatori; e, secondo
l'influsso di questa situazione personale, la storia diventava o adulazione o
calunnia.
Il regime
liberale, rendendo ai principi l'affetto dei popoli, ha reso nel tempo stesso
agli scrittori l'indipendenza e l'imparzialità del giudizio.
Oggidì che il
sovrano s'è sprofondato nelle moltitudini e vive della loro vita, adularlo
sarebbe ipocrisia, offenderlo sarebbe viltà.
Però lo
scrivere di regnanti non è facile ancora, per quanto la difficoltà abbia mutato
natura. Non è facile, perchè avviene talvolta che i cortigiani impauriti e le
democrazie soddisfatte si uniscano in un solo e intollerante grido di plauso,
attraverso al quale sembri importuna la voce severa di chi ama e teme.
Questa
difficoltà è assai minore, com'è minore il pericolo, quando si tratti di
famiglie dinastiche la cui storia rimonti alle origini della civiltà.
In questi casi
la voce dei secoli può sostituire efficacemente quelle voci contemporanee, che
diventassero troppo fioche o troppo obliose; e nella ricca e varia indole dei
numerosi antenati possono i regnanti contemporanei trovare quel senso della
misura che è la suprema saggezza dei reggitori di popoli.
Perciò mi fu
grato parlarvi delle origini d'una famiglia gloriosa nei fasti della patria; i
cui principi seppero essere quasi tutti energici senza tirannia, buoni senza
debolezza, amanti di libere istituzioni senza sminuire la dignità del loro
sangue.
Se questa
famiglia avesse illustrato col suo dominio qualunque altro popolo d'Europa, i
suoi ricordi desterebbero sempre nello storico il sentimento dell'ammirazione.
Ma quando nello
storico si confondono il cittadino ed il suddito, l'ammirazione si tramuta in
un complesso di affetti maggiori e diversi. L'indagine del passato non basta
più a soddisfare l'intelletto; che vorrebbe lanciarsi nell'avvenire e cercarvi
il segreto delle inquietudini e delle speranze patriottiche.
Le une e altre
autorizza la storia nel suo viaggio di lungo corso.
Ma se il
progresso politico non è ridotto ad una formola menzognera, questa storia
dovrebbe quind'innanzi subire meno che nel passato la legge dei violenti ed il
capriccio dei casi; dovrebbe quind'innanzi riposar meno sul contrasto che
sull'armonia degli interessi molteplici.
Ora, chi pensi
quante volte questi interessi hanno trovato efficace difesa presso popoli pieni
di fiducia e presso principi degni d'inspirarla può dare nell'avvenire il passo
alle speranze sulle inquietudini.
Poichè - voi me
lo insegnate, o signore, - quando l'amore può essere nel tempo stesso un
orgoglio, diventa il più forte e il più durevole dei sentimenti umani.
LE ORIGINI
DELLA MONARCHIA A NAPOLI
DI
Ruggero Bonghi
Signore e signori,
Dante
Alighieri, lo rammentate, dice, non ricordo ben dove:
Sempre a quel
ver che ha faccia di menzogna,
Dee l'uom
chiuder le labbra quanto puote,
Perocchè senza
colpa fa vergogna.
Se questo
precetto va seguito sempre, io avrei dovuto pregare gli ordinatori di queste
letture, di volermi assegnare soggetto diverso da quello, che, ben mio
malgrado, mi son visto imporre; giacchè esso è tale che, considerato sì nelle
sue cause remote e sì nei suoi effetti lungo i secoli, ha tanto di
meraviglioso, che, quando io ve n'abbia discorso parrà a voi piuttosto favola
che storia; un soggetto, per soprappiù, che s'aggira intorno a cosa mai
esistita sino a tempi tanto prossimi che molti di noi hanno convissuto più o
meno con essa, eppure tanto passata, che duriamo fatica a ricordarla noi, e
dureremo anche maggior fatica a imprimerla nella memoria o nella fantasia dei
nostri figliuoli: la monarchia napoletana.
Di fatti, chi
di voi, cui non fosse noto, penserebbe, che, per raccontarvi le origini di
questa monarchia perita per sempre, io deva forzarvi a riportare la vostra
immaginativa sin su all'ottavo secolo d.C. e trarvi meco sino alle coste della
Norvegia: e mostrarvele, queste, pullulanti di navi, e le navi spiccarsene di
qua, di là, e scorazzar per i mari che bagnano le spiaggie della Danimarca,
della Germania, dell'Inghilterra, della Francia, e cacciarsi nei fiumi, che vi
mettono foce, e penetrare più che possono, entro terra, e mettervi a ruba e a
sacco ogni cosa, e uccidervi o portar via uomini, rapire o violare e trucidare
donne, fanciulli, e tornare a casa, ricche di preda e di gloria? Eppure, o
signore, è così. Portano un illustre nome nella storia cotesti pirati del
settentrione: Vikingi, checchè questo nome voglia dire, abitanti o assalitori
di rade. Alle lor vittime parevano corsari del mare; essi se ne dicevano re. E
re erano. Per due o tre secoli i popoli rivieraschi non ebbero difesa contro di
loro. Nè quelli soli delle regioni nominate dianzi. Giacchè entrarono
nell'Atlantico, e visitarono a quel gentil loro modo le spiaggie occidentali
della Francia, della Spagna; entrarono nel Mediterraneo e visitarono le nostre.
Udite questa. Sentirono in una delle loro scorrerie parlare di Roma, della
ricca, della grande Roma: a Roma, a Roma, fu il loro grido subito. Quivi
avrebbero messe le mani sulla maggior somma di ricchezza al mondo. Quando,
costeggiando le spiaggie orientali della Spagna e le meridionali della Francia,
furono giunti, discendendo quelle dell'Italia, a Luni, vi fecero sosta poco
discosto dalla foce della Magra, sui confini della Liguria e della Etruria, cui
aveva già reso celebre e prosperoso il porto suo, quello che ora è detto della
Spezia. Era ancora città popolosa e ricca, quantunque fosse già sul declinare,
quando verso il principio della seconda metà del nono secolo cotesti Vikingi vi
approdarono. E a essi, una città che dopo scorsi cinque altri secoli Dante
avrebbe portato a esempio delle città ite,
anzi di quelle che non ci dovevano far parere cosa nuova nè forte,
Udir come le
schiatte si disfanno
Poscia che le
cittadi termine hanno,
a essi parve
Roma: tanto grande n'era il porto. Li comandava un Hasting, e si traeva dietro
un dugento navi di quelle ch'essi chiamavano suckhar, serpenti, trakur,
dragoni, nomi di agguato e di spavento. Ai Lunesi la notizia di così triste
arrivo pervenne mentre celebravano nella cattedrale la festa del Natale e ne
furono, sì, sgomenti, ma non tanto che non corressero a chiuder le porte e
s'armassero a difesa. Hasting mandò loro a dire che non nutriva nessuna cattiva
intenzione, lui; sbalestrato dai venti, aspettava di potere andar via; per ora
implorava soltanto che gli si lasciasse vettovagliare la ciurma, e per sè,
poichè si sentiva morire, il battesimo; nient'altro. S'ebbe vino, pane, ogni
cosa; e, quanto al battesimo, entrasse pure in città e venisse in chiesa a
farvisi battezzare. Si lasciò portare: non era in grado, diceva, di camminare;
tanto si sentiva in fin di vita; e non v'era segno di verace e tormentosa
agonia che non desse. Fu cerimonia solenne; il vescovo volle celebrare la
funzione lui; gli fece da compare il conte. Ed egli scongiurava: «Pochi giorni
mi restano, seppellitemi qui, in questo luogo che m'è sì caro; seppellitemi da
cristiano.» Fu riportato alla nave. A breve andare, si sparse voce che,
diffatti, egli era morto. I suoi lo allogarono nella bara, rivestito del giaco
e colla spada al fianco; e fecero così gran corrotto, e con così alti lamenti e
grida che più non avrebbero fatto se fosse morto davvero. E se ne andarono
colla bara alle porte della città, e quivi, piangendo, scongiurando, chiesero
che lor si aprissero, e si desse riposo al cadavere del lor capitano, del lor
padre, del loro fratello colà dov'era risorto a vita di spirito. E i cittadini
acconsentirono. Apriron le porte, ricevettero il morto con grande onore. Le
campane suonavano a stormo; preti e signori, ricchi e poveri accompagnavano
processionalmente. Il vescovo cantò la messa funebre, lui. Ma ecco che, quando
fu finita ogni cerimonia, quando si fu per alzare la bara, il morto ne saltò
fuori. Com'egli era armato, così erano tutti i suoi, che erano entrati in città
e in chiesa in sua compagnia. Avevan nascosto corazze e spade sotto le cappe.
Fecero infinita strage. I primi ad avere mozzato il capo furono il vescovo e il
conte compare. Poi, usciti di chiesa, misero a ruba la città; poi la campagna.
Non seppero, se non dopo compita l'opera, che la città non era Roma. Tornarono
di dove eran venuti; e io non ve ne avrei discorso sin qui, se l'avvenimento,
che può anche non essere in tutto vero, non mostrasse le qualità principali e
costanti della stirpe, sinchè durò intatta: nessuna più temeraria, più astuta,
più crudele al bisogno, più soverchiatrice e più ingorda di essa.
Come e perchè
cotesto sciame di corsari uscisse dalla terra natìa e si spandesse da per
tutto, è facile intendere; si trovavano troppi a casa, e la casa, per giunta,
era povera. Tedeschi di stirpe, e certo cacciati dalla spinta di altre genti o
della stessa loro famiglia o di diversa in quella estrema penisola, dovevano
forse ricordare con desiderio le spiaggie perse da secoli. E vi ritornavano con
desiderio. Ma non vi ritornavano quali n'erano partiti. Nella nuova lor patria
il fragore dei ghiacciai e il tono delle valanghe, durante la lunga notte
polare rischiarata soltanto dalla fiamma sparsa dall'aurora boreale; il muggire
dell'onde sbattute dalla tempesta sulle spiaggie cavernose dei seni di mare, le
folte e scure selve, e la state che scoppia a un tratto, e riveste le roccie e
le creste dei monti della betula odorosa e verde, mentre il sole sale sempre
più alto e gitta i suoi arcobaleni sulle cascate spumanti; e il bagliore dei
raggi che si riflettono dai campi di ghiaccio, e la luce verdognola, cangiante,
che ne riempie le grotte cristalline, destavano nei lor petti una meraviglia
mesta e pensosa. Tutta la lor credenza religiosa n'era colorita e formata.
L'universo si figuravano fosse colmato tutto dall'albero dell'esistenza, il frassino
Yggdrasil, che vien su del Nifl, il regno dei morti. A' suoi piedi sgorga
gorgogliando la fonte del Mimer, e laggiù nel regno buio stanno a sedere tre
Norne, tre Parche, sorelle, l'età passata, la presente e la futura, che ne
innaffiano le radici e filano i fili dei fati umani. L'impero della terra è
diviso tra gli Asi, i buoni Iddii, che rappresentano la luce e il calor della
state, e gli Iotuni, mostri giganteschi, che figurano il gelo, la tenebra, la
tempesta di neve. Quegli abitano in su nell'Asgard; questi in giù, al buio
nello Iotum. Principale tra gli Asi è Odino, il signore del cielo e della
terra, cogli occhi di foco; il padre degli uccisi in battaglia, che gli
accoglie presso di sè nel Walhalla. E v'era altri Asi appena meno potenti. E non
mancava loro il conforto, cui niente oltrepassa, la compagnia della donna;
Frigga, moglie di Odino, Freya, la dea tutelare dell'amore, Iduna, la custode
dei pomi di cui gli Asi vivono in una giovinezza eterna, divinatrice del
futuro. Ma a cotesti benefici Iddii stanno di contro i perversi, mostri
terribili: il lupo Feuris, il serpente Midgard, e Hel. Come padre degli Asi fu
Allfadur, così degli Iotuni fu Loki. Padre e figliuoli, Odino vinse e
variamente punì; ma quando il bellissimo Baldur, figliuolo di Odino e di
Frigga, morì, la fortuna degli Asi cominciò a declinare. Aveva pur presentito
la madre che sarebbe morto! Aveva chiesto a tutti gli elementi, a tutti, a
tutte le creature, a tutte, di non recargli danno: e l'avevan giurato. Pure
quel furbo di Loki le trasse di bocca, che una sola creatura, una sola, non
l'aveva giurato: un arboscello, il vischio. E Loki persuase il cieco Hodur di
colpire Baldur con un rametto di vischio. E il bellissimo Baldur cadde a terra
spento; e Nanna, la moglie, che si struggeva per lui di un infinito amore, lo
seguì. E la stessa sorte toccherà agli Asi tutti, il giorno che perirà la
terra; dovranno dileguarsi e sparire, nel crepuscolo degli Dii. Tre inverni,
non interrotti da nessuna state, si seguiranno l'un l'altro; si ottenebrerà il
sole; una sciagura incalzerà l'altra; per l'intiero mondo infurierà la guerra.
Surtur, il principe del fuoco, verrà da mezzogiorno a passo a passo; il cielo
si fenderà; e attraverso le suo fenditure gli spiriti del fuoco irromperanno.
Sotto i lor passi il ponte del cielo rovinerà. Nel settentrione il lupo Feuris
si sprigionerà dalla sua catena. La nave Negilfari, tratta dalle unghie dei
morti, sarà condotta dal gigante Hymir verso Oriente, e di quivi si avvicinerà
l'esercito dei cattivi spiriti, menati da Loki. I giganti di ghiaccio e il cane
dell'inferno Garmer s'affretteranno al ritrovo. Tutti converranno nelle pianure
Oscornar. Ed ecco il custode del cielo Heimdall soffiar nel suo corno; e gli
Dii marciare a battaglia, e tutti gli eroi seguirli, quanti ne son periti dal
principio dei tempi. Il frassino Yggdrasil vacilla, divelto dalle radici.
L'aquila gigantesca divora crocidando i cadaveri dei caduti; il serpente
Midgard, divincolandosi, vien fuori dal mare sputando veleno. Thor, sì,
l'uccide; ma l'uccisore alla sua volta è soffocato dal veleno vomitato dal suo
nemico. Feuris ingoia Allfadur, ma anch'egli muore. Loki e Heimdall si
trucidano l'un l'altro. Gli astri si spengono; fiamme dissolvono la compagine
della terra. E la terra si sprofonda nel mare; ma dal mare una nuova terra
emerge; gli Asi si destano da morte, e con loro sorge un uman genere
ringiovanito.
Vi parrà, che
in questo intreccio di fantasie cosmogoniche e religiose nulla vi sia di cui ci
si giovi. Nulla, di certo; forse vi avrete raccolto qualche eco di racconti già
uditi, stranamente confusi con invenzioni nuove; ma ciò al soggetto nostro non
preme. Al soggetto nostro preme osservare che, come le religioni sogliono,
anche questa dei Vikingi o dei Norvegi era atta ad aprirne gli spiriti e
lasciarli spaziare più in là e più in su, a metter loro davanti il contrasto
del bene e del male; ad arricchirli di qualche idealità avvivatrice. Difatti,
se gli abbiamo visti, i Vikingi, astuti e soperchiatori, pure non era sola la
preda che li allettava a' pericoli, bensì ancora gli abbagliava la gloria,
com'essi la intendevano, la vaghezza del nuovo. «Chi vuole», dicevano, «col suo
coraggio acquistare gloria, deve persino innanzi a tre nemici non trarsi
indietro; soltanto avanti a quattro può fuggire senza vergogna.» E il premio
che s'aspettavano, era, dopo morte, il banchettar con Odino lassù e con quanti
altri eroi erano morti prima o dopo. Nè volevano la battaglia, la morte, priva
di canto. Le corti dei principi, dei capi, le navi stesse, mentre scorrevano il
mare, eran piene dei lor cantori, gli Scaldi, ai quali spettava celebrare nei
versi le imprese dei valorosi. Nessuna persona più accetta di loro nei palazzi
dei grandi. Cantavano poesie loro, poesie di loro antecessori avanti ad essi.
Ne ricevevano in ricambio ricchi doni. I cortigiani avevano obbligo d'imparare
a mente i versi cantati e diffonderli. Non tutto, vedete, nei paesi e nei tempi
barbari è men civile che nei paesi e tempi civili.
Così vaghi di
glorie e di avventure accrebbero la loro e la nostra cognizione della terra.
Nel 861 Nadodd fu gettato da una terribile tempesta sulle coste di una terra
ignota; la chiamò come la vide, terra di
neve, ne tornò sgomento della natura
selvaggia, in mezzo a cui s'era visto; ma uno svedese, Gardar Svafarson, vi
approdò da capo più tardi e la chiamò Gardarsholm,
isola di Gardar. Altri, cacciati o da timori o da speranze o da voglia di
libero vivere, scoversero l'Islanda, Ingolfshodi; traevano il nome o dal
proprio loco o dalla natura visibile. Nè qui si fermarono. Verso la fine del
decimo secolo Eirek il rosso, sbandito dalla patria per un omicidio, allestì
una nave gigantesca col disegno di veleggiare verso mezzogiorno; non mosse
solo, ma accompagnato da audaci. Nel 982 vide distendersi dinanzi a lui una
lunga costa, coronata da un ghiacciaio; non sostò nè mutò rotta; sinchè non
ebbe incontrata una regione, che per essere di state verdeggiava tutta e la
chiamò Groenlandia, e vi chiamò altri. Fra questi un Bjarni, in un viaggio con
una propria nave, si trovò una volta a vagare molti giorni e notti senza sapere
dove fosse. Da molti giorni non vedeva il sole, quando gli si mostrò una terra,
che nè a lui nè a' suoi compagni parve la Groenlandia. Non vi si ancorò; navigò
più oltre; e dopo due giorni e due notti gli sorsero davanti due strisce di
costa, delle quali la seconda mostrava grandi monti di ghiaccio. E neanche qui
si sentì invogliato a sbarcare; avanzò; e, menato via da un forte libeccio,
scoverse dopo quattro giorni una quarta terra e vi discese. Quivi trovò il
padre Herjulf, che senza sua saputa vi dimorava, e accolto lietamente, vi
rimase il resto della vita. Che terre erano queste? L'ultima, si congettura
fosse la costa del Massachusetts; la seconda, la Nuova Scozia; la terza, non è
ben chiaro; forse il nuovo Fundland. Così avrebbero rinvenuto l'America un
cinque secoli e più prima di Colombo, se gli uomini vedessero davvero le cose,
prima di esser maturi a vederle e a giovarsene. Nè Bjarni restò poi solo. Un
Leif, figliuolo di quell'Eirek, scoperse il Labrador e rivide la Nuova Scozia,
che chiamò Terra del vino poichè vi abbondavano rigogliose le viti; nel 792 vi
tornò il fratello Thorwald, e pose la sua sede in quella che fu poi chiamata
isola di Rhode; e se ne spiccò per spiare il paese verso settentrione, ma fu
viaggio funesto. Giunto, si crede, alla montagna di Gurnet nel golfo di
Plymouth, l'uccisero. Ed altri seguirono; ma questi bastano a mostrare un
aspetto di questa indole Vikinga, il più adatto a spiegare la loro azione sul
mondo.
Giacchè i
Vikingi amavano di uscire di casa e andare a risiedere persino in regioni
ignote e selvaggie, come non avrebbero sentita la voglia di prender dimora in
regioni relativamente civili alle cui spiaggie approdavano o per i cui fiumi
s'internavano? Una delle prime di queste era la Francia nella sua costa
settentrionale, lì dove era a quei tempi chiamata Neustria. Risalivano la
Senna: bruciavano a dritta e a manca. Parigi gli attirava. Vi penetrarono nel
857; ne bruciarono le chiese: ne misero a ruba le case: la città si riscattò a
denaro, ma v'eran rimasti cinque anni. Ventotto anni dopo vi tornarono forti di
settecento navi. Il fiume n'era ricoperto per un tratto di due miglia. Ma la
città, istruita dalle precedenti invasioni, s'era afforzata. Fu variamente,
gagliardamente attaccata, ma anche gagliardamente difesa. Così l'anno dopo.
Come alla battaglia di Regillo, Castore e Polluce erano apparsi in aiuto a'
Romani, così a' Parigini venne in aiuto tutto un esercito celeste. Il capo dei
Vikingi stanco accondiscese ad andar via per denaro; gliene fu dato: andò. Ma
non tutti i suoi lo seguirono; parecchi restarono; e ritentarono gli assalti.
Nè si mossero, sinchè Carlo il Grosso non si fu avvicinato con un esercito, non
già per usarlo a cacciarli via colla forza, ma per pagare la ritirata anche a
questi. Eran rimasti dieci mesi; ma non perchè Parigi avea lor resistito, se ne
tornavano a casa. Anzi si spandevano per le regioni a settentrione di Parigi, e
vi si stanziavano. Già nel principio del decimo secolo la popolazione v'era di
Vikingi in gran parte. Anzi la difendevano contro altri Vikingi, meglio che i
Franchi non avevano fatto contro loro. Nel 911 un Rollo, o Rollone, - uomo di
tale corporatura che non c'era cavallo che lo reggesse, ond'era costretto ad
andare sempre a piedi, sicchè ne aveva avuto soprannome di camminatore, - chiese a Carlo il Semplice licenza di stabilirvisi
addirittura, e l'ebbe. Così quella parte di Neustria che i Vikingi occuparono
con lui, mutò nome, e si chiamò quind'innanzi Normandia; giacchè i Vikingi eran
detti altresì Northmen, uomini del Nord, o, come noi diciamo, senza più
intendere il nome, Normanni.
La cessione di
quel tratto di terra lungo la Senna dall'Epta e dall'Eure al mare non fu fatta
da Carlo volentieri: ma l'arcivescovo di Rouen non potette ottenere da Rollone
a miglior patto che si ritirasse dai confini della Borgogna, dov'era giunto, e
vi aveva vinto il Duca. Già questo patto, così duramente imposto, mostra in
quali condizioni fosse allora la Francia. Mentre i Normanni la disertavano a
settentrione, facevan peggio i Saraceni a mezzo giorno. La debolezza del
Principe, l'indisciplina e l'insubordinatezza dei grandi, la mala sicurezza di
tutti vi avevano disciolto ogni ordine. La leggenda - quella stessa che
l'Ariosto ha verseggiata - fece poi di tutti i Carli della dinastia Carolingia,
dal Magno al Semplice, uno solo; e dei Normanni e dei Saraceni un sol popolo, i
Pagani; sicchè questi e non quelli fu cantato ponessero l'assedio a Parigi. Una
storia piena di confusione e di disordine fu dalla leggenda confusa e
disordinata peggio. Ma Rollone sapeva chi egli era, e che forza sarebbe stata
la sua. Quando in Saint-Clair venne a colloquio con Carlo, gli porse la mano,
ed essendoglisi fatto segno, che dovesse baciargli il piede, vi si ricusò.
Dette però ordine a un Normanno di farlo in sua vece; e questi tirò tanto in su
il piede del Re, che lo gittò rovescioni per terra. Ecco come il nuovo nasce, e
tratta il vecchio; è insolente di sua natura.
Intanto i
Vikingi, i Normanni, i Pagani bianchi, Fiun
Gail, i Pagani neri, dubh Gail, i
Madjus, com'eran variamente chiamati da popolazioni cristiane o musulmane,
s'eran già cominciati a convertire al cristianesimo. Il loro sentimento
religioso non era forte: come prima non s'eran mai proposto di propagare la
fede di Odino, così parvero abbracciare la fede di Cristo piuttosto per ragion
politica, che per salvare le anime. L'arcivescovo di Rouen riuscì a battezzare
Rollone e i suoi seguaci, e Rollone mutò il nome in Roberto. A ogni modo nè la fede
mutata nè la nuova sede assicurata e tranquilla tolse ai Normanni l'antica
voglia di vagare per mare e per terra in cerca di nuove avventure. Una di
queste ci preme.
Nel quinto
secolo d. C. un cittadino di Siponto, la Manfredonia di ora, ai piedi del Gargano,
ebbe tanta grazia da Dio, che in una grotta non discosto dalla cima del monte
vide l'arcangelo Michele, quel medesimo che, nella battaglia coll'angelo
Lucifero, lo incalzò per modo colla spada di fuoco da precipitarlo addirittura
in inferno. L'8 maggio 493 l'arcangelo apparve di nuovo al vescovo di Siponto
Lorenzo e gli ordinò che dedicasse quella grotta a lui. Fu fatto; e
maravigliosa accoglienza trovò il nuovo culto in tutto l'Occidente. In
Normandia gli fu consacrata una cappella presso Avranches, su una roccia
bagnata dal mare, e ogni anno un infinito numero di pellegrini vi accorreva a
venerare l'arcangelo. Era naturale, che in molti sorgesse il desiderio di
peregrinare al proprio luogo in cui era apparso, al luogo che la pietà dei
fedeli aveva arricchito di doni, ed era perciò diventato preda a vicenda di
Longobardi, di Saraceni, di Greci. Vi si poteva passare chi volesse andare in
Terra Santa: e questo, il maggiore dei pellegrinaggi, non era stato mai smesso.
Covava negli animi per Terra Santa il foco che divamperà di lì a un secolo.
Ora, un
Normanno dei principali, Gisalberto Butterico, poco oltre il 1000, s'avviò
pellegrino al Gargano. Non lasciava la patria senza cagione; aveva ucciso il
visconte Guglielmo, seduttore di una sua figliuola; voleva scansare la pena che
Riccardo II, il terzo successore di Rollone, gli avrebbe di certo inflitta,
poichè portava amore all'ucciso. Menava seco i suoi quattro fratelli, Rainulfo,
Asclittino, Osmundo e Rodolfo, e altri compaesani, di molti. Bisogna accennare,
nelle mani di chi stesse a quei tempi la regione che costoro attraversavano.
Quanta parte
dell'antica popolazione, vissuta qui mentre l'Impero Romano durò, scampasse
agli strazi delle invasioni barbariche, non si può dire; e neanche se e quanti
Goti sopravvivessero alle guerre e alle conquiste, Bizantina prima, Longobarda
poi. Certo alla popolazione Romana più o meno numerosa e alla gente gota,
s'erano oramai sovrapposti Longobardi, Greci, Saraceni. Questi ultimi cacciati
sin dal 916 dal loro nido al Garigliano, dove erano rimasti asserragliati
trentaquattro anni, non avevano mai smesso di molestare l'una o l'altra parte
del territorio napoletano, ma non erano riusciti a stabilirvisi; occupavano,
sì, a riprese città persino importanti, ma combattuti da indigeni, da Greci, da
Longobardi, non vi duravano; però, restano tuttora - nè tutti sulle spiaggie -
nomi di luoghi che li ricordano e attestano una più o meno lunga dimora.
Venivano per lo più dalla Sicilia, già conquistata da essi via via a cominciare
dalla prima metà del nono secolo, o di più lontano, dall'Africa, e trovavano
alleati nelle discordie cristiane, alimentate dal numero dei principati
Longobardi, dalla condizione incerta e mutevole dei possessi Greci, dalle
ambizioni e dalle ingordigie di tutti: e tra tutti e più legittime, ma non meno
disordinatrici, le gelosie di più di un comune, rivendicatosi o desideroso di
rivendicarsi a libertà. Già, quanto a' principati Longobardi dopo morto
Pandolfo Capodiferro nel 981, il ducato di Benevento si era disciolto da capo
in tre; un ducato di Benevento, sminuito, un principato di Capua e uno di
Salerno. Dal primo s'eran distaccate altresì le contee dei Marsi e di Chieti,
che prima gli erano appartenute, ed avevan già fatto parte del Ducato di
Spoleto. Dalla spiaggia del Tirreno i dominî di questi principati si
distendevano entro terra sino alle falde del Gargano e alla catena Appennina:
ma qui si trovavano a contesa coi Greci, che, possedendo la spiaggia Adriatica,
e, di giunta, la Calabria, gli affrontavano da Oriente e da Mezzogiorno. E a'
principali Longobardi il possesso stesso della spiaggia Tirrena era interrotto
da ducati minori, il cui magistrato supremo era elettivo, e che riconoscevano
una cotal sovranità preeminente all'imperatore di Costantinopoli; quantunque
l'elezione non uscisse di solito da una famiglia, e la preminenza imperiale
fosse diventata in tutto una forma vuota di effetto. Tali erano Gaeta, Napoli,
Amalfi, Sorrento.
D'altra parte i
Greci avean diviso il lor tema d'Italia
come lo chiamavano per ricordo dell'antico potere, in due governi: quel di
Puglia e quel di Calabria; e davano nome di Catopano
al governatore del primo - o che questo sia una corruttela di capitano o che
voglia dire sopra tutto, - di
Stratego a quel del secondo.
Felice, come
vedono, condizione di popolo doveva essere questa; ma peggio di una realtà così
intricata e violenta doveva aduggiarlo un'ombra. Due secoli prima, papa Leone
III, coi suffragi del popolo di Roma, aveva, a parer suo, ritornato in vita
l'impero Romano nella persona di Carlo Magno, incoronandolo e segnandolo colle
sue mani di sacerdote. Una confusione di idee aveva dato motivo a una creazione
siffatta; e le tenne dietro una gran confusione di fatti. Chi guardi al
successo, potrebbe sospettare, che appunto il Papato sperava di pescare nel
torbido; ma queste astuzie a lunga vista sono per lo più congetture vane.
Bisogna cercare il motivo del Papa in tutt'altro, e, certo, in ciò, che
l'Impero restaurato da Roma per le mani del sacerdozio si sarebbe surrogato
all'impero di tutt'altra origine che s'intitolava da Bisanzio, e sarebbe stato
del sacerdozio Romano e della sua primazia un appoggio continuo e sicuro. A
ogni modo quell'impero d'Occidente, rinnovato prima nei Franchi, e trasmesso da
quello ai Tedeschi, pretendeva diritti almeno su tutte le terre già appartenute
all'impero Romano, finito nel 476. Ma a quali diritti? Non si sapeva, e il Papa
lo sapeva meno di tutti. Certo, a quelli, che secondo il suo vigor d'animo e di
braccio, ciascun imperatore avesse saputo mantenere, esercitare o rinnovar
colla spada. Intanto, nelle provincie di cui parliamo, questa mal definita
autorità imperiale era riconosciuta dai ducati Longobardi; mentre era
sconosciuta dai minori ducati e dai Greci, che avevano una loro propria
autorità imperiale, la Bizantina.
Quando quei
Normanni venivano, appunto queste due autorità imperiali eran per cozzare di
nuovo; e contro la Bizantina cozzavano già i popoli delle Puglie. Pare che di
tutti cotesti reggitori i peggiori fossero i Greci; giacchè erano anche i più
civili, e quando al mal volere e alla
possa s'aggiunge l'argomento della mente, nessun riparo, dice ancora Dante,
vi può far la gente. Melo e il suo
cognato Datto, due cittadini Baresi, erano a capo di molto popolo insorti contro
essi nel 1009; ma davanti al catapano Bizantino, venuto da Costantinopoli con
molto esercito, non avevan potuto tenere il campo, e s'eran dovuti rinchiudere
in Bari; poi Bari stessa fu presa; ed essi fuggirono a mala pena, e s'ebbero a
ricoverare Melo, in Capua, Datto in Monte Cassino. Benedetto VIII, un Papa dei
buoni, eletto nell'anno stesso che vide la sconfitta di cotesti due patrioti,
li favoriva; com'egli cacciò i Saraceni da Luni, così avrebbe voluto cacciare i
Greci dalla spiaggia Adriatica. A questa impresa gli parvero buono aiuto quei
Normanni nominati dianzi. Gli si erano presentati in Roma; egli aveva assolto
Butterico dell'omicidio commesso. Le lor persone aitanti, le lor sembianze
guerriere gli davano luogo a sperar bene. Gli mandò a Melo: e, questi, raccolto
di nuovo un esercito, riaccese la guerra. Il 1017 egli e i Normanni vinsero nel
maggio il catapano Andronico, ma ne furono sconfitti nel giugno; non però per
modo, che, se ebbero a desistere dal marciare a Bari, non potessero persistere
a conquistar terre più a settentrione, nella Puglia, e sconfiggere alla loro
volta un catapano Contoleone venuto di fresco. Seguirono altre zuffe; la
contesa finì per allora, come un'altra più celebre, a Canne. Quivi, nel 1018,
l'esercito di Melo, di cui i Normanni erano il principal nerbo, e l'esercito
Bizantino, un'accozzaglia di assoldati di nazioni barbare, anzichè di Greci, -
e v'era persino dei Russi, che si batterono meglio di tutti, - comandata da
Basilio Botojanne, si affrontarono. A' Normanni non bastò il valore smisurato
per vincere; il numero li soverchiò. Molti rimasero morti nella battaglia: chi
fu fatto prigione; altri si rifugiarono presso duchi, e conti Longobardi. Melo
corse a Bamberga a chiedere soccorso ad Enrico II imperatore. Trovò alla corte
di questo anche il Papa e il normanno Rodolfo. L'imperatore dette a Melo per
cominciare il titolo di Duca di Puglia, non potendo dargli la Puglia stessa: ma
Melo nell'aprile del 1020 morì. Il Papa tornò a Roma: Rodolfo restò aspettando.
E l'Imperatore per parte sua aspettava d'avere composte le cose in Germania,
dove anch'egli aveva un suo proprio ribelle, per fare la spedizione d'Italia;
giacchè i progressi dei Bizantini, vincitori a Canne, erano tali da mettere
l'autorità imperiale in pericolo di restare nel mezzogiorno senza terre che la
riconoscessero, e minacciavano persino il Papa in Roma. Nel 1021 Enrico II fu
in grado di scendere nel suo regno d'Italia. Celebrato il Natale in Ravenna, se
ne spiccò dividendo il suo esercito in tre parti, l'una comandata da lui, le
altre due da due arcivescovi. Dei duchi Longobardi uno solo gli era rimasto
fedele, Landolfo V di Benevento; punì gli altri due; Pandolfo cacciò da Capua,
e installò in sua vece un altro Pandolfo, Conte di Teano; a Guaimaro di Salerno
chiese il figliuolo in ostaggio. Poi prese a gran fatica Troja, - città poco
innanzi fondata da Greci con questo vanitoso nome; - e infine si risolvette a
tornarsene a casa. La peste gli decimava l'esercito, sorte comune degli
eserciti forestieri nell'Italia meridionale per più secoli. Se non gli
disfacevano gli uomini, li disfacevano le febbri. Dei Normanni altresì tornò in
patria la maggior parte; ma molti restarono. E sopratutto restò l'impressione
del lor valore nella fantasia dei popoli che gli avevano visti combattere, come
in essi stessi quella del paese in cui avevan combattuto, e perso e vinto
battaglie. Non avevan potuto, di certo, in quella prima prova, appropriarselo,
ma se fossero stati più, pensavano, l'avrebbero fatto; ed era terra grassa e promettente.
Intanto, i duchi e i principi Longobardi si ripartirono tra di sè quelli che
non andaron via. Servivano come soldati di ventura alle lor guerre reciproche.
Le quali nessuno, credo, narrerà mai tutte; e io non ne narrerò nessuna. Chè
tutta questa non è storia, ma stoppa. Preme soltanto ricordare che a un
Normanno valoroso, per nome Rainulfo, il Duca Sergio di Napoli, nel 1029, dette
una sua figliuola per moglie, la vedova contessa di Gaeta, e per dote un
territorio tra Napoli e Capua, la Contea di Aversa. Nel bel mezzo dei suoi
possessi il conte Rainulfo elevò un castello. Così un primo Normanno si
stabilì, si afforzò, mise radici.
Signori, se v'è
storia, la quale provi che gli uomini fanno le cose, e non le cose gli uomini;
e che dottrine molto recenti le quali disperdono la persona umana nell'ambiente
in cui vive, son false, è quella che io v'ho narrata sinora e sto per narrarvi;
giacchè si vede la mano dell'uomo, per il volere e l'arbitrio che la dirige,
fazionarla essa. Nel Cotentin, in Normandia, non lontano da Coutances in quello
ch'è ora il dipartimento della Manica, viveva un cavaliere, Tancredi di
Altavilla. Ebbe due mogli: l'una, Moriella, gli dette cinque figliuoli,
Guglielmo, Drogone, Umfredo, Goffredo, Serlone; l'altra, Trasenda, sette,
Roberto, Mangero, Guglielmo, Alfredo, Umberto, Tancredi, Ruggero. La sostanza
famigliare, non che bastare ai figliuoli, appena bastava al padre. E il padre
dette a ciascuno una spada e un cavallo; e gli mandò con Dio; cercassero per il
mondo gloria e fortuna. I tre primi, Guglielmo, ch'ebbe soprannome Braccio di
ferro, Drogone e Umfredo giunsero verso il 1038 alla corte del giovine Guaimaro
di Salerno, succeduto al padre, che aveva già prima adoperato guerrieri
Normanni. Avevan condotti seco trecento cavalieri. Presero servizio
coll'imperatore greco Michele, che voleva ritogliere la Sicilia agli Arabi.
Fecero questo patto: avrebbero ricevuto in compenso metà della preda e della
terra. E da prima l'impresa riusciva; quel Guglielmo faceva prodigi: ma Giorgio
Maniace, il generale greco, non teneva il patto. Sicchè i tre figliuoli di
Tancredi si partirono da lui in collera, e venuti sul continente, cercarono
prender vendetta dei Greci. Al che furono aiutati da un Arduino Longobardo,
anch'egli offeso da Maniace, e dal conte Rainulfo d'Aversa. La guerra cominciò
nel 1041, e, per difesa che i Greci facessero, dovettero pure abbandonare a'
Normanni e ad Arduino quasi tutte le città possedute da loro, e il Gargano per
giunta. Nel 1042 i Normanni elessero a lor capo Guglielmo Braccio di ferro, e
questi già si chiamò Conte di Puglia; e della nuova contea si lasciò investire
da Guimaro di Salerno e da Rainulfo di Aversa; dei quali il primo, diventato
molto potente, si fece in questa congiuntura Principe Duca, e il secondo s'ebbe
il Gargano e i dintorni. Ad Arduino spettò, secondo i patti, la metà degli
acquisti. Dodici altri Normanni, che Rainulfo aveva messo insieme con Guglielmo
a capo dell'impresa, ottennero ciascuno un particolar dominio. Questi accordi
conclusero in Melfi, che sarebbe rimasta città comune a tutti.
Guglielmo morì
nel 1046; i Normanni gli elessero a successore il fratello Drogone; e Guimaro
ne confermò la scelta. Davvero di dove questi traesse il diritto d'investire e
di confermare, non si vede: ma egli s'era impossessato di Amalfi e di Capua, e
aveva fatto d'un suo fratello il Duca di Sorrento, e come aveva dato in moglie
a Guglielmo la figliuola di questo, così dava in moglie a Drogone la figliuola
sua. Una minor forza, dunque, cercava nella ricognizione d'una forza maggiore,
la ricognizione del diritto suo; e forse, questa maggior forza del Duca di
Salerno ritrovava la sua legittimità propria e quella degli altri,
nell'autorità imperiale che aveva inizialmente investito lui. Del che, però,
non si sarebbe mostrato persuaso l'imperatore Enrico III, quando nel 1047 venne
in Campania: giacchè lo costrinse a render Capua al principe spossessato e a
rinunciare al titolo di Duca. Invece investì di sua mano Drogone e Rodolfo,
succeduto a Rainolfo di Aversa e suo nipote.
Così la casa
dei Normanni s'allarga; ma per ora son dominî distaccati i loro; cresciuti sì
di numero, ma sconnessi. E ora, una inimicizia inaspettata scoppia. I primi
Normanni eran venuti coll'assenso del Papa; ma ora lor diventa avversa la
politica papale. Leone IX, Papa sin dal 1048, non poteva di certo prevedere,
ch'essi avrebbero costituito, accanto allo Stato della Chiesa, uno Stato forte:
il che al papato non è mai piaciuto; e ora vedeva, che eran già più forti di
quanti principi e popoli esistevano prima di loro nello Stato attiguo. Forse,
anzi certo, neanche l'Imperatore li gradiva, come quelli che non avevano
aspettato l'investitura sua per intitolarsi Conti: e tra l'Imperatore ed il
Papa correvano allora intelligenze strette. A ogni modo il pomo della discordia
parve fosse Benevento. L'Imperatore aveva fatto dono al Papa di questa città;
ma del territorio di essa n'aveva investito Drogone. Così il primo ducato
Longobardo pagava la pena di aver parteggiato[15],
alla calata dell'Imperatore, per i Greci contro lui ed il Papa. E Drogone,
quanto a sè, avrebbe ben voluto che i suoi Normanni non facessero danno ai
cittadini; ma non eran facili a tenere a segno. Entravano in città, e la
taglieggiavano e in ogni altra maniera la offendevano. Drogone, non che essere
in grado d'impedirlo, fu ucciso lui a tradimento in una chiesa, mentre Leone IX
raccoglieva un esercito contro di lui. La campagna che seguì, ebbe questa fine
che il Papa, quantunque si collegasse con Argiro, - un figliuolo di Melo, che
mutata parte più volte, era riuscito a diventar Catapano Bizantino e a
ritogliere Bari a' Normanni, - il Papa, dico, fu vinto e fatto prigione presso
Civitella, il 18 giugno 1053. Non mai prigioniero fu fatto segno di maggiori
onori; ma in compenso dovette a' vincitori accordare la signoria della Puglia,
della Calabria e della Sicilia. Di dove gli veniva il diritto di dare roba non
sua? Questo diritto papale di dare, come si accordava col diritto imperiale di
dare? Non se lo chiedevano. Andava negli spiriti sorgendo e radicandosi l'idea
di una doppia autorità universale, senza che insieme sorgesse nessun preciso
concetto dei limiti tra le due, o che l'una su ciò consentisse coll'altra.
Umfredo, fratel
di Drogone e suo successore alla contea di Puglia, e Riccardo, Conte di Aversa,
avean capitanato i Normanni in questa felice impresa. Intanto era disceso di
Normandia un altro dei fratelli di Umfredo; però del secondo letto, Roberto.
Questi più alto della persona, che la più parte dei suoi compagni di Normandia,
colla bionda capigliatura disciolta, largo di spalle, voce sonora e imperiosa,
pareva nato a comandare; e di fatti col valore smisurato congiungeva una
qualità, non meno necessaria, l'astuzia; onde appunto ebbe soprannome
Guiscardo. Visse più anni piuttosto da bandito che da cavaliere, - se le due
parole a quei tempi avevano diverso senso, - in un castello di san Marco, a
mura di legno, non lontano da Bisignano, in provincia di Cosenza. Di quivi si
calava a far preda, occupando con agguati città o assalendo cittadini e
forestieri. Drogone il fratello glielo aveva donato, e insieme concessogli il
diritto di conquistarsi la Calabria. Un altro Normanno, un Girardo, gli offrì
una sua zia in moglie e dugento cavalieri in aiuto. Roberto accettò tutto, zia
e cavalieri; e, chiesto licenza a Drogone, sposò Alderade, che così si chiamava
la zia. Così uniti si assoggettarono gran parte del paese. Intanto nel 1055
moriva Umfredo, e lasciava figliuoli in età non adatta al comando. Il principio
di eredità non era già così prevalso come fece poi; si sceglieva il successore
nella famiglia; ma non era già ammesso che il principato si dovesse
necessariamente trasmettere di padre in figliuolo o figliuola. Sicchè i
Normanni elessero Roberto a successore di Umfredo; e Roberto, senza darsi
pensiero d'essere designato dal padre morente a tutore del figliuol minorenne
Abelardo, nominò sè Duca di Puglia e di Calabria. Nicolò II glielo confermò; e
il Guiscardo gli si obbligò a difender la Chiesa. Fu più difficile ottener
l'obbedienza dei Baroni: nè gli costò poco o breve sforzo. Così si costituì tra
i Normanni un principato già grosso: ma quella conferma chiesta a' Papi, e
ottenuta, di un possesso acquistato con le armi, che pareva investirlo di
diritto, in realtà lo rendeva vacillante e gli scalzava la base di diritto
proprio.
E si vide
subito. Ho nominato dianzi un Riccardo Conte di Aversa. Pure, a Rainulfo era
succeduto Rodolfo: come ora invece di questo è conte Riccardo? In un
semplicissimo modo, parrebbe; Rodolfo era, bensì, morto nel 1047; ma Riccardo
non ne era il figliuolo. Egli era bensì cognato del Guiscardo e nipote di
Rainulfo; ma non eran titoli questi che rendessero il suo titolo alla contea
migliore di ogni altro. Però nessuno più bello di lui; nessuno di più gentile
aspetto; nessuno cavaliere più ardito. E a' Normanni questi eran titoli che
superavano ogni altro. E l'elessero. Se non che egli era in carcere; ve l'aveva
gittato Drogone per punirlo, dopo averlo vinto, della gran molestia che dava,
battagliando, a vicini e a lontani. Ora, doveva per prima cosa uscirne.
Guaimaro glielo ottenne; ma non appena Conte Riccardo si vide padrone di
Aversa, volle conquistar Capua. E ci riuscì nel 1058 malgrado i Capuani. E così
finì il secondo ducato Longobardo.
Nè qui Riccardo
si fermò. Un suo genero e vassallo Guglielmo di Monstarola gli si ribellò, e si
rifugiò da papa Alessandro II e lo riconobbe a suo signore. Riccardo mosse nel
1066 contro Roma stessa e osò intimare guerra al Papa. E il Papa ricorse per
aiuto a re Errico di Germania, che fu poi Errico IV, l'Errico di Canossa, ancor
sedicenne. Il Re non si mosse; però il suo scudiere, Duca Goffredo di Lorena e
di Toscana, fece sua la causa del Papa. Ma poichè nè Goffredo si sentiva
abbastanza forte per mettere alla ragione Riccardo, nè Riccardo era abbastanza
sicuro di potergli resistere, fu conclusa una pace. E qui si vede come la
potenza dei Papi s'intromettesse già tra i Baroni del paese vicino e si facesse
fomite di ribellioni e guarantigia di ribelli.
La potenza dei
Papa era sul crescere, anzi per raggiungere il sommo dei suoi ideali e delle
sue speranze: che già Ildebrando, quel meraviglioso uomo che nel 1073 divenne
lui Papa e si chiamò Gregorio VII, governava sin da Vittore II, cioè da
diciotto anni, la Chiesa. E nella sua mente piena d'ardore, di coraggio e di
costanza aveva, secondo la inclinazione e la scienza dei tempi, maturato il
concetto, che la Chiesa, indipendente nella sua azione, nei suoi dignitari, nei
suoi beni da ogni autorità imperiale o regia, dovesse sola esser fonte di
tutto, e soprapporsi a tutto, come autorità ch'essa era, proveniente senza
intermezzo da Dio. Non mai era stata tentata rivoluzione maggiore di questa; e
più disperata di riuscita nella integrità, almeno, del suo disegno. Poniamo che
il Papato ne avesse il diritto, dove avrebbe trovato la forza sufficiente a
incuterne il rispetto? Era un disegno squilibrato, ma in questo squilibrio
necessario tra l'ideale sognato e il reale resistente fu l'attrattiva sua.
Però prima di
vederlo codesto uomo smisurato apparir sulla scena nostra, - la minore, del
resto, delle scene in cui apparve, - dobbiamo ricordare la maggior impresa, che
intanto Roberto compiva. Un altro suo fratello era giunto, nel 1057, da
Normandia, il minore di tutti, Ruggero, con tre sorelle, per giunta, e la
madre. Anch'egli bell'uomo e da far colpo; se non superava Roberto in valore,
lo superava in bontà di cuore e amabilità di tratto. Da prima, ebbero i due
fratelli qualche dissapore; poi, nel 1060, Roberto si risolvette a dare al
fratello il comando di una parte del suo esercito, e commettergli la conquista
definitiva della Calabria. Insieme posero l'assedio a Reggio: e la città,
quantunque si difendesse bravamente, fu presa. E così Roberto era giunto
all'estremo punto della penisola; ma egli era già stato dal Papa investito
dell'isola di rimpetto. Ruggero non ne era in minor desiderio di lui. La
Sicilia era allora in mano dei Saraceni, che v'avevano posto piede nel 827, più
di due secoli innanzi, e l'avevan tolta ai Greci, che l'avean tolta ai Goti,
come questi a' Romani, e i Romani di nuovo a' Greci e a' Fenicii, e gli uni e
gli altri, rivaleggiando, ai Siculi indigeni o piuttosto venuti d'Italia; e chi
sa a qual altro popolo questi invasori primissimi l'avranno sottratta!
L'impresa fu
tentata prima da Ruggero solo nel settembre del 1060, seguito da non più di
dugento cavavalieri. Mal riuscita, fu ritentata nel febbraio del 1061 da lui e
da Roberto insieme, sollecitati da un Saraceno due volte infedele. Non la
narrerò, quantunque sia piena d'interesse; e mi contenterò di dire, che
Palermo, città che durante il dominio Saraceno era diventata la principale
dell'isola, dopo resistito a fortissimi attacchi, si arrese nel 1072. La Chiesa
vi surrogò la Moschea, come due secoli prima la Moschea vi aveva surrogata la
Chiesa: ma come nella prima mutazione non erano stati esterminati i Cristiani e
Greci, così ora nella seconda non furono esterminati i Maomettani e Saraceni.
Anzi questi rimasero numerosi nell'isola, e diventarono per soprappiù
istrumento e forza di governo ai principi Normanni e Svevi. Però, per quanto la
tolleranza meriti lode, se anche si prescinda da' fini politici, anzichè morali
che la dettarono, se nelle vicende che seguirono i Maomettani ebbero gran parte
a mantenere il regno ai principi Normanni e Svevi, si può dubitare se la
prevalenza lasciata talora a' Musulmani nel governo e nell'esercito, giovasse a
dar solidità allo Stato che i Normanni crearono e gli Svevi ereditarono.
Colla presa di
Palermo non fu tutta compita l'occupazione dell'isola nè questa tranquillata
tutta. Ma oramai la conquista e la pacificazione erano un processo sicuro; e
dei Greci, dei Longobardi, - come vi si chiamavano tutti gl'Italiani, - dei Saraceni
che non fossero tornati in Africa, degl'indigeni si sarebbe a mano a mano fatto
un popolo solo; giacchè è propria qualità delle isole il macerare insieme le
stirpi che le abitano, anche se molte e diverse. Intanto i due fratelli, per
principiare, presero tra loro quest'accordo, che sarebbero loro appartenuti in
comune, metà per uno, Palermo, Messina e Val Demone nel settentrione
dell'isola; e a Ruggiero la metà delle altre regioni dell'isola o conquistate o
tuttora da conquistare; e l'altra metà insieme al lor nipote Serlone e ad un
altro parente degli Altavilla, Arisgoto di Pozzuoli. Non era combinazione da
durare un pezzo. Serlone, del resto, un valoroso, a breve andare morì ucciso
con perfidia da un Saraceno; Ruggiero ne piangeva; Guiscardo gli gridò:
«Piangere, si conviene alle donne; agli uomini vendicarsi.» Questo tratto
dipinge la diversa natura dei due.
E Roberto e
Ruggiero, aumentati ciascuno di potere, crebbero altresì di titoli. Ruggiero,
già Conte di Calabria sin dal 1062, quantunque la possedesse solo a metà con
Roberto, s'intitolò altresì Conte di Sicilia e vi rimase a finir la conquista;
l'altro, Roberto, al suo titolo di Duca di Puglia e di Calabria, - perchè il
Conte di Sicilia apparisse vassallo con questo secondo titolo, come lo era con
quello di Conte di Calabria, - aggiunse l'altro di Duca di Sicilia e tornò sul
continente. Quivi, nel 1071 egli aveva, dopo lungo assedio, ritolto Bari a'
Greci; ma gli bisognò, tornato da Palermo, riconquistare Trani, e rimettere a
dovere i Baroni ribollenti sempre, come quelli che venuti uguali in Italia, non
vedevano perchè dovessero omaggio e obbedienza a un di loro, quale era Roberto,
e neanche al più nobile di tutti nella regione natia. Allora tumultuavano,
perchè Roberto voleva che facessero la dote alla sua figliuola che andava sposa
a Ugo margravio d'Este. Continuava così Guiscardo ad elevarsi colle parentele.
L'anno innanzi ne aveva sposata un'altra all'imperatore d'Oriente.
E ingrossava
insieme lo Stato. Sin dal 1058 aveva con un pretesto repudiata Alderade, la
compagna de' suoi poveri anni, e chiesta in moglie a Gisolfo Principe di
Salerno la sorella Sigelgaite, donna di alto animo, che nelle imprese del
marito prese non piccola parte. Tre virtù, dice un cronista, erano in lui:
ricchezza, chè nessuno era più ricco; pietà, che nessuno era più pio;
cavaliere, che nessuno era più cavaliere; e tre virtù in lei, nobiltà di
sangue, bellezza di forme e intelligenza di spirito. Il fratello ne accordò la
mano per paura; ma l'esser diventato cognato di Guiscardo non lo salvò. Chè
questi nel 1078 gli tolse colle insidie e colle armi il Principato di Salerno e
lo sbandì. Aveva già nel 1073 occupato con improvviso assalto Amalfi, e tra le
due date Sorrento. Così il terzo ducato Longobardo cadeva; e insieme con esso
due dei ducati minori.
E colla fortuna
gli cresceva l'ardire. Quando l'ultimo duca di Benevento morì nel 1078 senza
figliuoli, si rifecero vive le pretensioni opposte del Papa e dei Normanni
sulla città. Il Guiscardo, che fidava per le sue nelle armi, vi pose,
senz'altro, l'assedio. Ma il Papa, ch'era Gregorio VII, aveva anch'egli un'arme
sua, molto affilata a quei tempi: lo scomunicò. Il Guiscardo non si sentiva
nella guerra contro il Papa confortato dal consenso de' suoi; il fratello
Ruggiero si profondeva in attestazioni di devozione al Papa; Riccardo di Capua,
ammalato per modo, che morì nell'anno, gli chiedeva l'assoluzione, e restituiva
alla Chiesa tutto il mal tolto. Il Guiscardo scese a patti. Nel giugno del 1078
Papa e Duca vennero a colloquio in Aquino. Il Duca si riconobbe vassallo del
Papa e promise di difenderne i possessi contro chi si sia; e il Papa lo investì
per vessillo - il che, si dice, fu fatto per la prima volta - dei ducati di
Puglia, di Calabria, di Sicilia, di Salerno, di Amalfi, a patto che ne pagasse
censo. Così si confermò tra il Papa e i Normanni e i lor successori, se ne
avrebbero avuti, una relazione, che già s'è vista nascere; e che lungo quasi
tutta la storia della monarchia, di cui vi espongo l'origine, sarà gravida di
guai.
Papa Gregorio
non era per sè nemico ai Normanni. L'impresa di Sicilia, come impresa di
Cristiani contro a Musulmani e intesa a render l'isola ai primi, gli andava, di
certo, a genio. Era un caso di quel ripiglio di spirito cristiano, che già si vedeva
da più anni in Ispagna, e che in breve avrebbe divampato nelle Crociate.
D'altronde, egli ritrovava nei Normanni una forza incomoda forse perchè molto
vicina, ma anche, perchè molto vicina, adatta a prontamente soccorrerlo contra
l'autorità imperiale, tra la quale e la papale imperversava più che mai la
guerra per la libertà della collazione dei beneficî ecclesiastici, così
ostinatamente pretesa da una parte, così ostinatamente negata dall'altra. Nel
1078 Errico IV si andava già rilevando dalla umiliazione subita a Canossa due
anni innanzi, e i fatti andavano provando che la vittoria, quivi ottenuta da
Gregorio, non era stata in realtà tanta quanta era parsa. In questa rete di
circostanze confuse, certo il meglio era per Gregorio e il Guiscardo di ritornare
amici; e perchè a Guiscardo avrebbe dovuto parere fantastico lo sperare che
Gregorio avrebbe finito col coronare lui imperatore d'Occidente in Roma?
Intanto
meditava diventarlo in Oriente. Gliene dava occasione questo, che la sua
figliuola Elena, maritata nel 1097 a Costantino, figliuolo primogenito di
Michele VII, era stata rinchiusa in un monastero da un Niceforo Botoniate, che,
impossessatosi di Costantinopoli, aveva fatto prigione lei, il marito, il
suocero, già per opera di altri sbalzato dal trono. Il Guiscardo mosse con una
gran flotta a liberar la figliuola, a buttar giù Niceforo, a metter sul trono
dei Comneni non quel povero Michele, ma sè. Gregorio VII ve l'incoraggiava.
Prese Corfù; pose l'assedio a Durazzo in Albania; ma non vi entrò che nel
febbraio del 1082; chè prima ebbe a vincere nell'ottobre del 1081 una
sanguinosa battaglia. I Greci eran venuti ad affrontarlo comandati da un
Comneno, Alessio, che già aveva scacciato Niceforo e s'era alleato coi
Veneziani, perchè sciogliessero l'assedio di Durazzo da mare, mentr'egli
l'avrebbe sciolto da terra. Alla vittoria del Guiscardo aveva avuta una piccola
parte Sigelgaite: colla lancia levata ricacciava nelle file dei combattenti i
guerrieri fuggenti di Puglia. Ma Alessio non s'era sgomento; raccoglieva nuove
forze a difesa. E i Baroni di Puglia, sempre insofferenti del giogo,
minacciavano allearsi con lui contro il lor duca; e Gregorio oramai implorava
da Roma che ritornasse, venisse in soccorso della Chiesa minacciata. Difatti
Errico non cessava di creargli antipapi, e nel 1081 discendeva armato in
Italia. Anche qui un'altra donna difendeva principalmente Gregorio, Matilde di
Toscana, la gran Contessa. Il Guiscardo si persuase che gli bisognava ritornare
in Italia; però, non ismise il disegno di un impero normanno di Oriente; lasciò
a compierlo Boemondo, l'unico figliuolo avuto da Alderade. L'impresa infine
fallì. Il Guiscardo tornato nelle Puglie ebbe prima a reprimervi insurrezioni
di Baroni; poi a correre in aiuto al Papa. Errico aveva occupato Roma nel 1084;
s'era fatto incoronare imperatore da un suo Papa; aveva tratto il popolo dalla
sua; e Gregorio s'era dovuto rinchiudere in Castel Sant'Angelo. Guiscardo nel
maggio s'accostò a Roma con un esercito di seimila cavalli e trentamila fanti; l'imperatore
fuggì. Entrato in città non senza pericolo, ne fece scempio: le rovine di Roma
sono in gran parte opera sua. Gregorio liberato lo seguì al suo ritorno nelle
Puglie, e andò a morire il 25 maggio 1085 a Salerno. Dette a sè morendo questa
testimonianza ch'egli avesse amato la giustizia e odiato l'iniquità, e perciò
morisse esule. Che si risichi di morire esule, amando la giustizia, è vero; ma
ch'egli avesse amato la giustizia sempre, è forse men vero.
A breve andare
lo seguì il Guiscardo, un uomo di ferro dietro l'altro. Egli aveva ripigliato
il suo disegno dell'impero di Oriente. Nel settembre del 1084 era ripartito da
Brindisi con una flotta di centoventi navi; conduceva seco i suoi tre figliuoli
Boemondo, Ruggiero e Guido. Fece rotta per Corfù; ebbe a difendersi contro la
flotta veneziana che gl'impediva il passaggio; pure approdò e riconquistò
l'intera isola. Si proponeva di marciare contro Costantinopoli nella primavera
del 1085. Ma ecco che nei dintorni di Corfù lo coglie una febbre così micidiale
che n'è ucciso in pochi giorni, il 17 luglio 1085. Sigelgaite ne raccolse il
cadavere in una nave; e sbattuta dalla tempesta, salvò a mala pena sè e il
morto. Pure, venuta infine a spiaggia, ne seppellì il cuore ed i visceri ad
Otranto; il corpo imbalsamato nella chiesa della Santa Trinità di Venosa,
dov'erano già i fratelli di lui. Esercito e flotta tornarono, ma come quello
era stato grandemente scemato dalla peste, così questa fu dalla bufera.
Roberto
Guiscardo fu, certo, uno dei più grandi uomini del suo tempo e fondò la potenza
normanna. Ma v'ho detto via via, dove fossero le magagne di questa potenza; e
n'avete potuto vedere infine un'altra; nata da avventure, resta troppo
passionata di avventure. Egli lasciava un solo fratello, Ruggiero; di Alderade
un figliuolo, di Segelgaite due. Aveva nominato erede il primo dei due ultimi,
Ruggiero. Fu nuova magagna. Ruggiero non aveva forza d'animo e di sangue pari
al padre, e la successione gliela contese Boemondo. Nel 1088, Ruggiero, il
conte di Calabria e di Sicilia, lo zio li rappattumò: Ruggiero sarebbe stato il
Duca di Puglia; Boemondo avrebbe ritenuto una parte di Calabria, Taranto,
Otranto e alcune altre terre. In più altre occasioni Ruggiero zio venne in
aiuto a Ruggiero nipote per confermargli lo stato contro ribellioni incessanti
di Baroni o di città. Nel 1091 gli conquistò Capua, contro il popolo, che
n'aveva cacciato Riccardo II, succeduto a Giordano, figliuolo di Riccardo I. Il
nipote gli accordò in compenso quella metà di Palermo e di altre città che
aveva ereditata da suo padre Roberto. Così Ruggiero zio rimaneva solo padrone
dell'isola di Sicilia e della inferiore Calabria, il cui possesso aveva unito
nelle sue mani prima. E la conquista della Sicilia aveva compito in quello
stesso anno colla reddizione di Val di Noto; v'eran bisognati trent'anni. S'era
d'allora in poi o prima cominciato a chiamare il Gran Conte; e di ogni vincolo
di vassallaggio della contea di Sicilia al Ducato di Paglia non fu più parlato.
Bramoso di gloria e di possanza tentò in quello stesso anno l'impresa di Malta,
non per appropriarsela, ma per liberare i molti prigionieri cristiani che i
Saraceni vi tenevan rinchiusi. Pacificato il paese soggetto a lui e al nipote,
al che bisognò all'uno e all'altro riprovarsi ancora più volte, morì nel 1101,
anch'egli, come il Guiscardo, a 70 anni.
Non era stato,
a me pare, minor uomo di lui. Non men valoroso nè meno uomo di guerra, aveva
sortito natura più intellettuale e gentile. Una cronista, Anna Comneno, dice di
lui, ch'egli parlasse con una grazia meravigliosa; avesse concetti rapidi e
profondi: si mostrasse sempre gaio, affabile a tutti. Un tratto suo basti di
allorchè egli stava ritentando l'impresa di Sicilia. Aveva ripassato lo stretto
con dugentocinquanta cavalieri, quando gli giunse notizia di una persona giunta
per lui in Calabria. Era Giuditta figliuola del Conte di Grentemesnil, che
discendeva dai duchi di Normandia. Ruggiero, che aveva appena trent'anni, si
era già qualche anno innanzi innamorato della fanciulla. Ed ora essa memore di
lui e ricordata da lui, se n'era venuta in Calabria colla sua sorella Emma. Il
Conte non fu più visto nel campo; corse all'amata subito. E la sposò in Mileto
con splendide feste, quantunque fosse tuttora povero lui. L'amava molto allora,
e l'amò molto sempre; pure non s'indugiò troppo con lei; ritornò dall'amata ai
nemici. Giuditta gli premorì di molti anni; gli era premorto altresì
giovanissimo un figliuolo Guglielmo: e otto anni prima, con infinito dolor suo,
un altro figliuolo Giordano. Morta Giuditta, egli aveva sposato una Eremburge
figliuola del Conte di Mortone, e dopo morta questa, nel 1091, un'Adelasia
figliuola di Bonifacio Marchese di Monferrato, della quale rimanevan figliuoli
un Simone di otto anni, un Ruggiero di sei. Sicchè la parte dei dominî
normanni, meglio composta insieme e più solida, doveva ora essere esposta a una
delle più difficili prove, la reggenza di una donna. Pure condotta sino al 1105
a nome di Simone, poi, questo morto, a nome di Ruggiero, fu reggenza
tranquilla; il che prova in che ferma condizione il Gran Conte lasciasse
l'isola, e che buona e intelligente donna fosse Adelasia. Nel 1112 Ruggiero
assunse il governo. Egli era stato allevato con cura, tra dotti arabi e
cristiani; e i primi, che erano allora avanti a tutti in cognizione di scienze,
gliene avevano arricchita la mente. Aveva mostrato per tempo un vivace spirito
e un'insolita voglia d'imparare; caritatevole per modo che nessuno ricorreva a
lui invano. Donava tutto il denaro che si trovava addosso; e se più non ne
aveva, non dava requie alla madre insino a che non ne lo provvedesse; insieme,
indole maschia, guerriera, e già vivente il padre, soleva dire al fratello
Simone: «Lasciami la corona e le armi e io in ricambio ti farò Vescovo o Papa
di Roma.»
Intanto nel
1111 era morto così Ruggiero suo cugino, il figliuolo del Guiscardo, come
altresì l'altro figliuolo Boemondo, il quale, uno, com'egli fu, degli eroi
della prima crociata, s'era fondato in Antiochia un principato. Al primo era
succeduto il figliuolo Guglielmo: al secondo anche il figliuolo, chiamato del
pari Boemondo. Le condizioni dei possessi dei Normanni sul continente erano sin
dal principio del secolo tristi. La potenza dei duchi sfatata, e scarsa a
contenere i Baroni impazienti di ogni soggezione. La sovranità eminente del
papa rimaneva senza efficacia nelle mani dei successori di Gregorio VII,
Vittore III (1086-88), Urbano II (1088-1098), Pasquale II (1099-1117), Gelasio
II (1118), Calisto II (1119-1123), sbattuti e raminghi essi stessi. Se però ad
altri questo era male, a Ruggiero di Sicilia era bene. Gli dava occasione di
mescolarsi delle cose del continente, come aveva fatto suo padre, ma con più
frutto. Già nel 1121 era passato in Calabria con un esercito e aveva abbattuto
castella di ribelli e ripreso città; sicchè il duca Guglielmo gli fece cessione
dei suoi diritti eventuali sul paese. Poichè Boemondo II se ne rimaneva in
Palestina nella sua Antiochia, nè si dava cura dei suoi stati d'Italia,
Ruggiero ne prese cura lui e se gli appropriò. Più tardi ricomprò a Guglielmo
di Puglia con una notevole somma di denaro il diritto di successione al ducato,
nel caso che morisse senza figliuoli. E il 26 giugno del 1027 Guglielmo morì
appunto senza figliuoli. Ruggiero che in quei giorni apparecchiava una spedizione
contro i Musulmani di Spagna dopo riuscitagliene a male un'altra contro i
Musulmani d'Africa, desistette; chè trovò di maggiore importanza assicurarsi il
possesso del ducato di Puglia, al quale non aveva se non quel tanto di diritto,
che poteva dargli il contratto stipulato con Guglielmo. Bisognava l'assenso dei
Baroni e delle città, e prevedeva che in quelli e in queste avrebbe trovato
grandi ripugnanze. E in fatti ne trovò; ma più colle buone che colle tristi,
più colla persuasione che colle armi le vinse; e i Baroni delle Puglie e delle
Calabrie lo proclamarono Duca.
Il che non
piaceva punto a papa Onorio II succeduto (nel 1124) a Calisto II. La Germania,
divisa in sè medesima, non dava in quel momento paura: vi spuntava la guerra
tra guelfi e ghibellini. D'altronde nel 1125 Calisto aveva a Vormazia concluso
un concordato coll'imperatore Enrico V circa i diritti rispettivi della Chiesa
e dell'Impero nella collazione dei benefizi ecclesiastici; un componimento
equo, parrebbe, considerati i tempi, ma che appunto perchè moderato, s'attrasse
i vituperi di chi voleva che nulla cedesse la Chiesa e di chi voleva che nulla
cedesse l'Impero, e se gli attrae tuttora ai giorni nostri da chi vuol
persuadere, che si deva ritenere sconfitto quello dei due, che non ottenne
tutto. Checchè sia di ciò, il Papato aveva oramai maggiore agio a riguardare
alle cose del mezzogiorno; e a condurvisi secondo gli interessi propri. I quali
Onorio credeva che fossero chiaramente questi: impedire che troppo grosso Stato
si costituisse vicino al suo, mantenere in condizione di vassallo il Ducato di
Puglia. Ora Ruggiero offendeva l'uno o l'altro, unendo alla Contea di Sicilia
tutti i possessi normanni del continente, e intitolandosi duca di Puglia e di
Calabria da sè, anzi mutando, come fece appena tornato in Sicilia coll'assenso
dei baroni siciliani, quello di Gran Conte in quello di Duca dell'Isola. Non
bisognava indugiare: Onorio II si recò, quindi, in Capua e scomunicò il
temerario; Ruggiero gli mandò ambasciatori a calmarlo; Onorio glieli rimandò
via. E venne a Troja e scomunicò da capo, e predicò la crociata contro di lui,
e condonò i peccati a tutti quelli che avessero preso le armi contro di lui;
anzi provocò a ucciderlo. E fece meglio. Convocò i Baroni, e chiese loro, con infocate
parole, d'insorgergli contro, e n'ebbe promessa dai più potenti, e persino da
Rainulfo di Alife cognato di Ruggiero. Nè ad altre ambascierie di Ruggiero dava
ascolto, e nemmeno la profferta di riconoscere il Ducato di Puglia da lui, lo
piegò. Già questa condotta prudente di Ruggiero mostra che forza avessero a
quei tempi armi tanto spuntate oggi, che non si adopererebbero senza dar
cagione di riso. Una donna venne a Ruggiero in aiuto, una donna morta, ma
santa. Il corpo di sant'Agata, che quel Maniace, nominato dianzi, aveva rapito
da Catania e portato in Costantinopoli, un prete calabrese e un francese lo
riportarono da Costantinopoli a Catania appunto allora. Poteva una santa
ritornare nei dominii di uno scomunicato, se la scomunica fosse stata legittima
e valida? Di certo, no. Il disfavore quindi, che dall'inimicizia del papa
proveniva a Ruggiero nelle menti popolari, fu contrastato e dissipato dal
favore che gli dimostrava una santa. E Ruggiero non indugiò a giovarsi
dell'inaspettato aiuto: ripassò lo stretto, nel 1028: riconquistò più città, ed
avanzò sempre, sinchè si trovò di fronte all'esercito del papa al fiume Bradano
nella pianura di Pado Petroso. Mentre i due avversari esitavano a venire alle
mani, l'esercito del papa si dileguava: poichè s'era al colmo della state, mal
tolleravano le fatiche del campo soldati e Baroni. Il papa vistosi a mal
partito, senza darsi per inteso dei Baroni, che aveva attirati a così brutto
gioco, mandò a offrire a Ruggiero che l'avrebbe rilevato dalla scomunica e investito
del Ducato di Puglia a Benevento. Accettato con gioia. E Onorio si ritrasse
verso Benevento, e Ruggiero seguì. Ma nella città questo prudente non volle
entrare. Dovette il papa venirne fuori, e presso il ponte maggiore compiere
l'investitura solenne.
In tutta la
regione che fu poi il Regno di Napoli, si reggeva oramai indipendente dai
Normanni solo il ducato di Napoli, - ducato durato 500 anni, molto più a lungo
di ciascuna delle dinastie che l'hanno seguito; - giacchè il ducato di Gaeta
era già caduto in mani normanne. Non era legittima aspettazione, ragionevole
ambizione, che oramai tutta questa regione si costituisse a regno, e il duca
Ruggiero diventasse re? Poichè egli ebbe represso di nuovo l'insolenza ribelle
dei Baroni, e in un'assemblea a Melfi ottenuto l'assenso a un Editto che
restava un ordine qual si sia in un paese disertato tutto da moti di violenza
continua e instabile, se ne tornò in Sicilia sul finire del 1029. Quivi maturò
dentro di sè il pensiero di farsi re. Chi dei re di Europa più potente di lui?
I suoi Baroni di Sicilia ve lo incoraggiavano. Ma che contrasto non avrebbe
trovato nel Papa! Ed ecco che al fortunato muore Onorio, e la successione n'è
contestata tra Innocenzo II e Anacleto. Quando i papi erano due, s'era sicuri
di ottenere dall'uno quello che s'era sicuri di vedersi rifiutato dall'altro.
Anacleto furò le mosse ad Innocenzo, o forse questi che contava appoggiarsi
sulla Germania e n'era stato riconosciuto, come altresì dalla Francia e
dall'Inghilterra, non avrebbe potuto attenersi al partito che l'altro seguì.
Certo, Innocenzo lasciò intendere che non avrebbe secondato Ruggiero nella sua
ambizione regia; onde questi trovò soltanto canonica l'elezione di Anacleto,
come Anacleto trovò legittima l'ambizione del duca. Sicchè vennero a colloquio
in Avellino nell'estate del 1130; e il 27 settembre tra il Papa e il Duca fu
concluso in Benevento un concordato che non solo conferiva al Normanno nome e
diritti di re, ma altresì gli accordava che si sarebbe potuto far coronare re da
arcivescovi del regno a sua scelta. E Napoli sarebbe stata anche sua, e Capua,
e delle milizie di Benevento avrebbe usato a sua posta. Sarebbe bisognato solo
ch'egli e i suoi successori avessero riconosciuto il regno della Sede
pontificia e pagatogliene censo. Ruggiero tornato a Palermo convocò i Baroni
siciliani a parlamento, comunicò l'accordo col Papa, e ne chiese il parere:
tutti assentirono. E il cardinal Conti, legato del Papa, vi lesse un breve, già
combinato in Benevento tra Anacleto e Ruggiero, in cui quello, indirizzandosi a
questo, gli annunciava che per la virtù della potenza sua e la sua munificenza
verso la Chiesa egli s'era risoluto di farlo re, lui e i suoi successori, di
Sicilia, di Calabria e di Puglia; e tali li faceva in forza dell'autorità sua;
ed elevava la Sicilia a prima provincia del regno. Poi confermava tutte le
concessioni fatte dai suoi predecessori ai predecessori del Re: tra le quali
v'era pure la legazione di Sicilia, accordata da Urbano II al Gran Conte.
Ripeteva il dono di Napoli e del Principato di Capua. E v'era espresso il patto
che il Re dovesse mantenere fede al Papa, e pagare alla Chiesa romana un
tributo annuo di seicento schifat.
Non vi si diceva però, che il Re sarebbe decaduto, se non avesse mantenuto il
patto; bensì che sarebbe caduto in anatema chi vi si fosse opposto.
La cerimonia
della coronazione fu celebrata in Palermo nella vecchia cattedrale dal cardinal
Conti il 25 dicembre del 1130. Una infinita folla accorse da ogni parte a
goderne lo spettacolo. La magnificenza ne fu meravigliosa; ma io ne dirò questo
solo: non un sacerdote, ma un laico, il principe Roberto II di Capua, mise la
corona sul capo al Re.
Ruggiero regnò
altri ventiquattro anni. Il suo impero si distese sulle coste di Africa.
L'Oriente attirò anche lui. E che avesse sopra l'Italia ambizioni più larghe
del territorio, sopra cui regnò, lo prova il titolo che talora aggiunse agli
altri suoi, Italiæ rex: titolo contro
di cui i Pisani nel 1136 protestarono non con vane parole, ma con una flotta,
quantunque senza felice successo. Non fu uomo minore del padre e dello zio;
anzi maggiore per sapienza di governo e larghezza di mente. Un cronista lo dice
con verità provvido, sapiente, discreto, di sottile ingegno, di gran consiglio,
inclinato a usare piuttosto la ragione che la forza. E fu certo il più gran re
dei suoi tempi; poichè Guglielmo d'Inghilterra era morto nel 1087, prima che
Ruggiero nascesse.
A me è stato
chiesto di esporvi le origini di quella che fu prima la monarchia di Sicilia e
di Puglia, poi delle due Sicilie, poi Napoletana; io non oltrepasserò il mio
soggetto: pure quel nome che m'è venuto sulle labbra di Guglielmo il
Conquistatore mi ferma, e mi consiglia a fermarmi ancora per un momento. Anche
Guglielmo era Normanno, un bastardo di Roberto I, il quinto duca di Normandia.
Intraprese la conquista, come fu chiamata, dell'Inghilterra nel 1066, quando
già Roberto Guiscardo s'era fatto duca di Puglia e di Calabria. Si racconta
anzi, che si sentisse punto di emulazione a udire le alte gesta del Guiscardo.
Ora perchè la monarchia inglese, che fu l'opera di Guglielmo, ha avuto una
storia tanto diversa da quella della monarchia napoletana, che dove nella prima
è tutta l'unità e la potenza di un poema epico, nella seconda è tutta la
sconnessione e la fiacchezza di una serie di episodi? Certo, nell'undecimo e
nel duodecimo secolo la monarchia napoletana era assai più potente, e
risplendeva d'ogni pregio di forza e di civiltà assai più dell'inglese. Come e
quando la relazione s'è invertita? La monarchia inglese ha avuto variazioni e
molte nella sua dinastia, contese civili, feroci e lunghe nella sua storia; la
monarchia napoletana n'ha avuto di dinastie sei, e tutte di diversa nazione:
Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnuoli, Borboni. Perchè in quella la dinastia,
per effetto delle mutazioni stesse cui si è piegata, si è mantenuta; in questa
nessuna dinastia ha gittato radici? Perchè?
E poichè questa
dimanda sulla vita e sull'efficacia delle dinastie, mi è occorsa alla mente,
ditemi ancor questo. Nel principio dell'undecimo secolo, quando quell'omicida
del Butterico venne per il primo co' suoi fratelli e con seguito di cavalieri
in Italia, e fu primissima origine dei fatti onde nacque nel primo terzo del
duodecimo secolo la monarchia napoletana, viveva nel settentrione d'Italia a
cavaliere delle Alpi un picciolissimo conte, un Umberto Biancamano, il cui
primario possesso era il contado di Salmorene nel Viennese, un contado, che
contava, nientemeno, ventidue castelli. Vi aggiunse forse, del suo vivente, dal
1003 al 1056, in tutto o in parte, i contadi di Noyon, di Moriana, di Savoia,
di Bellay, il Ciablese e la Tarantasia. Nessuno potrebbe oggi misurarvi per
l'appunto i suoi dominî; ma, certo, la loro estensione doveva appena pareggiare
quella d'una delle provincie che fecero parte del regno di Ruggiero. Nel 1130,
quando questi fu coronato Re nel duomo di Palermo, i discendenti di Umberto
erano, sì, più potenti signori di un secolo innanzi, ma di gran lunga, di gran
lunga meno potenti di lui. Il quinto successore di Umberto, conte sin dal 1103,
Amedeo III, possedeva in soprappiù solo una parte della Contea di Torino, e
altresì un tratto di terra, forse il Bugey, donato da Enrico IV imperatore al
marchese Pietro e al conte Amedeo II nel 1074 per avergli conceduto il passo: e
in quello stesso anno ripigliava per poco la città di Torino che gli si era
ribellata. Che differenza tra i possessi di cotesto conte alpigiano, malamente
connessi insieme, attraversati e separati da altissimi monti, diversi per
qualità di popolazione, con quel mirabile complesso dei possessi isolani e
continentali del re Ruggiero? Questi assunse il titolo di Re d'Italia; fu il
primo dei principi del mezzogiorno a farlo, ma non fu l'ultimo; però nè egli nè
alcuni dei suoi successori compì l'impresa cui il titolo accennava. Perchè? E
perchè invece la compirono i discendenti di Umberto, tra i cui ascendenti v'era
forse stato qualcuno che l'avesse preso prima di Ruggiero, ma eran parsi per
tanto tempo poi così lontani dal potervi pretendere? Certo, l'unità regia
d'Italia doveva esser fatta dall'uno o dall'altro dei due regni che si
costituirono a così grande diversità di data, l'uno dalla dinastia normanna nel
1130, l'altro da quella di Savoia nel 1713; ed è curioso che al Duca di Savoia,
così si chiama fin dal 1416, il titolo di Re venisse dall'acquisto della
Sicilia, appunto perchè il Ruggiero aveva di quest'isola fatto un regno.
Nell'Italia Centrale e neanche nella Valle del Po, per diverse ragioni, si
sarebbe potuto aggruppare, addensare un nocciolo di forza, sufficiente a
compire l'impresa di una nuova unità politica dell'Italia come si sia. Dove il
soverchio di vigoria aveva esausto i potenti comuni del medio evo, dove ogni
vita politica s'era via via assiderata ed estinta, dove ogni possanza di armi
era venuta meno. Ma se è così, perchè dal regno del settentrione è venuta
l'unità all'Italia, e il regno del mezzogiorno n'è stato disfatto? Perchè?
Questi e molti
altri perchè mi si affollano alla mente, e il rispondervi sarebbe soggetto di
maggior interesse, che non è stato forse quello di cui vi ho discorso. Ma
richiedono che di questo si fosse discorso prima; e a ogni modo vogliono esser
trattati in pieno e con penetrante e imparziale esame. Troverete, di certo,
altri che ve li esponga così; e a me non resta se non di pregarvi a benedire la
storia tale e quale si è fatta e si è conclusa; poichè dalla triturazione di
tanti uomini e cose n'è uscito infine questo; che in voi io non saluto e
ringrazio Toscani, nè voi avete sopportato in me un napoletano: ma un italiano,
per desiderio vostro, vi ha parlato, e Italiani, per bontà loro, l'hanno udito.
LE ORIGINI DEL PAPATO
E DEL COMUNE DI ROMA
DI
Arturo Graf
Signore e Signori,
Nel gennaio
dell'anno 1077 seguiva in Italia uno dei fatti più memorabili che narrino le
storie del mondo. Per tre giorni di seguito, nella corte del Castel di Canossa,
un imperatore tedesco aspettava, vestito del saio dei penitenti, a capo
scoperto, a piè nudi, che il papa, dal quale era stato scomunicato e maledetto,
volesse ammetterlo alla sua presenza, largirgli l'assoluzione e il perdono.
Quell'imperatore aveva nome Enrico IV; quel papa Gregorio VII.
Com'era
possibile ciò? per quali ragioni, per quali vie era cresciuta così
formidabilmente la potestà di colui che pur si diceva servo dei servi di
Cristo? Gregorio sognò di far soggette alla potestà dei pontefici tutte le
potestà della terra; quale forza d'idee, quale concorso di eventi, suscitaron
quel sogno, e per poco non fecero che diventasse realtà?
Per intenderlo
bisogna risalire alle origini, bisogna rifar nello spirito il corso della
storia. Nella quale nulla è di miracoloso e d'inesplicabile; ma concatenazione
infinita di cause e di effetti, e logico esercizio di forze ineluttabili.
Vediamo prima
di tutto perchè e come sorgesse il papato, quella preminenza, cioè, che il
vescovo di Roma acquistò sopra gli altri vescovi; e perchè e come sorgesse e si
fermasse in Roma, e quivi, e non altrove, dovesse sorgere e fermarsi. Sarò
parco nel ricordo dei fatti, come l'indole e la misura del mio dire richiedono,
e mi studierò di trarne fuori l'anima che li fa muovere e ne dà ragione.
Per lungo tempo
le comunità cristiane particolari, le singole Chiese, trionfando delle
persecuzioni, anzi traendo da esse nuovo vigore e vita novella, s'andarono
moltiplicando per entro al mondo pagano, senza che l'una prevalesse, a dir
proprio, alle altre. Ciò non dimeno le comunità di più antica fondazione, o
fondate in città più cospicue, e in specie quelle che avevano, o si credeva
avessero avuto, a primo istitutore alcuno degli apostoli, dovevano di necessità
esser tenute in maggior concetto e primeggiare in qualche maniera. Il desiderio
della cattolicità, ossia della universalità, della quale è già cenno, sino
forse dal primo secolo, in una epistola di Sant'Ignazio, vescovo di Antiochia;
il bisogno di opporre a comuni nemici una comune difesa, e di serbare intera,
incorrotta, uniforme la dottrina di Cristo, nel che era la forza e la salvezza
di tutti; tendevano già per sè stessi, con lento ed inconsapevole lavoro, a
costituire certe forme di preminenza, tanto più durature e capaci d'incremento
quanto più utili. Le comunità non vivevano vita separata; vivevano anzi in una
perpetua comunione di pensieri, di parole e di opere, ricorrendo le une alle
altre, ogni qual volta nascesse un dubbio in materia di dottrina o di
disciplina, ogni qual volta avessero bisogno di consiglio o di aiuto. Così
stringevano fra loro vincoli d'interesse e di fratellanza, e, come avviene,
tendevano spontaneamente a raccogliersi e ordinarsi intorno ad un centro.
In origine il
primato spettò di pien diritto a Gerusalemme, dove il Redentore aveva insegnato
ed era morto, e dove gli apostoli avevano ricevuto lo Spirito Santo prima di
separarsi e muovere all'opera della predicazione. Se la storia fosse governata
da preconcetti ideali, inflessibili ed inviariabili, Gerusalemme avrebbe dovuto
essere la Chiesa madre dell'orbe cristiano, e la natural sede del pontificato;
invece di fronte a lei sorsero: Antiochia, ch'era stata il centro della
predicazione di San Paolo; Alessandria, che aveva ricevuto la nuova fede da San
Marco: Roma, che due apostoli avevano consacrata col sangue, ed era la
metropoli del mondo. Il primato di Costantinopoli era ancora di là da venire.
Per un certo tempo Roma non fu maggiore delle altre Chiese maggiori; ma non
tardò molto a crescere sopra tutte le altre. E così doveva avvenire.
Fu veramente
San Pietro in Roma? vi sofferse egli veramente il martirio? È questo un dubbio
che diede materia a infinite dispute, un dubbio che la critica sino a questi
giorni non potè risolvere, e che forse non potrà risolvere mai. Se non vi fu,
dovette certo desiderare di andarvi, perchè le forze del cristianesimo nascente
già tendevano verso Roma, a cui tutto tendeva; perchè il mondo non poteva esser
fatto seguace di Cristo, se prima al mite giogo di Cristo non si piegava la
città ch'era capo del mondo, e perchè all'entusiasmo dei primi cristiani un
tale trionfo doveva sembrare sopra tutti gli altri glorioso e magnifico. Sia
come si voglia, certo è che, in Roma, la credenza alla venuta e
all'insegnamento del principe degli apostoli nella città, appar viva sino dal
principio del secondo secolo, e che se questa era leggenda, era leggenda
necessaria, di cui si scorgono immediatamente gli effetti. La Chiesa fondata da
San Pietro e da San Paolo doveva non solo, per ragionevole presunzione,
possedere la dottrina nella maggior sua integrità e purezza, ma avere ancora
sopra tutte l'altre Chiese quello stesso primato che sopra tutti gli altri
apostoli Cristo aveva conferito a San Pietro. I Papi furono dunque legittimi
successori di San Pietro, appunto perchè successori di lui furono papi.
Il sentimento
di questo primato s'andò facendo sempre più vivo ed universale, e più saldo il
proposito di farlo valere. Ireneo, vescovo di Lione, e martire nei primi anni
del secolo terzo, risolutamente affermava in un suo scritto contro gli eretici
Valentiniani, che tutte le Chiese debbono conformarsi alla Chiesa di Roma in
ragione della preminenza che le spetta, e non molti anni dopo Cipriano, vescovo
di Cartagine, diceva in una delle sue epistole: «V'è un solo Dio, e un solo
Cristo, e una sola Chiesa, e una sola cattedra, fondata per le stesse parole
del Signore su Pietro»; e chiamava in un'altra epistola sua la Chiesa di Roma
«radice e matrice della Chiesa cattolica». Già Vittore I (192-202) aveva
asserita la sua prerogativa; mezzo secolo più tardi, Stefano I (253-257),
escludendo dalla comunion dei fedeli alcuni vescovi, che in certa question di
battesimo, non consentivano con le dottrine di Roma, derivava il suo diritto
dal diritto di Pietro, in cui era fondata la Chiesa, e di cui egli era il
legittimo successore. La tomba del principe degli apostoli diventò come il
Palladio, nonchè di Roma cristiana, del papato.
La dimora e il
martirio di San Pietro in Roma, o la opinione di quella dimora e di quel
martirio, dovevano, senza dubbio, conferire potentemente al primato della
Chiesa di Roma e del vescovo di essa; ma non credo che per sè potessero
produrlo ed assicurarlo. Il soggiorno, l'insegnamento, la morte di Gesù in
Gerusalemme, non bastarono a conferir quel primato a Gerusalemme, anzi non
bastarono nemmeno, nel tempo che seguì, a riscattarla dalla dominazione degli
infedeli. Se San Pietro avesse insegnato e fosse morto in alcun'altra città
dell'Oriente e dell'Occidente; e poniam pure che fosse delle maggiori, quella
città non sarebbe divenuta per questo, ecclesiasticamente parlando, madre delle
altre, e non sarebbe divenuta sede del papato. A tale officio era serbata Roma.
Senza Roma, assai probabilmente non vi sarebbe stato papato, o sarebbe stato un
papato assai diverso da quello che fu; e senza papato, o con un papato diverso,
è assai dubbio se vi sarebbe stata cattolicità. Sembra strano a dire, ma non è
men vero che ad instaurare la Chiesa cattolica, e a fondare pei secoli la
potestà dei papi, ci volle tutta la forza di Roma pagana.
Ho già detto
che le forze cristiane tendevano a Roma naturalmente, perchè Roma era il cuore
e il capo del mondo; perchè tutto, da tutte le parti del vastissimo impero,
tendeva a Roma, e concorreva in Roma. Si ricordi come le altre religioni erano
confluite verso la città imperiale, desiderose di assidervisi e di acquistarvi
come un nuovo lustro e una nuova consacrazione. I cristiani detestavano Roma,
figurata nell'Apocalisse come la bestia dalle sette teste, e la chiamavano col
nome ingiurioso di Babilonia; ma non sapevano e non volevano staccarsi da lei.
Dove tanti elementi e tante forze concorrevano, la vita si faceva più intensa
ed operosa, e l'organismo di quella Chiesa vigoreggiava e cresceva, come
vigoreggia e cresce nell'organismo animale un membro in cui più operose e più intense
si raccolgano le energie della vita.
Roma era la
sede dell'impero, e doveva, anche per ciò, diventare la suprema sede del
cristianesimo: l'imperatore che avversava e perseguitava la nuova religione,
l'imperatore doveva, senza volerlo, suscitare il papa. In fatto era naturale
che il vescovo il quale si trovava in più immediata opposizione con Cesare, e
che di Cesare, più da vicino, sfidava i decreti e la maestà, dovesse
acquistare, nel concetto dello universe genti cristiane, una maggiore
importanza, una maggior dignità, e l'una e l'altra tanto maggiori, quanto meno
efficaci contro la Chiesa governata da lui gli editti di Cesare. Al qual
proposito è pur da notare che la ostilità degli imperatori giovò anche in altro
modo al papato; giacchè se gl'imperatori fossero stati sin dal principio
cristiani, e amici e tutori dei vescovi di Roma, assai probabilmente, o prima o
poi, in una o in un'altra maniera, si sarebbero mutati di amici e tutori in
padroni, avrebbero usurpato molte attribuzioni e molti offici di quei vescovi,
avrebbero, con altre parole, ucciso il papato sul nascere. Più e più fatti dei
tempi posteriori, e l'esempio memorabile dei patriarchi di Costantinopoli,
divenuti schiavi e strumenti degl'imperatori loro, non lascian dubbio di ciò.
Ma sopratutto
conferì Roma alla istituzione e perpetuazione del papato con quel carattere di
universalità che le era proprio, con quel suo vanto di eternità, che così
spesso risuona sulle labbra degli scrittori pagani, e per quel convincimento
suo proprio e di altri, anzi di tutti, allora e dopo, attraverso ai secoli,
attraverso a tutti i rivolgimenti, le vicissitudini, le ruine della storia, che
in lei, e solamente in lei, fosse la sorgente prima di ogni diritto e di ogni
sovranità. Roma caput terrarum e caput rerum, doveva pur essere caput
Ecclesiæ. La cattolicità religiosa non sarebbe stata possibile senza
quell'altra cattolicità, civile e politica, che da Roma, e nel suo nome s'era
diffusa nel mondo. La religione di Cristo, non nazionale, come la giudaica, non
chiusa entro i termini di una patria, non legata necessariamente a un ciclo
storico, ma liberale e universale, preposta per tutti i tempi a tutte le patrie
e a tutti i popoli, ebbe, a dispetto degli oltraggi e delle persecuzioni,
grandissimo aiuto e grandissimo incremento da quella Roma intorno a cui e sotto
alla cui potestà s'erano congregate e fuse le genti. La religione di Cristo
presuppone un concetto capitale e nuovo, quello di umanità; e tale concetto
appunto Roma aveva suscitato ed elaborato, e tradotto ancora, per quanto
concedevano i tempi, in un fatto. Senza Roma il Cristianesimo non avrebbe
potuto sorgere, o, sorto, non avrebbe potuto diffondersi.
Tanto è ciò
vero che gli stessi cristiani cominciarono, appena sopravvenuti tempi migliori,
a considerare Roma come un proprio istrumento della Provvidenza, e a dire che a
lei era stato commesso da quella il glorioso officio di preparare il mondo alla
venuta del Redentore, e di spianare le vie alla diffusione della nuova
dottrina. Prudenzio, nato verso il mezzo del quarto secolo, Prudenzio che
giudica Roma la più magnifica delle opere della Provvidenza, dice nel suo poema
contro Simmaco: O Roma, vuoi tu sapere perchè sei salita tant'alto? e perchè
tutto il mondo soggiaccia al tuo freno? Dio, volendo consociar tutti i popoli,
e stringere in un concorde amore tutti gli animi, li fece soggetti al tuo
impero, perchè non possono le genti congiungersi degnamente con Cristo, se
prima un unico spirito non le congiunga fra loro. In conformità di tali idee
scrisse Paolo Orosio i sette libri delle sue storie contro i pagani, sforzandosi di provare che tutta la storia passata
di Roma, la sua gloria e la sua potenza, altro non erano che una preparazione
del Cristianesimo. Questo concetto ebbe ancora il medio evo, e si vede espresso
da Dante in quei noti versi del secondo canto dell'Inferno, dove, ricordata Roma e ricordato l'impero, dice:
La quale e il
quale, a voler dir lo vero,
Fûr stabiliti
per lo loco santo
U' siede il
successor del maggior Piero;
e soggiunge che
Enea, nell'inferno, ove gli era stato concesso di penetrare,
Intese cose che
furon cagione
Di sua vittoria
e del papale ammanto.
Ancora il nome
di Roma doveva favorire potentemente l'opera della propagazione della fede,
alla quale per secoli attesero i papi con instancabile zelo; perchè i popoli,
assuefatti a ricevere da Roma la legge politica, dovevano essere naturalmente
proclivi a ricevere da lei anche la legge religiosa; e tutti sanno quanto il
nome e la maestà della metropoli del mondo potesse sullo spirito degli stessi
barbari invasori. Da altra banda, i popoli da sì lungo tempo piegati alla
signoria politica di Roma, dovevano facilmente ancora piegarsi alla signoria
ecclesiastica che in lei si veniva formando, e, senza quasi avvedersene,
aiutarla e promuoverla. Tale e tanto fu quel glorioso nome di Roma, che valse,
per secoli, a dar sembianza, e persino qualche spirito di vita, a un fantasma,
a quello che il Petrarca diceva nome vano
senza soggetto, al restaurato impero d'Occidente: come non avrebbe esso
giovato a un organismo pien di vigore e di vita qual era il papato?
Così è che, per
tutte queste ragioni, la potestà dei romani pontefici andò di mano in mano
crescendo, finchè divenne preminenza incontestata ed assoluta; ma fu
instaurazione lenta e lunga, turbata da numerose vicende e da gravi peripezie.
Il maggiore pericolo a quella preminenza venne (chi il crederebbe!) dai primi
imperatori che abbracciarono il cristianesimo. Nota è la storia di Costantino,
sebbene non al tutto palesi e chiare sieno le ragioni del suo operare. Vinto
Massenzio, Costantino promulgò l'anno 313 il famoso editto di Milano, che
sanciva la piena libertà religiosa, senza favorire delle due religioni nemiche,
la pagana e la cristiana, più l'una che l'altra. E in questa parità si durò
dieci anni, e furono molti, perchè non era condizione che potesse durare a
lungo. Appena ebbe maturato nell'animo il proposito di dare all'impero maggiore
unità e salvezza, Costantino fu condotto a vagheggiare quella uniformità
religiosa di cui per lo innanzi non si era curato. Vinto Licinio, egli, che pur
si fregiava del pagano titolo di pontifex
maximus, egli che non si fece battezzare se non presso a morte, cominciò a
favorire il cristianesimo, a perseguitare il paganesimo. In sulle prime non
s'immischiò nelle facende interne della Chiesa di cui s'era fatto tutore; ma
non andò molto che vi s'intromise assai più del dovere, e convocò sinodi, fra i
quali il famoso ecumenico di Nicea, esiliò vescovi, e li ripristinò
nell'ufficio ond'erano stati privati. La potestà laica invadeva il dominio
della potestà ecclesiastica, e, come sempre, dalla commistione e dalla
confusione delle due potestà nascevano turbazioni e disordini, onde s'aveva a
risentire tutta la compagine della Chiesa.
Sotto parecchi
degl'imperatori che seguirono le cose andarono peggiorando, perchè su questo
sdrucciolo era difficile fermarsi. Il beneficio di Costantino fu pagato a caro
prezzo. Non solo si videro imperatori favorir l'eresie e promuovere le contese;
ma se ne videro di quelli che usurparono il posto e l'ufficio dei vescovi.
Riappariva l'imperatore pontifex maximus
sotto sembianze cristiane. Costanzo, che convoca concilii, che decreta in
materia religiosa come in materia civile, che impone simboli, quasi fosse il
legittimo interprete dello Spirito Santo, e che nel sinodo di Milano del 355
getta in viso ai padri stupiti ed esterrefatti il memorabile placito: Canone è la mia volontà; Costanzo, cui
il più perseguitato dei vescovi, Atanasio di Alessandria, dà il nome di
Anticristo, che tre secoli innanzi era stato dato a Nerone, è imperatore e papa
ad un tempo, e caccia in esilio l'altro papa Liberio, quando questi ardisce di
levarglisi a fronte e di contrastargli. Tali, ed altre simili intrusioni e
soperchierie, erano del resto provocate continuamente dalle stesse fazioni che
tenevano in subbuglio la Chiesa, e non meno dagli avversarii che dai
propugnatori dell'ortodossia, i quali tutti, quando più non isperavano di
vincere colle ragioni, o coi sofismi e le calunnie, volentieri si volgevano per
aiuto a chi aveva la forza e non era malcontento di adoperarla. Le fazioni
cercavano di aver dalla loro l'imperatore, e l'imperatore, com'era naturale (e
non sempre forse fu male), cercava di assodare e rendere assoluto il dominio
suo facendosi arbitro delle coscienze, avocando a sè la suprema autorità
spirituale.
Il papato corse
allora grave pericolo; ma tante erano del rimanente le condizioni che il
favorivano, tanti gli aiuti che gli venivano da ogni banda, e tanta avvedutezza
e costanza ebbero i vescovi di Roma, che il pericolo fu superato e la vittoria
ottenuta. Già il concilio di Sardica, sino dall'anno 347, aveva riconosciuta e
proclamata la preminenza del vescovo di Roma; nel sinodo di Costantinopoli, del
381, il vescovo di Roma fu dichiarato primo in dignità, quello di
Costantinopoli secondo. Verso la fine del secolo VI, e dopo, a più riprese,
gl'imperatori bizantini tentarono di dichiarare ecumenico veramente il loro
patriarca, che già più volte aveva usurpato quel nome e di sostituirlo al papa
di Roma, troppo lontano e troppo riottoso; ma ogni loro conato fu inutile.
Valentiniano,
dopo la breve riscossa che il paganesimo ebbe con Giuliano l'Apostata,
ripristinò la libertà dei culti; ma con Teodosio il cristianesimo diventò
stabilmente religione dello Stato. La chiesa d'Occidente, in opposizione con
quella d'Oriente, sempre più tendeva ad escludere da ogni giurisdizione sua il
potere civile, ed a rendere autonomo il supremo ministero ecclesiastico. Gli
avvenimenti incalzavano e favorivano quella tendenza. Per un complesso di cause
e di condizioni che non tocca a me rintracciare, l'organismo dello Stato in
Occidente s'andava sempre più indebolendo, e s'avviava alla morte; e di quanto
lo Stato s'indeboliva, di tanto s'afforzava la Chiesa, sempre più emancipata da
quella incomoda soggezione. Tutte le menti e le volontà e le virtù che altrove
oramai non avevano modo di esercitarsi, voltavansi spontaneamente alla Chiesa,
si raccoglievano in lei. Ciò che era vivo cercava la vita, e la vita era nella
Chiesa, e la morte dello Stato era necessariamente accelerata dal defluir delle
forze verso la Chiesa. Questo non era un caso nuovo nella storia. A poco a poco
la gerarchia ecclesiastica s'instaura, le chiese per la pietà dei fedeli
straordinariamente arricchiscono, la monarchia spirituale dei papi si fonda.
Leone I, che meritò il nome di Grande, ebbe immensa autorità; fece, nel 453,
tornare addietro Attila; mitigò, nel 455, gli orrori della irruzione di
Genserico. I barbari distruggevano l'impero d'Occidente; ma, convertiti già al
cristianesimo, rispettavano la Chiesa, s'inchinavano dinanzi al suo pontefice.
Mentre Teodorico sconfiggeva Odoacre, e si apparecchiava a farsi padrone
d'Italia, Gelasio I rispondeva alle prepotenze dell'imperatore Anastasio con
una lettera famosa, ove l'autorità dei vescovi è separata risolutamente
dall'autorità dei principi, anzi è fatta maggiore con argomenti che i
successori di lui non mancheranno di ripetere. E quando, nel 524, il pontefice
Giovanni, primo di questo nome, andò, forzato da Teodorico, a Costantinopoli,
per farvi cessare la persecuzione contro gli Ariani, l'imperatore Giustino
mosse, col popolo, solennemente a riceverlo, gli si gettò ai piedi, e volle
essere di bel nuovo incoronato da lui.
Intorno a quel
tempo ancora, senza che si possa dire con precisione quando, cominciò l'uso di
serbare al solo vescovo di Roma il nome di papa, nome che per lo innanzi non
aveva significato alcuno di prerogativa, e soleva darsi a tutti i vescovi
indistintamente, ed anche ai semplici chierici. Così pure il nome di pontefice,
che fu da prima comune a tutti i vescovi, diventò proprio dei vescovi di Roma,
e significativo del loro primato.
Ma la potestà
dei papi non cresceva e non si assodava senza molte vicissitudini e scadimenti
repentini, così volendo la turbata e violenta condizione dei tempi. Le elezioni
suscitavano cupidigie, si lasciavano dietro rancori, e non sempre eran libere,
e spesso furono occasione di turbolenze e di scandali.
Nei primi
secoli la elezione del papa spettava, come quella di tutti i vescovi in
generale, al clero ed al popolo; ma i principi non tardarono a intromettervisi
in varii modi, indicando norme e procedure, arrogandosi di decidere in caso di
contestazione, pretendendo di confermare l'eletto, o, a dirittura, di designar
colui su cui dovevano raccogliersi i voti.
Ai tempi di
Atalarico e di Amalasunta la confermazione regia costava 3000 monete d'oro.
Teodato da prima restituì la libertà della elezione, poi impose Silverio. Nè
per questo rispetto, come per altri, fu la dominazione greca migliore di quella
dei Goti. Non solo gl'imperatori s'ingerirono nelle elezioni, ma deposero i
papi non graditi da loro. Silverio fu deposto ed esiliato, e in esilio morì,
credesi, di fame. La condizione dei papi non fu allora migliore di quella dei
patriarchi di Costantinopoli, anzi fu peggiore per più rispetti: le elezioni si
fecero senza nemmeno più consultare i Romani.
Vennero i
Longobardi, e s'impadronirono della più gran parte d'Italia: gl'imperatori
d'Oriente non v'ebbero quasi più che una parvenza di dominio, e la Chiesa fu
sottratta anche una volta al loro pessimo giogo. Ma tutto ciò non avvenne in un
giorno. Salì sulla cattedra di Pietro un papa, riconosciuto come uno dei
maggiori che la Chiesa abbia avuto, Gregorio Magno, soprannominato il Console di Dio, il quale spese la vita
in riforme d'ogni maniera, e nella costante rivendicazione dei diritti inerenti
al suo ministero. Egli s'oppose vigorosamente alla pretensione del patriarca di
Costantinopoli di fregiarsi del titolo di ecumenico; tenne testa
all'imperatore, che non senza riposti intendimenti favoriva quella pretensione;
e fra Greci e Longobardi, fra pericoli e difficoltà d'ogni sorta, seppe
procacciare alla Chiesa una notabile indipendenza. Sotto i successori suoi le cose
mutarono di bel nuovo in peggio, di bel nuovo gravò su Roma e la Chiesa il
despotismo degl'imperatori; ma durante la lunga e fastidiosa contesa pel culto
delle immagini, tutto l'Occidente s'oppose all'Oriente, e i papi insorsero
contro la prepotenza degli autocrati di Bisanzio. Vero è che alle prepotenze di
costoro tennero dietro quelle dei Longobardi, più infesti assai perchè più
vicini.
Non è punto
facile formarsi un giusto concetto dell'autorità dei pontefici in questo tempo
e del rispetto ond'essi godevano. Il mutare continuo delle fortune, il cozzare
violento dei più disparati interessi, la ruina degli ordini appena instaurati,
eran cagione che la stessa istituzione del papato non potesse acquetarsi in una
forma stabile di diritto e di consuetudine. I principii ideali erano abbastanza
determinati e saldi, ma spesso erano offesi e manomessi nella persona reale del
pontefice che gl'incarnava. Si venerava il papa astratto; si deponeva,
s'ingiuriava, si mutilava il papa concreto; e la ruvidezza delle coscienze, e
la barbarie dei costumi, non lasciavano scorgere la mostruosità della
contraddizione. Quello stesso Liutprando, che menava per la briglia il cavallo
del papa Zaccaria, aveva forzato Gregorio III e i Romani a invocare contro di
lui l'aiuto di Carlo Martello e dei Franchi.
I Franchi
vennero, con Pippino prima, con Carlo Magno poi, e distrussero il regno dei
Longobardi e posero fine all'odiata loro dominazione. Il giorno di Natale
dell'anno 800, Carlo Magno ricevette in Roma, nella basilica del principe degli
apostoli, dalle mani di Leone III, la corona imperiale. Cessava così ogni
ragione degl'imperatori bizantini sopra Roma e sopra l'Italia; risorgeva dopo
tre secoli l'Impero d'Occidente. Leone III non poteva immaginare allora che
l'impero e il papato dovevano diventare nemici più tardi, e riempiere il mondo
dello scandalo e del rumore delle loro secolari contese.
Non ridirò le
vicende e le fortune del papato nel tempo degl'imperatori franchi, e poi nel
tempo degli Ottoni, storia avviluppata e lunga, sopra alcun punto della quale
bisognerà ch'io ritorni. La restaurazione dell'impero non era senza pericoli
del papato, perchè non era possibile che gl'imperatori non chiedessero, o non
usurpassero, diritti e prerogative tali da menomare più o meno l'autorità e la
libertà dei pontefici. E cominciò Carlo Magno a darne l'esempio, Carlo Magno,
di cui il papa fu un vero e proprio vassallo. Ma non era possibile, da altra
banda, che il danno crescesse oltre a certa misura, e che l'impero
sopraffacesse durevolmente il papato, perchè l'impero era e rimaneva,
essenzialmente, una finzione, e il papato era una cosa viva e reale, e piena di
forza. L'autorità imperiale si dissolveva come appena mancasse un uomo di
grande e vigoroso animo per tenerla insieme e sorreggerla, mentre l'autorità
papale era assai più nella istituzione che negli uomini. E a crescer forza alla
istituzione vennero in buon punto, verso il mezzo del IX secolo, le famose
Decretali del falso Isidoro, che a nuove pretensioni dei papi recarono il suffragio
di antiche, simulate risoluzioni, e furono di sì gran peso e di tanta efficacia
allora e poi, che da esse appunto si suole far cominciare una nuova età nella
storia del papato. Così, a dispetto dei rigori degli Ottoni, a dispetto delle
brutture e delle violenze per cui è celebre quel tristo periodo della storia di
Roma che va sotto il nome di pornocrazia, l'autorità dei pontefici andò,
sebbene interrottamente, crescendo. Scomunica ed interdetto erano diventati
armi terribili. Il 18 giugno del 1053 i Normanni vinsero a Civitate Leone IX,
che in armi s'era mosso contro di loro, e lo fecero prigioniero; ma come
udirono ch'egli si piegava a levare l'interdetto con cui li aveva colpiti, gli
si gettarono ai piedi, e gli fecero ressa d'attorno per baciargli le mani. Poco
dopo si compieva, per opera di Cerulario, la separazione, già cominciata con
Fozio, della Chiesa greca dalla latina; ma l'autorità dei pontefici, se veniva
a mancare in Oriente, cresceva sempre più in Occidente.
E ad assicurare
vie meglio tale autorità una grande innovazione fu introdotta nel 1059 da
Niccolò II, inspirato in ciò e in altro da quell'Ildebrando che doveva esser
papa a sua volta col nome di Gregorio VII. Da tempo immemorabile la elezione
dei pontefici era, come abbiamo veduto, occasion di raggiri, di soprusi, di
turbamenti d'ogni maniera. I pontefici non potevano sperare indipendenza e
libertà piena per sè e per la Chiesa, se prima non liberavano da qualsiasi
ingerenza straniera la propria elezione. Guidato da tale pensiero, Niccolò II
fece votare dal Concilio Lateranense di quell'anno un decreto, in virtù del
quale la elezione del pontefice fu deferita al collegio dei cardinali, mentre
all'imperatore, al rimanente del clero, al popolo, non fu lasciato altro
diritto che quello dell'approvazione. L'importanza e la forza di tale
provvedimento furono subito avvertite da chi n'era leso. Non molto dopo, al
decreto conciliare fu contrapposta una falsificazione dettata evidentemente da
spirito imperiale, falsificazione che assegnava all'imperatore un posto fra i præduces, o promotori della elezione.
E il 22 di
aprile dell'anno 1073 fu eletto dai Cardinali, consenziente tutto il clero,
plaudente il popolo, Gregorio VII, il quale era già stato l'amico e il
consigliere di parecchi pontefici, e il vero operatore delle riforme consentite
da loro. Gregorio VII meditò la monarchia universale teocratica. Volle sciolto
il clero, sciolte le corporazioni religiose da ogni dipendenza dalle potestà
laiche, e proibì le investiture; strinse con mano vigorosa tutte in un fascio
le forze della Chiesa; scomunicò Enrico IV; svincolò i sudditi suoi dal debito
di fedeltà. Pensava e dichiarava che il potere dei re è frode diabolica; che
colui a cui era stata concessa potestà di aprire e di serrare le porte del cielo
doveva essere giudice della terra; che il papa ha diritto di deporre gli
imperatori; che le insegne imperiali appartengono a lui solamente; che i popoli
tutti devono prostrarglisi ai piedi. Gregorio VII e i primi successori suoi
fecero della potestà dei papi la potestà massima del medio evo, una potestà che
accoglieva dentro di sè, e da cui scaturiva, come da sorgente, ogni autorità
ecclesiastica, ogni autorità laica.
In fatto, la
Chiesa allora è tutta nel papa, o è un'emanazione del papa. I vescovi hanno perduto
ogni autonomia, e non serbano altra autorità che quella che è delegata loro dal
pontefice, di cui sono fatti gli strumenti. La infallibilità è dei pontefici, e
non dei concilii, i quali non hanno altro officio che di approvare. Innocenzo
III non si contenta più di chiamarsi, come i suoi predecessori, vicario di
Pietro, ma vuol essere chiamato vicario di Cristo, e afferma che ciò che il
pontefice vuole e opera, vuole e opera come Dio, non come uomo. Si vede subito
quali conseguenze possono essere tratte da un'affermazione così fatta. La
volontà del papa è la volontà stessa di Dio, e perciò non è lecito contraddirla
nè discuterla. Agostino Trionfo, nella sua Summa
de potestate ecclesiastica, composta a richiesta di Giovanni XXII, giunse a
dire che non si può appellare dal giudizio del papa al giudizio di Dio, essendo
l'appello solamente possibile da un giudice inferiore a uno maggiore, e papa e
Dio essendo una cosa sola.
Per ciò che
spetta alla potestà laica l'ordine è a dirittura invertito. A tempo degli
Ottoni noi vediamo il pontefice dipendere dall'imperatore, e porgere
all'imperatore, il quale, in sostanza, è arbitro delle elezioni, il giuramento
di fedeltà. Ora è l'imperatore che dipende dal papa, è fatto una creatura del
papa. Innocenzo III ripete ciò che aveva detto Gregorio VII, ciò che ripeterà
qualche anno più tardi Innocenzo IV: la potestà laica non può essere legittima
se non derivi dalla ecclesiastica. L'imperatore non può ricevere la corona se
non dal papa, e non è imperatore se da lui non la riceve. I regni sono dati dal
papa in feudo a chi li governa. La relazione vicendevole dei due poteri è
chiarita con la famosa comparazione dei due luminari, del sole ch'era il papa,
della luna ch'era l'imperatore. Queste dottrine trionfavano. Ottone IV, incoronato
da Innocenzo III, si fece chiamar re dei Romani per la grazia di Dio e del
papa; Pietro d'Aragona riceveva in feudo il suo regno e si riconosceva
tributario e vassallo della Chiesa; Giovanni Senza Terra deponeva la corona per
riprenderla, in più legittima forma, dalle mani del legato Pandolfo.
L'inquisizione e i nuovi ordini monastici aiutavano potentemente l'assolutismo
dei papi.
Questo
assolutismo, la commistione dei due poteri e dei due reggimenti ch'esso portava
con sè, ebbero avversari ardenti e risoluti, suscitarono biasimi e rampogne
senza fine. Basta ricordar l'Alighieri, che oppose all'eccessive pretensioni
dei papi il suo trattato De Monarchia,
e in molti luoghi del poema avventa contr'esse i fulmini dell'ira sua. Certo,
quella commistione fu causa di molte sciagure o di pervertimenti irreparabili;
ma lo storico imparziale deve pur riconoscere ch'essa era necessaria e
inevitabile. Le pretensioni di pontefici come Gregorio VII ed Innocenzo III
sono la logica conseguenza di certe premesse, dalle quali si svolgono come la
pianta dal seme.
Gesù Cristo
aveva in mente e voleva la separazione delle due potestà, spirituale e
temporale, quando pronunziava le memorabili parole: Date a Cesare ciò che è di Cesare; date a Dio ciò che è di Dio.
Dopo lui, molti vollero, e molti si adoperarono a ottener quel medesimo, finchè
ai giorni nostri fu proclamata, come provvedimento ottimo di ragione e di
diritto, la separazione totale della Chiesa e dello Stato. Se non che, tale
separazione, quanto è facile in teorica, altrettanto è difficile in pratica, e
se potrà effettuarsi ora, o in avvenire, certo non poteva effettuarsi in
passato. Notisi che gli stessi concetti fondamentali sono qui molto difficili
da fermare e da circoscrivere; che non si può dire, con precisione dove finisca
lo spirituale e dove il temporale cominci; e che essendo, così dell'uno come
dell'altro, subbietto ed obbietto l'uomo, di necessità debbono spirituale e
temporale entrar l'uno nell'altro. Ond'è che noi vediamo, o la potestà laica
cercare di sopraffar la ecclesiastica, o questa cercare di sopraffar quella.
Non sempre, del resto, ci fu frode o violenza: più d'una volta l'una potestà
consentì, o a dirittura chiese l'ingerenza dell'altra; più di una volta sì
fatta ingerenza fu resa necessaria dalla condizione dei tempi, dalle storiche
vicende.
Giustiniano, il
quale pure usurpò non pochi diritti e offici dei papi, volle, nondimeno, che i
vescovi dirigessero la elezione dei più cospicui officiali della diocesi; che
vigilassero il loro operato e l'uso che si faceva del pubblico denaro; che
soprintendessero alle fabbriche e alle prigioni; avessero in tutela i minori.
Promulgando la prammatica sanzione, egli conferì loro anche la elezione della
più parte degli ufficiali provinciali e la vigilanza dei loro atti.
Sopraggiunti
tempi calamitosi, nella confusione e nella ruina degli ordinamenti antichi, la
potestà civile dei vescovi, e più quella dei papi, dovettero andare
necessariamente crescendo. Quando l'Italia, abbandonata alle proprie sue forze
dagl'imperatori d'Oriente, ebbe a difendersi, come potè, dalle violenze dei
Longobardi, spesso ogni autorità si raccolse nei vescovi, come in coloro che
soli erano in grado di assumerla. «Sono tante le faccende pubbliche,» scriveva
Gregorio Magno ai patriarchi dell'Oriente «cui deve attendere qui chi ha nome
di vescovo, da lasciar dubbio se egli abbia officio di pastore d'anime o di
principe secolare». Lo stesso Gregorio, che per tutto il tempo del suo papato
dovette accudire, com'egli pur dice, ai chierici, ai monasteri, ai poveri, al
popolo e, per giunta, ai Longobardi, lo stesso Gregorio fu principe e papa ad
un tempo, e con ragione poteva egli scrivere in altra sua lettera: «Sono già
ventisette anni che in questa città noi viviamo tra le spade dei Longobardi; e
non è da dire quanto tributo debba ogni giorno questa Chiesa porgere loro,
perchè ci sia conceduto di vivere. Avvertirò solo che come in Ravenna è un
tesoriere imperiale che provvede alle spese quotidiane, così in questa città
sono io fatto tesoriere loro per ogni occorrenza.» Estraniandosi sempre più
Roma dall'impero, Gregorio III fece restaurare a proprie spese le mura della
città.
In questi fatti
non è usurpazione di poteri, ma naturale accessione, richiesta dagli
avvenimenti. Se i papi avessero voluto allora attendere al solo ufficio
pastorale, astenendosi da ogni ingerenza nei civili negozii, avrebbero
aggravato i pericoli e i mali ond'erano afflitte in più particolar modo le
popolazioni d'Italia. La nuova potestà veniva loro, più che da altro, dallo
scadimento e dalla defezione della potestà laica ordinaria. Più tardi fu la
stessa potestà laica quella che nei pontefici riconobbe un'autorità diversa
dalla spirituale. Come nei primi secoli della Chiesa si videro più d'una volta
le parti chiamar giudici delle loro contese gl'imperatori, attribuendo loro,
per la speranza di vincere, un'autorità spirituale che quelli non avevano; così
più tardi si videro principi chiamar giudici i papi in cause civili e
politiche, attribuendo loro, per la speranza medesima, una autorità che quelli
non avrebbero dovuto avere. Esempio memorabile a tale riguardo è quel di
Pippino, seguito poi da altri in gran numero. L'anno 751, Pippino, figlio di
Carlo Martello, e maggiordomo di quell'ombra di re che fu Childerico III, mandò
a Roma il vescovo Burgardo e il cappellano Folrado, con missione d'interrogare
il papa Zaccaria circa i re di Francia, «i quali non avevano più in quel tempo
regal potestà; se ciò fosse bene o non fosse». Non v'è dubbio che il papa
avrebbe dovuto rispondere alla subdola domanda con affermare esplicitamente il
diritto del re legittimo; ma premuto ogni giorno più dai Longobardi, non
potendo sperare aiuto se non dai Franchi, e non lo potendo ottenere se non a
patto di avere amico Pippino, fece atto di cattivo sacerdote, ma di buon
politico, e mandò a rispondere a Pippino «esser meglio che il nome di Re si
desse a colui il quale aveva la potestà, anzichè a colui che non avendo la
potestà, riteneva il nome». E così «per non turbar l'ordine, per l'apostolica sua
autorità ordinò che Pippino fosse re». Childerico fu deposto, e Pippino, unto
re dai vescovi di Gallia, ne tolse il luogo. Tre anni dopo, Stefano III,
volendo assicurar meglio il fatto, e dargli maggior solennità, consacrò di bel
nuovo Pippino, e insieme con lui la moglie Bertrada, e i figliuoli Carlo e
Carlomanno, conferendo a quello e a questo il titolo di patrizii dei Romani; e
benedisse i signori Franchi presenti, ammonendoli sotto minaccia d'interdetto e
di scomunica, di non più mai eleggersi un re d'altra schiatta. Passato mezzo
secolo, Carlo Magno riceveva da un altro pontefice la corona del rinnovato
impero.
Come dunque non
avrebbero i papi attribuito a sè medesimi il diritto di creare i principi e
disporre dei regni, se tale diritto era ammesso ed invocato da coloro appunto
che avrebbero dovuto negarlo e combatterlo? e che cosa si poteva
ragionevolmente opporre ai papi, e alle pretensioni loro sopra l'impero,
quando, in sostegno di quelle pretensioni medesime, i papi recavano innanzi il
fatto irrecusabile che per opera loro era avvenuta la traslazione della
sovranità imperiale, prima dai Greci ai Franchi, e poi dai Franchi ai Tedeschi?
Che i papi, da altra banda, cercassero di approfittarsi di ogni occasione
favorevole per accrescere la potestà propria, è cosa naturale, e consentanea
alla umana natura. Ma non si creda che quel crescere della potestà papale oltre
i confini che pareva le dovessero essere più legittimamente assegnati, fosse
sola conseguenza degli avvenimenti storici e di storiche congiunture, della
debolezza degli uni e dell'avidità degli altri; era pure, come ho accennato,
conseguenza logica, logico svolgimento di certi principii, di certe idee,
consustanziali alla stessa dottrina cristiana.
Che cosa è,
secondo tale dottrina, la vita terrena? Non altro che un avviamento e una
preparazione alla vita eterna. Qual è il fine dell'uomo? Raggiungere,
conformando la vita terrena alla legge di Dio, la eterna felicità; al qual
ultimo fine debbono essere coordinate le istituzioni tutte del viver civile e
politico, leggi, magistrature, principati. Chi è che ha la retta cognizione
della legge divina e l'officio di bandirla e di farla trionfare? La Chiesa, e
quando la Chiesa sarà tutta accentrata nel papa, il papa. Voi vedete subito
come si deduca l'ultima conseguenza: il papa, illuminato dalla verità,
assistito dallo Spirito Santo, dee governare il mondo e i suoi principi, come
la mente governa il corpo: ogni diritto che contrasti col suo, il quale
s'immedesima con quello dell'intero genere umano, chiamato da Cristo ad aver
parte nel regno dei cieli, è un diritto irrazionale e illegittimo. Il papa
deporrà il principe che, a suo giudizio, non aiuti i sudditi suoi al
conseguimento di quell'unico fine, e disporrà dei regni della terra, delle
insegne e degli onori reali nel modo che al conseguimento di quell'unico fine
gli parrà più conforme e dicevole. Io non dico già che in quella rivendicazione
di alta sovranità civile e politica per parte dei papi non entrassero molte
volte la cupidigia e la frode; ma dico che quella rivendicazione stessa non
sarebbe stata possibile senza il concorso di fatti e di condizioni che i papi
non avevano creati, e senza il suffragio di principii che erano tenuti
universalmente per veri. Per certo Gregorio VII e alcuni dei successori suoi
ebbero piena fede nel diritto che asserivano.
Ma i papi, non
solo esercitarono un diritto di alta sovranità sui principi temporali; furono
principi temporali essi medesimi, ed ebbero un regno, la cui storia,
intralciata e lunga, è intimamente congiunta con la storia della loro autorità
spirituale. Chi dice che il dominio temporale nocque molte volte all'ufficio
del supremo apostolato, e lo involse in interessi disonesti e biechi, non dice
se non il vero; ma erra chi crede che l'acquisto di quel dominio sia stato
necessariamente e sempre frutto di arti frodolente, di audaci menzogne e di
sfacciate usurpazioni. Arti e menzogne ed usurpazioni ci furono come in ogni
altra cosa umana; ma s'ha a dire di quell'acquisto ciò che dello sconfinamento
dell'autorità papale ricordato pur ora: esso fu cominciato, poi promosso, da
fatti storici ineluttabili e da più ineluttabili credenze e dottrine.
Le origini
prime di quello che poi fu detto Stato della Chiesa sono molto antiche. Cristo
insegnò il disprezzo dei beni di quaggiu; consigliò a chi aveva fede in lui di
distribuire ogni suo avere ai poveri e di seguirlo, e disse espresso che il suo
regno non era di questo mondo. La Chiesa primitiva non ebbe ricchezze, ma visse
di oblazioni, le quali servivano a sostentamento dei ministri, dei pellegrini,
dei poveri, e alle spese del culto. Il trionfo della fede, l'organarsi e
l'assodarsi della gerarchia, dovevano, anche per questo rispetto, mutare
profondamente la condizione delle cose. Le singole chiese arricchirono, e quelle
stesse ragioni che fecero di Roma la principal Chiesa dell'orbe cristiano,
fecero pure di Roma la Chiesa più ricca. La famosa donazione di Costantino è
una favola; ma gli è fuor di dubbio che Costantino fu assai liberale con la
Chiesa di Roma, arricchita da lui di templi, di suppellettili preziose, di
fondi rustici e urbani. L'esempio di Costantino fu imitato dai successori suoi,
e da innumerevoli privati cui era stata concessa facoltà di donare, o di
lasciare per testamento i loro beni alla Chiesa. Molte fra le più ricche
famiglie di Roma gareggiarono in quest'opera, guidate da un pensiero che non
poteva non sembrare in tutto ragionevole e giusto a coloro che avevano la fede
e l'entusiasmo della fede; giacchè chi meglio della Chiesa avrebbe potuto far
dei beni di quaggiù un uso conforme agli ammaestramenti degli Evangeli? chi
meglio di lei adoperare a buono e legittimo fine ciò che di solito è fomite e
strumento di peccato? Così è che allo sfasciarsi dell'impero d'Occidente il
patrimonio di San Pietro, com'ebbe a chiamarsi, comprende vastissime
possessioni, non solo in Italia, ma in Gallia ancora, in Dalmazia, in Africa,
in Asia. Anche le altre Chiese maggiori avevano allora patrimonii più o meno
cospicui, sebbene senza paragone minori di quello che aveva la Chiesa di Roma.
I papi
amministravano il patrimonio, riscotevano le copiosissime rendite, ma non
avevano sopra di esso diritto di sovranità, diritto che spettava, secondo le
regioni ov'erano poste le terre, o ai re franchi o all'imperatore d'Oriente. Se
non che, date le condizioni generali dei tempi; dato il progressivo e
irreparabile sfiacchimento della potestà degl'imperatori bizantini in Italia, e
il crescere della potestà dei pontefici, non era possibile che o prima o poi
questi non pensassero a sostituire all'apparente sovranità degl'imperatori la
reale sovranità propria. E una sostituzione così fatta ebbe favore dalle
popolazioni italiane, che minacciate e strette da nemici formidabili, e non
protette da sovrani di nome e per giunta lontani, non vedevano chi meglio del
papa, che avevano in casa, potesse farsi tutore degl'interessi e delle ragioni
loro. La sovranità spirituale dei pontefici attirava dunque a sè, naturalmente
ed irresistibilmente, anche questa sovranità temporale.
Il primo nucleo
di uno Stato della Chiesa, propriamente detto, procurò, e sembra strano a dire,
Liudprando, il re di quei Longobardi che tante noie diedero ai papi, e contro a
cui i papi invocarono l'aiuto vittorioso dei Franchi. Nel 728 Liudprando cesse
e donò poco tempo dopo che se n'era fatto padrone, la città di Sutri agli
apostoli Pietro a Paolo, non tenendo conto alcuno dell'imperatore a cui essa
apparteneva di diritto. Era papa allora Gregorio II, il quale, avendo il popolo
cacciato il duca, che appunto rappresentava in Roma l'imperatore, fu davvero
signore di quello che dicevasi ducato romano. Nel 741 lo stesso Liudprando fece
dono a papa Zaccaria di parecchie altre città. Maggiore accrescimento ebbe
pochi anni più tardi il nascente Stato della Chiesa per la donazione di
Pippino, e per quelle di Desiderio e di Carlo Magno; così che, nei primi anni
del secolo IX, esso comprendeva, oltre l'antico ducato romano, l'esarcato di
Ravenna quasi intero, la Pentapoli e una parte rilevante del ducato di Toscana.
Il patrimonio di San Pietro cresceva, ma non cresceva di pari passo la signoria
dei pontefici sopra di esso, presa in mezzo e premuta da altri diritti.
Gl'imperatori franchi, a cominciare da Carlo Magno, si riserbarono l'alta
sovranità, e la esercitarono, sebbene non sia possibile sempre vedere entro
quali limiti si contenesse, e come si conciliassero le due potestà
degl'imperatori e dei papi. Certo ai papi quella soggezione doveva tornare
assai poco gradita, ed essi dovevano porre ogni studio a scemarla. In ciò
ebbero aiutatori efficaci gli stessi degeneri successori di Carlo Magno: Carlo
il Calvo non esercitò più su Roma e le altre terre del patrimonio che una
parvenza di autorità.
Fu molto
disputato circa il tempo in cui cominciò ad aver corso la famosa favola della
donazione di Costantino, e le contrarie opinioni non si sono mai potute mettere
d'accordo. Chi la vuole immaginata a tempo di Carlo, chi di Pippino, e chi
prima e chi dopo. L'opinione più probabile è forse quella che la fa sorgere ai
tempi di Niccolò I, degno precursore di Gregorio VII; di quel Niccolò di cui il
cronista Reginone, suo contemporaneo, ebbe a dire che comandò ai re ed ai
tiranni, e come signore del mondo impose loro la sua volontà. Nessun mezzo si
sarebbe potuto escogitare più acconcio di quella favola a sopraffare l'ultimo
resto dell'incomoda sovranità imperiale, mentre lo scadimento stesso di quella
sovranità agevolava e favoriva la diffusione della favola e le permetteva
d'acquistar credito. Convertendosi alla fede di Cristo, e ricevendo il battesimo,
Costantino aveva ceduto in perpetuo a papa Silvestro, ed ai suoi successori,
Roma, l'Italia e tutto l'Occidente, e in conformità di tale cessione aveva
trasferita in Bisanzio la sede dell'impero. Come dunque s'arrogavano quei nuovi
imperatori un qualsiasi diritto di sovranità sopra le terre della Chiesa? Non
erano piuttosto essi, che si atteggiavano a sovrani, i feudatari dei pontefici,
e non dovevano riconoscere da questi, insieme con la corona imperiale, anche la
investitura? Liudprando, Pippino, Desiderio, Carlo Magno, non donarono nulla
alla Chiesa, ma le restituirono ciò che indebitamente e malvagiamente le era
stato tolto. Più tardi s'andò anche più in là, e fu considerata come una
restituzione la stessa donazione di Costantino.
L'apocrifo atto
acquistò grandissima autorità e fu ai papi di grandissimo giovamento. Invano,
nel 999, l'imperatore Ottone III lo dichiarava menzogna sfacciata: durante
tutto il medio evo esso fu tenuto in conto di autentico, e allegato ogni qual
volta se ne offerse opportunità. Su di esso, e su le donazioni egualmente
autentiche di Lodovico il Pio, di Ottone I e di Arrigo II, si fondava nel 1059
Niccolò II per dare in feudo a Roberto Guiscardo la Puglia, la Calabria e la
Sicilia, quest'ultima ancora da strappare ai Greci ed ai Saraceni, e per
investire del principato di Capua Riccardo conte di Aversa. Dante rimproverava
con aspre parole a Costantino la dote
funesta che aveva pervertita la Chiesa di Cristo; ma solo due secoli più tardi
l'Ariosto poteva por quella dote nel mondo della luna, ove tutto è raccolto
Ciò che si
perde, o per nostro difetto,
O per colpa di
tempo o di fortuna.
La donazione o,
se così vogliamo chiamarla, restituzione che la contessa Matilde, la gloriosa
amica e fautrice di Gregorio VII, fece de' suoi dominii alla Chiesa accrebbe di
molto ancora il patrimonio di questa. Gli è assai probabile che Matilde abbia
inteso donare i soli suoi possessi allodiali, non quelli che teneva in feudo
dall'imperatore, e di cui non poteva disporre; ma è certo da altra banda che
l'atto di lei fu cagione di nuove dispute e di nuove contese fra imperatori e
papi. Innocenzo III riuscì ad aver ragione anche in ciò, e fu signore di uno
Stato affatto indipendente, e come tale riconosciuto dallo stesso imperatore,
Stato che comprendeva, oltre il territorio che da Ceprano si distende sino a
Radicofani, il ducato di Spoleto, la marca d'Ancona, l'antico esarcato di
Ravenna sino al Po, la contea di Brettinoro, i dominii della contessa Matilde.
Abbiam veduto i
papi crescere a poco a poco; acquistar diritto di preminenza su tutti gli altri
vescovi; assicurarsi la libertà; mutarsi di vicarii di Pietro in vicarii di
Cristo; attrarre sempre più a sè la potestà diffusa nel corpo della Chiesa;
assumere quasi carattere di divinità; stendere sul mondo un'autorità
formidabile, la quale, essendo tutta spirituale in principio, si fa arbitra
d'interessi e di diritti affatto temporali, si sovrappone ad ogni autorità
laica, e la nega, o l'ammette solo come un'emanazione di sè stessa. Abbiam
veduto le ricchezze affluire nella Chiesa, e i papi amministrare vastissime
possessioni, diventare feudatari dei re, emanciparsi da ogni esterna sovranità,
cingere da ultimo la corona dei principi secolari e indipendenti. Abbiam veduto
tutto ciò aver suo principio in Roma, crescere in Roma, intorno a Roma e per
Roma. Molti fatti, molte idee, molte forze concorsero a formare il papato; ma,
se Roma non fosse stata, nemmeno il papato sarebbe stato, o come ho avvertito,
sarebbe stato un papato assai diverso da quello che fu.
Ebbene, qui
s'offre all'attenzione vostra un fatto assai strano. In Roma sempre ebbero i
papi i più acerbi nemici loro; in Roma corsero i più gravi pericoli; Roma fu il
trono e la gogna loro, il luogo della loro glorificazione e del loro martirio.
Niccolò Machiavelli ebbe a fare l'osservazione che i papi, i quali fuori di
Roma avevano grandissima e indisputata autorità, ne avevano pochissima in Roma.
Tale osservazione, verissima, era già stata fatta assai prima, in pieno medio
evo. Quello stesso Gregorio VII che si condusse a' piedi un imperatore, non fu
egli assalito in chiesa da Cencio nel bel mezzo delle funzioni del Natale,
percosso, trascinato pei capelli? E quanti papi prima di lui, e dopo di lui,
non furono in Roma, e nello stesso loro palazzo, e nelle chiese maggiori,
assaliti, oltraggiati, percossi, spogliati delle insegne del pontificato,
minacciati di morte? Quanti non si salvarono con patti vergognosi o con fughe
precipitose? Quell'Urbano II che poteva con una parola sollevare l'Europa in armi,
e precipitarla contro gl'infedeli al riscatto di Terra Santa, nulla poteva in
Roma, e fu più d'una volta ridotto a campar di elemosine. Pasquale II fu preso
a sassate durante la processione di Pasqua, e costretto a fuggirsene. Lucio II
morì d'una sassata che lo colse mentre tentava di espugnare il Campidoglio.
Persino Innocenzo III dovette cercare scampo nella fuga. E chi potrebbe
noverare tutti i papi cui Roma chiuse superbamente in sul viso le porte?
L'eterna Città
fece pagar caro ai pontefici il vanto e il beneficio che venivano loro da lei.
Era in essa un fermento inestinguibile, uno spirito prevaricatore e protervo
che veniva d'alto e di lontano, e mai non chetava. La ribellione vi ribolliva e
rimuggiva in perpetuo, e fu per secoli la forma ordinaria della sua vita. Roma
ricordava d'aver signoreggiato il mondo; Roma ricordava d'essere stata la fonte
d'ogni diritto e d'ogni sovranità, e voleva continuare ad essere, e non voleva
obbedire, e non obbediva a lungo mai a nessuna potestà, nemmeno a quelle ch'essa
stessa creava. L'impero era lei,
Roma caput mundi regit orbis
frena rotundi:
quel popolo
s'inebbriava ancora al suono terribile del suo nome e sognava sogni smisurati.
Roma voleva l'impero e voleva il papato; ma come ornamenti suoi li voleva, nè l'imperatore
nè il papa riceveva come signori assoluti. Li voleva entrambi, perchè a
costituire la suprema sovranità che credeva suo dritto, era necessario il
concorso di entrambi; ma come l'una delle due potestà minacciava di crescer
troppo e di soperchiare, essa aiutava l'altra. Però, tra l'impero e il papato
noi vediamo per secoli una Roma sempre in sommovimento, sempre in armi, vinta
spesso, non domata mai, che pugna per salvare l'autonomia propria, e si afferma
comune, e si afferma repubblica, e non dà pace nè a sè stessa, nè altrui. Da
tale sua condizione vien fuori una storia meravigliosa ed oscura, quale
nessun'altra città nel mondo ebbe o avrà mai; storia di violenze, di errori, di
tradimenti, di entusiasmi, di vittorie, di sconfitte, di peripezie d'ogni
maniera, senza fine e senza tregua. Simile a quel vortice spaventoso del mare
di cui favoleggiò l'età di mezzo, pel quale passavano a mano a mano le acque
tutte che sono sulla faccia della terra, Roma riceveva dentro di sè le forze
tumultuanti del mondo, e fra le sue mura esse venivano agli urti supremi, alle
supreme battaglie.
La storia del
comune di Roma è in parte oscura, in parte disforme da quella degli altri
comuni italiani, sorti in condizioni molto diverse dalle sue. Le vecchie
istituzioni, sebbene alterate, sebbene affralite, durarono in essere sotto i
Goti ed i Greci; ma si perdettero nel tempo della lotta contro i Longobardi,
quando popolo e papa si allearono contro il comune avversario, e insieme si
adoperarono a scuotere il giogo degl'imperatori d'Oriente. Il senato si dilegua
e sorge un comune nuovo in cui al potere civile prevale il militare. In sul
principiare del secolo VIII si menziona per la prima volta il ducato romano. Il
territorio della città si è allargato, e il popolo si sforza d'avere un duca di
sua elezione, e ci riesce. L'antico prefetto imperiale sparisce ancor esso, o
muta officio e carattere, diventa un giudice criminale. Il potere civile si
fonde col militare, e sono entrambi nelle mani del duca, che abita sul Palatino
e ha sotto di sè una popolazione spartita in quattro classi, e l'esercito, che
è formato del fiore della cittadinanza e prende parte nella elezione del papa.
Il papa non è sovrano; ma ha sotto di sè numerosi officiali, dirige una vasta
amministrazione, fruisce d'ingenti entrate, esercita il potere civile quante
volte gliene è data opportunità, e l'autorità sua di tanto cresce di quanto
l'imperiale scema.
Con la
distruzione del regno dei Longobardi le cose mutarono in parte, e in parte
rimasero come per lo innanzi. Alla sovranità nominale degl'imperatori d'Oriente
si sostituì la sovranità reale di Carlo Magno, e il papa fu, sotto di esso,
capo dello Stato, ma più di nome che di fatto. A limitare il potere suo c'era
da un lato il messo imperiale, c'era dall'altro la nobiltà, la quale formava
l'esercito, e moveva a suo grado il popolo, ed era, per dir così, l'elemento
primo ed incoercibile della repubblica. Leone III, quello stesso Leone che a
Carlo Magno, quasi in segno di sudditanza, mandava le chiavi della tomba di San
Pietro, e il gonfalone di Roma, e chiedeva un messo imperiale che venisse a
ricevere il giuramento di fedeltà dei Romani, operando come signore di Roma,
durò gran fatica a reggersi e a serbarsi illeso in mezzo al furore delle
fazioni che straziavano la città, e fu ascritto a miracolo. Gli avversarii suoi
lo assaltarono nel bel mezzo di Roma, lo rovesciarono da cavallo, tentarono,
dicesi, di strappargli la lingua e gli occhi; e v'è chi afferma che ci
riuscirono, e che per grazia di Dio riacquistò l'una e gli altri.
Era
incominciato quel terribile giuoco delle fazioni che, per secoli, doveva
insanguinar la città, riempierla di tumulto e d'orrore. Cresceva fra quelle
tragiche mura una nobiltà la più superba, la più tracotante che mai siasi
veduta, al papa tanto più infesta, quanto più fiacco ed incerto il potere
imperiale che poteva, se non domarla, frenarla. Col dissolversi dell'impero
franco, l'audacia sua giunse al colmo, adescata ed aizzata da quella stessa
istituzione del papato che avrebbe dovuto esser principio di pace e di ordine.
Non v'era famiglia di patrizii che non agognasse di vedere un de' suoi coronato
della tiara; e non v'era pontefice che non si facesse puntello e scudo delle
armi de' suoi partigiani. La repubblica, una repubblica turbolenta e malvagia
di nobili combattenti fra loro, crebbe di bel nuovo sui papi. Roma fu in balìa
di donne senza pudore e senza pietà, e i papi furono loro creature, poi del
secondo Alberico, sin verso il mezzo del secolo decimo, degni di chi li poneva
sul trono come di chi li rovesciava. La Chiesa non ricorda tempi più tristi di
questi, nè maggiori vergogne. Il papato in quella burrasca non naufragò perchè
troppe altre forze lo sorreggevano.
Intanto,
aiutato da quello Alberico, che più cose nuove ordinò, il popolo cominciava a
levarsi a fronte della nobiltà, di cui era stato insino allora strumento; ad
affermar sue ragioni; a far armi; recando nuovo fomite di dissidio, in quel
tumulto; accelerando, con sue mutazioni, le peripezie e le catastrofi;
avviluppando più sempre quella intricata matassa di cupidigie, di gelosie, di
odii, di torti e di diritti. Con Ottone I la spenta sovranità imperiale prese a
rivivere, ma insidiata, combattuta. Ai 3 di gennaio del 964 nobili e popolo
insorgono a furia, e benchè vinti rimangono poi padroni della città.
L'imperatore indi a poco si parte; Leone VIII, eletto per volere
dell'imperatore, fugge. Segue una inenarrabile storia di subiti mutamenti, di
usurpazioni, di pugne, di rappresaglie, di stragi. Roma diviene il campo dove le
due parti contrarie, la nazionale e l'imperiale, combattono una guerra
micidiale e fraudolente, non mai finita. Ciascuna elegge il suo papa, e si
sforza di tor di mezzo il papa della parte avversaria. Benedetto VI fu
strangolato in carcere; dopo otto mesi di pontificato, Giovanni XIV morì in
Castel Sant'Angelo, non si sa bene se di fame o di veleno; il cadavere di
Bonifacio VII fu crivellato di lanciate, trascinato ignudo per le vie, gettato
e abbandonato dinanzi al così detto cavallo di Costantino; Giovanni XV e
Gregorio V furono cacciati da Giovanni Crescenzio il quale signoreggiò Roma
molt'anni, finchè fu vinto e fatto decapitare da Ottone III.
Là le vittorie
imperiali abbassavano per qualche tempo la frazione contraria, non fondavano
stabilmente la pace e l'ordine. Il patriziato, in cui erano penetrati numerosi
elementi feudali, cresce, benchè diviso, d'insolenza e di forza. Roma si copre
di torri e di propugnacoli; il Colosseo, le terme, gli archi, i templi
dell'antichità diventano fortezze e ripari. Si leva sull'altre famiglie nobili
la famiglia dei conti di Tuscolo, arbitri molt'anni del papato e di Roma. E il
disordine aumenta, aumenta la corruzione: nel 1015 tre pontefici si contendono
la tiara.
Se non che in
quegli anni di perpetuo scompiglio era cresciuto di forze, e aveva acquistato
coscienza del suo diritto anche il popolo, e nel 1143 insorse e imitò l'esempio
d'altri comuni vendicatisi a libertà. Dichiarò cessato il potere temporale dei
papi e restaurata la repubblica; ricostituì il senato; ma vietò quasi del tutto
ai nobili di sedervi; riavocò a sè ogni sovranità usurpata da altrui. Due anni
dopo venne in Roma Arnaldo da Brescia, e infervorò vie più gli animi,
predicando contro la corruzione dei chierici, richiamando la Chiesa alle
istituzioni e ai costumi dei tempi apostolici e Roma all'antica sua gloria.
Arnaldo morì per questo peccato, e le sue ceneri furono gettate nel Tevere, e
quel sogno di rinnovata repubblica si dileguò con esse.
Ma riapparve
più tardi e i papi non ebbero così presto quieto e sicuro dominio sulla città
riottosa. Quel sogno era la visione di un passato incancellabile; era la
figurazione di una speranza che sempre rinasceva negli animi, li consolava e
incitava. Leone IV la significò in un verso, quando sulla porta principale della
nuova città che da lui prese il nome faceva scrivere:
Roma caput orbis, splendor,
spes, aurea Roma.
Come la stessa
città delle genti, quel sogno sembrava immortale: esso turbò i sonni a molti
pontefici; esso accese e sollevò gli animi di Cola di Rienzo e di Stefano
Porcari. Francesco Petrarca n'era irradiato quando ricordava
L'antiche mura
ch'ancor teme ed ama
E trema 'l
mondo quando si rimembra
Del tempo
andato e indietro si rivolve.
Dileguato quel
sogno, Roma quetò, e non fu più per secoli, se non un comune amministrativo.
Essa obbedì ai pontefici; ma come la potestà loro cresceva su di essa, così
scemava sul mondo; e intanto per essi e per lei maturavano nel remoto dei tempi
novelli destini.
GLI ORDINI RELIGIOSI E L'ERESIA
DI
Felice Tocco
Signore e Signori,
Di settimana
santa è bene entrare in chiesa e riandare col pensiero la storia delle più
antiche eresie, non fosse altro per sapere se resti in noi qualche vestigio
degli antichi errori. E se fastidio vi prenderà di questa corsa vertiginosa per
l'ampio giro di più che due secoli, non incolpate me, vittima innocente, ma chi
scelse insieme e il subbietto della conferenza e il conferenziere, cadendo
senza dubbio in eresia doppia e doppiamente infelice. E dico male subbietto,
chè l'argomento nostro non ne ha uno, ma due non che disparati siffattamente
opposti che molti di voi si saranno dimandati con meraviglia a quale bell'umore
sia caduto in mente di metterli insieme. Nè avete torto perchè gli ordini
religiosi furono sempre tenuti per il più saldo presidio di quella stessa
Chiesa, che l'eresia tendeva da più parti di sovvertire, anzi alcuni di questi
ordini sursero appunto per combattere corpo a corpo e perseguitare a morte gli
eretici. Nè fa d'uopo citare i frati predicatori o domenicani, che in grazia di
un bisticcio etimologico non disdegnavano di chiamarsi cani del Signore, domini canes, e quali bracchi, fiutanti
da lontano l'eresia, sono infatti effigiati in uno dei grandi affreschi del
Cappellone degli Spagnuoli.
Ma non ostante
questi contrasti, che certo a nessuno verrà in mente di revocare in dubbio,
altri potrebbe scoprire qualche non lontana analogia tra il movimento ereticale
e la riforma degli ordini monastici, principalmente in quel torno di tempo, di
che io debbo intrattenervi, vale a dire nel corso dei secoli decimosecondo e
decimoterzo. In primo luogo gli ordini monastici non dissimulavano la loro
posizione al clero secolare, il quale nella confusione ognor crescente del
principato civile con la dignità ecclesiastica, sempreppiù si allontanava dai
precetti del Vangelo; e non solo il papa aveva un dominio temporale, ma molti
vescovi, specie in Germania, erano anche principi dell'impero; e non di rado
quella mano che doveva levarsi a benedire collo stesso segno di croce amici ed
inimici, brandiva la spada contro gli stessi fedeli. Di siffatto tralignamento
mondano e del fasto e della corruzione del clero si facevano denunziatori e
giudici principalmente i fondatori di nuovi ordini religiosi che predicavano
doversi le anime schive e disdegnose ritrarre nel silenzio dei chiostri, per
praticare quelle virtù evangeliche, che nel fragore delle armi e nel lusso di
una vita mondana e vescovi e prelati avevano smarrite. L'ostilità tra il clero
secolare e i nuovi ordini religiosi, principalmente al sorgere dei frati
mendicanti, crebbe a tal segno che un eminente professore dell'Università
parigina, Guglielmo di Sant'Amore, pubblicò contro di loro un'amara invettiva,
intitolata: «Dei pericoli dei tempi novissimi», dove rimbeccando i novatori,
sosteneva il vero flagello della Chiesa essere appunto quei sodalizi frateschi,
che scemando il prestigio delle antiche istituzioni, tornavano come minaccia ed
offesa permanente alle più alte autorità ecclesiastiche. Il papa Alessandro IV
impose silenzio all'audace polemista, e solennemente condannò il libro
pericoloso, ma la lotta non ismise per questo, e più tardi fu rinnovata con ben
altro successo.
Ma oltre a
questo carattere polemico, un altro tratto è da rilevare nelle riforme degli
ordini religiosi, che con rapida vicenda si succedevano tra il secolo
decimosecondo e il decimoterzo; ed è il rigoroso ascetismo. L'ordine principale
della Cristianità, fondato nel secolo VI da San Benedetto, non avea portato
quei frutti che il pio fondatore ne sperava. Certo a nessuno può cadere in
mente di negare i meriti dell'ordine benedettino, che in tempi di buia
ignoranza seppe conservare la tradizione della coltura, e glorificò il lavoro
manuale quando da tutti era tenuto a vile, e più volte difese i vinti dalle
prepotenze dei barbari vincitori; ma non si può d'altra parte contrastare che
avendo quell'ordine accumulate enormi ricchezze, deviò siffattamente dalla
semplicità ed operosità primitiva che non mancavano nell'ordine stesso voci di
severe rampogne, e molti tentativi di riforma si alternarono a brevi
intervalli.
Tralascio le
riforme di San Romualdo che nel 1012 fondò l'ordine dei Camaldolesi, e quella
di San Brunone che nel 1085 fondò l'ordine dei Certosini, perchè l'uno e
l'altro, pur conservando la regola di San Benedetto, fecero ritorno alla
disciplina più austera degli antichi eremiti della Tebaide. Ma anche quelli che
più strettamente si tennero all'istituzione benedettina, come Guglielmo di
Aquitania che fondò la celebre abbazia di Clugny nel 909, e più tardi San
Bernardo che nel 1115 aperse quella ancor più celebre di Chiaravalle,
intendevan tutti di richiamare i loro confratelli ad una più rigida osservanza
della Regola.
Nè diverso fu
il pensiero del calabrese abate Gioacchino, che ancor più severa riforma aveva
inaugurata nelle alpestri solitudini di San Giovanni in Fiore, e maggiori e più
copiosi frutti se ne imprometteva, perchè nell'ardente fantasia vedeva prossima
una terza età del mondo, in cui non solo l'ordine benedettino, ma la
cristianità tutta andrebbe radicalmente riformata.
Di queste
teorie gioachinitiche discorreremo a suo tempo. Per ora tornando al nostro
proposito, dico che i due caratteri del movimento riformatore dei cenobii,
l'opposizione contro il clero non pure secolare ma regolare e il rigido
ascetismo, sono altresì le molle più potenti dell'eresia medioevale. Perchè non
s'ha da credere che l'eresia medioevale nella maggior parte delle sue forme si
opponga alla Chiesa stabilita per vendicare, poniamo, o la libertà della
coscienza o l'autonomia dello Stato, o per ridare alla natura ed alla vita quei
diritti, che l'ascetismo le aveva tolti. Tutto al contrario l'eresia medioevale
è più ascetica dello stesso Cattolicismo. E per questo lo combatte e l'assale
da più parti, perchè non lo crede abbastanza agguerrito contro i tre nemici
dell'anima, il mondo, il demonio e la carne. Questa comunanza d'intendimenti
tra i riformatori e gli eretici, per quanto parziale e momentanea, rende
ragione del fatto stranissimo che alcune eresie prendano le mosse da movimenti
al principio non ereticali, anzi protetti e incoraggiati dalla Chiesa. Così i
Patarini, che negli editti di Federico II sono accomunati colla peggior genìa
di eretici, nel secolo XI non erano altro se non il clero minore milanese, che
sotto l'inspirazione dei papi insorgeva contro gli abusi e le rilassatezze del
clero maggiore. Anche oggi si chiama a Milano dai Patari una contrada, dove
abbondano i patari, o rivenduglioli di roba usata. L'italiano rigattiere non esprime tutto il disprezzo
che si collega col patari o patee. E appunto patari o patarini
furono denominati i membri del basso clero che ardivano di muover guerra
all'alto, nome che sulla bocca degli uni poteva suonare scherno o dileggio, ma
sulla bocca degli altri era titolo di gloria o per lo meno di cristiana umiltà.
Certo è che il basso clero accusava l'alto di due vizii capitali: il
concubinato e la simonia. Intorno alla prima di queste due accuse bisogna però
bene intendersi, perchè non è da credere che tutto l'alto clero milanese
conducesse vita dissoluta. Per lo contrario molti sacerdoti credevano di aver
menato moglie legittimamente, e di non essere divenuti per questo peggiori
degli altri. Perchè il celibato dei preti non è un articolo di fede, ma una
misura disciplinare, dalla quale la Chiesa stessa talvolta si allontana, come
anche oggi rispetto ai sacerdoti di rito greco. E a qualunque tempo, più meno
antico, questa misura rimonti, certo è che la Chiesa milanese per lunga
consuetudine se n'era dipartita, e si contava in Lombardia sì gran numero di
preti ammogliati, che lo stesso Leone IX riconosceva non esser lecito mettere
sul lastrico tante povere donne, non di altro colpevoli se non di aver seguito
un uso inveterato del loro paese. Ed anche sull'altro capo d'accusa bisognava
osservare, che la simonia (così chiamata da quel Simone Mago, che voleva
comprare a contanti la dignità apostolica) era un male non della Chiesa
milanese soltanto ma di tutta la Cristianità. I beneficii ecclesiastici davano
così larghi profitti, che quanti avevano il diritto di conferirli, volendo
prendervi qualche parte, li solevano dare al migliore offerente; nè dopo secoli
di lotta si riuscì a sradicare il male. Ma se la Chiesa milanese poteva addurre
in suo favore vecchie consuetudini ed esempi di tutti i paesi, non aveano torto
i papi a imporre al clero quello che credevano più utile nell'interesse della
cristianità. E potevan ben pretendere che la milizia di Cristo non da altre
cure fosse distratta, nè altre famiglie riconoscesse fuor del consorzio dei
fedeli a lei affidato, e che i beneficii ecclesiastici fossero dati al più
degno non al migliore offerente. Al che aggiungete la Chiesa romana mal
soffrire che l'arcivescovo di Milano, divenuto come a dire principe della
città, aspirasse ad un'autonomia non conciliabile con la rigida gerarchia del
cattolicesimo, e non vi parrà strano che sia scoppiata terribile la lotta tra
il clero minore, obbediente ai cenni di Roma, e il clero maggiore forte delle
sue clientele e degli antichi diritti.
Molte vittime
caddero dalle due parti e tra gli altri i capi stessi dei patarini Arialdo ed
Erlembardo, che ben presto furono levati sugli altari. Ma cessato il moto
patarinico, e fiaccata la potenza degli arcivescovi milanesi, non cessarono per
questo gli scandali, e almeno per la simonia le cose continuarono come prima,
che per isvellere il male dalla radice bisognava togliere al clero i lauti
beneficii, e la potestà secolare con quelli congiunta, a cominciare dalle somme
cime sino agli ultimi gradini della gerarchia. Quest'audace riforma fu
proclamata altamente da Arnaldo da Brescia e dagli Arnaldisti, i veri
continuatori del movimento patarinico. Ma ormai le sorti erano mutate, i nuovi
Patarini non obbedivano ai cenni di Roma come gli antichi, e furon dichiarati eretici,
e il loro capo, non che levato sugli altari, fu gettato nel Tevere. Nè io
negherò che in qualche punto dommatico gli Arnaldisti non si allontanassero
dalla fede, come nel sostenere che la dignità sacerdotale immediatamente si
perda quando chi l'eserciti ne sia indegno, e che i sacramenti somministrati da
un prete concubinario o simoniaco non abbiano valore; ma anche su questo punto
i Patarini antichi non pensavano diversamente dai nuovi, e certo è che gli uni
e gli altri volevano informata la vita del clero a più rigoroso ascetismo.
Quello che i
Patarini chiedevano al clero, altri eretici, o i cosìdetti Catari, lo volevano
esteso a tutti i fedeli. Ben per tempo il nome di Patarini si scambiò con
quello di Catari o Catarini come si diceva presso di noi. Ma originariamente ed
etimologicamente i due nomi erano e sono distinti. I Catari sono una setta
venutaci dalla Bulgaria (e però furono detti anche bulgari o bougres), di cui si sentì per la prima
volta parlare nell'alta Italia quando non erano ancora cominciate le agitazioni
patariniche, e si dicevano Catari dal greco
καθαρὸς (puro) che da noi divenne catàro o anche cazàro e in Germania si trasformò in Ketzer, usato d'allora in poi a significare eretico per antonomasia. I Catari si chiamavano così in quanto si
vantavano di non esser lordi delle colpe che osavan rimproverare alla Chiesa
cattolica. Ammettevano anch'essi essere tre i nemici dell'uomo, il mondo, la
carne e il demonio, ma i due primi credevano fossero creati dall'ultimo.
Imperocchè seguendo l'antica dottrina manichea, ponevano due spiriti eterni e
lottanti fra di loro, lo spirito del bene, o Dio buono, e lo spirito del male,
o Demonio. Ciascuno dei due Dii avrebbe creato a modo suo, il Dio buono le
anime nella loro purità nativa a lui rassomiglianti, il Dio malvagio invece i
corpi e tutte le cose visibili. Insegnavano inoltre, seguendo le antiche
tradizioni pitagoriche, che un bel giorno le creature del buon Dio deviarono
dal dritto sentiero e precipitando dal cielo vestirono la carne, dando così
principio a quell'iliade di mali che non avrà mai fine, finchè non sarà dato
loro di ritornare al Cielo onde partirono. E concludevano: l'unico mezzo di
conseguire sì eccelso fine essere questo, sequestrarsi dal mondo, opera del
malvagio Dio, e mortificare la carne fonte di ogni corruzione. Nè soltanto ai
preti ma benanco a tutti i fedeli interdicevano il matrimonio, perchè mettere
al mondo nuovi figliuoli è come costringere le anime a rientrare un'altra volta
nella prigione della carne. Se tale strana religione avesse potuto attecchire,
la conseguenza sarebbe stata questa, che il primo giorno del suo trionfo
sarebbe stato l'ultimo della umanità, perchè la generazione, che accettando in
buona fede il catarismo, ne avesse seguite scrupolosamente le massime, non
avrebbe avuto discendenti, e si sarebbe verificato così quel suicidio cosmico,
che qualche filosofo contemporaneo ha osato di spacciare come una grande
novità. Pur troppo in fatto di stranezze e di pazzie si può dire con
l'Ecclesiaste: nulla di nuovo sotto il
sole.
Il Catarismo è
certamente agli antipodi del Cristianesimo, perchè l'uno è rigorosamente
dualista, l'altro monoteista; l'uno proscrive il matrimonio, l'altro lo
proclama un sacramento: l'uno infine crede di compiere ed inverare l'Ebraismo,
l'altro condanna il vecchio Testamento, e crede il Dio terribile e vendicativo
degli Ebrei non essere se non il Dio malvagio degli antichi Parsi. Ed è molto
strano come in pieno Medio Evo, quando la fede era più viva, e la Chiesa aveva
riportato o stava per riportare, le più splendide vittorie sugli avversarii
suoi, è strano, ripeto, come una credenza così anticristiana, e che per giunta
fa violenza alla natura umana, abbia potuto trovare tanti proseliti. Eppure è
così. Il Catarismo si diffuse in tutta l'Europa, e l'Italia nostra, tenuta da
noi stessi per il paese meno adatto alle innovazioni religiose, ne era per così
dire il centro. Tutte le classi partecipavano alla nuova fede, e le donne non
meno degli uomini. Di qui, da Firenze, partì una donna coraggiosa ed intrepida
alla volta di Orvieto, ove una calda parola trasse molti alla nuova fede. E
cosa più strana ancora, un altro paese che rivaleggiava coll'Italia per il
favore dato al Catarismo, fu appunto quella Provenza, dove fioriva il culto
della nuova lingua e della nuova poesia, e dove tutti i trovatori cantavano e
sfinivano di amore anche quando non ne sentivan punto. In mezzo a tanto sorriso
di cielo e a cosiffatta gaiezza di vita pur trovò modo di prosperare la più
tetra ed ascetica delle religioni, la quale si diffuse così largamente nelle
diocesi di Tolosa, di Carcassona e di Albi, che il nome stesso di albigese
divenne a così dire sinonimo di cataro. E fu duopo di lunga e sanguinosa
crociata, e di una inquisizione ancor più terribile della guerra stessa, per
ispiantare l'eresia da quel paese dove aveva messe sì profonde radici. Le
ragioni di questo fatto meraviglioso sono molte, ma non temiate che io abusi
della pazienza vostra per isvolgerle tutte. La principale è questa, che i
Catari non ostante le opposizioni si credevano cristiani, più cristiani ancora,
dei cattolici. E sapevano a mente il nuovo Testamento, e lo traducevano in
volgare perchè tutti l'intendessero. Ed ogni loro opinione avvaloravano con
citazioni bibliche per ridurre al silenzio gli avversari loro. Essi credevano
anzi di interpretare nel vero spirito i precetti evangelici. Così nell'Evangelo
è detto essere più agevole che un
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio,
ed essi esagerando e frantendendo aggiungevano: nessuna eccezione potersi dare,
e poniamo anche che il ricco adoperi buona parte delle sue sostanze a benefizio
degli altri, non tornerà per questo nel grembo di Dio buono, perchè la povertà
assoluta è di rigore, e possedere e amare le ricchezze torna lo stesso come
attribuire un pregio alle cose di questo mondo, che quale opera del malvagio
Dio non ne hanno alcuno. E se nell'Evangelo è scritto: voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, ma io vi dico
che chiunque s'adira contro a suo fratello senza ragione, sarà sottoposto a
giudizio, essi aggiungevano: non potersi uccidere in nessun modo, nè in
guerra, nè in nome della legge, e la Chiesa che bandisce crociate e condanna al
rogo i suoi nemici, non seguire i precetti di Cristo, che dice: Amate i vostri nemici, benedite coloro che
vi benedicono, fate bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi
fanno torto e vi perseguitano. Inoltre questi astuti eretici non tutte le
loro dottrine svelavano a tutti, ma solo quelle che più facilmente
s'accoglievano, e che servivano a staccarli dalla Chiesa, il resto poi veniva
da sè. Nè a tutti i seguaci della lor fede chiedevano gli stessi sacrifizii, ma
sapevano ben distinguere tra perfetti e credenti, i quali ultimi potevano ben
dirsi Catari senza rinunziare alla loro famiglia o alla loro proprietà. Con
tali espedienti la fede catara appariva meno ostica, e guadagnava ogni giorno
seguaci, massime per le virtù eroiche e gli atti di coraggio degli intrepidi perfetti, che perseguitati da tutte le
parti non cedevano, e piuttosto che smentire la loro fede, salivano
animosamente il rogo. Una condotta austera, una vita di stenti e di abnegazioni
continue è il miglior mezzo per guadagnare le anime. Si racconta il caso di una
fanciulla caduta in sospetto d'eresia, a cui fu ingiunto di assistere al
supplizio dei correligionari suoi. Quando il capo di essi, Arnaldo di nome,
entrando nelle fiamme, aperse le braccia per benedire i suoi fratelli, la
fanciulla svincolatasi dagli sgherri che le stavano ai fianchi, si lanciò nel
rogo, sagrificando alla nuova fede la sua bella e fiorente giovinezza.
Non meno
disposti a dare la vita alla fede loro si mostravano altri eretici, che hanno
ben poco di comune coi Catari, i Valdesi, così chiamati da Pietro Valdo, un
mercante di Lione che seguendo il precetto di Cristo, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e donalo ai poveri, distribuì
le male accumulate ricchezze tra i suoi concittadini, e vestito un povero saio
andò accattando di porta in porta, e predicando dappertutto la parola del
Signore. Questo movimento al principio non era anticattolico, tanto che ad uno
dei seguaci di Pietro Valdo, a Durando di Huesca, fu agevole di staccarsi dal
novatore e farsi riconoscere e benedire da papa Innocenzo III come capo di un
nuovo sodalizio cattolico. Nè alcuna parte del domma o della liturgia cattolica
il Valdo voleva attaccare, ma solo tornare la Chiesa alla sua purità primitiva.
Senonchè per questo capo i Valdesi non usavan diverso linguaggio dei Catari e
Arnaldisti. Da quel giorno, essi dicevano, che Silvestro ebbe l'infausta
donazione di Costantino (spuria donazione a cui allora tutti prestavan fede),
da quel giorno l'avidità di ricchezze non fu mai satolla, nè mai si estinse la
sete di dominio, e la Chiesa vestita di porpora, e incoronata di gemme prese le
sembianze della gran peccatrice dell'Apocalisse (17.1). Queste roventi parole
uscivano talvolta anche da labbra ortodosse, e i Ghibellini tutti solevano
adoperarle da Pier delle Vigne al nostro Dante di cui è nota la terzina:
Ahi Costantin
di quanto mal fu matre
e l'altra ancor
più vibrata:
Di voi, Pastor,
s'accorse il Vangelista.
Ma i
Ghibellini, più che una setta ereticale, formavano un partito politico, perchè
il non credere alla necessità del potere temporale, non era allora e non è oggi
un'eresia, e perfino nelle lotte più ardenti tra la Chiesa e l'Impero i Papi
non osarono mai di sollevare all'altezza di un domma religioso una questione
sostanzialmente politica.
I Valdesi però
eran più radicali dei Ghibellini, e benchè si dicessero e credessero nel cuor
loro sinceri cattolici, pure interpretavano la parola evangelica in senso molto
più rigido ed unilaterale che non fosse consentito dalla tradizione cattolica,
e si attribuivano il diritto di predicarla senza averne ricevuto alcun mandato
dalle autorità ecclesiastiche. Ben per tempo quindi furono ripresi dal vescovo
di Lione e dal papa Alessandro III, e più tardi Lucio III li scomunicò, nè
Innocenzo III revocò il decreto del suo predecessore. Espulsi così dalla
Chiesa, i Valdesi non potevano continuare se non a patto di scegliere nel
proprio seno chi facesse le veci dei sacerdoti cattolici. E così semprepiù
allontanandosi dall'ortodossia, proclamavano aver la facoltà di spezzare il
pane eucaristico chiunque di loro sia di cuor puro, e in luogo della
confessione auricolare valer meglio una confessione in pubblico a tutta la
comunità dei fedeli; non essere necessario un luogo speciale per rivolgere la
sua preghiera al Cielo; e infine anticipando la riforma, negavano potersi il
sacrifizio eucaristico applicare ai defunti, e toglievano di mezzo il
purgatorio. Per tal guisa l'eresia valdese tornava non meno pericolosa della
catara, e si diffondeva da per tutto con maggiore facilità.
Contro tutte
queste eresie, la catara, l'arnaldistica, la valdese, non valevano più nè le
vecchie armi delle scomuniche e degli interdetti, nè le nuove ancor più
terribili della tortura, del rogo. Più si perseguitavano gli eretici, e più si
ringagliardiva la loro fede, e molti andavano incontro alla morte lieti e
cantando degli inni, come nei primi tempi delle persecuzioni cristiane. Per
vincere o almeno svigorire la propaganda di questi intrepidi e convinti
novatori, bisognava opporle un'altra propaganda non meno operosa ed efficace.
Non era più il caso di chiudersi nel silenzio degli eremi o nella quiete dei
conventi. Per combattere le dottrine degli eretici bisognava imitarne le
pratiche e le virtù ed accettare la povertà evangelica da loro inculcata, e
ramingare come loro, accattando dovunque la vita e dovunque predicando la
parola del Vangelo. Così nacquero gli ordini mendicanti. Il primo a bandire
come suprema regola la povertà assoluta fu San Francesco di Assisi, il
fondatore di un nuovo sodalizio di frati, che per umiltà si dissero minori, ma
ben presto per i servigi resi alla Chiesa apparvero maggiori fra tutti. E certo
il prestigio di questi nuovi apostoli della povertà fu tale, che anche altri
ordini religiosi ebbero ad adottarne le massime. E si dichiararono mendicanti i
seguaci di San Domenico o frati predicatori, che da principio avevano
abbracciata la regola agostiniana; mendicanti i diversi ordini, che da
Alessandro IV furono riuniti in un solo sotto il nome di Eremiti di
Sant'Agostino; mendicanti infine i Carmelitani, il cui ordine fondato nel 1156
dal crociato Bertoldo, nel 1245 trasformò i suoi romitaggi in cenobii. Nella
vita povera ed umile parve in quei giorni consistere la perfezione evangelica,
e si faceva a gara a chi potesse condurla con maggior rigore.
Ma non diversamente
da tutti gli altri ideali anche quello della povertà assoluta doveva rompere
contro non pochi ostacoli. E l'ordine religioso, che più tenacemente degli
altri gli restò fido, ebbe a patire i più crudeli disinganni, e ne andò
travolto in dissensi e lotte funeste, le quali composte per poco
dall'autorevole voce di San Francesco, non tardarono a divampare alla di lui
morte, e più ancora al tempo del generalato di frate Elia. Questi, già stato
vicario di San Francesco nel governo dell'ordine, volle erigere in onore di lui
un tempio che per mole e splendore vincesse tutti. E radunate le offerte, che
piovevano in gran copia da ogni parte della Cristianità, dette così vigoroso
impulso ai lavori, che in breve tempo sorse quella mole grandiosa, detta a ragione
il tempio dell'arte rinata. Ivi infatti l'architettura seppe trarre dallo stile
gotico nuovi e meravigliosi effetti; ivi Cimabue dipinse quegli affreschi, che
segnarono il principio della riscossa contro le tradizioni bizantine e gli
detter fama di tener lo campo nella
pittura; ivi Giotto tentò più arditi voli, sì che la fama di colui oscura. Ma le meraviglie dell'arte nuova
non sedussero gli entusiasti della povertà, che se avessero potuto avrebbero
colle loro stesse mani distrutto quell'insigne monumento, dove tante ricchezze
di marmi o d'oro eran profuse. E fieramente rimproveravano a frate Elia di
essersi allontanato dalla regola di San Francesco, che vieta rigorosamente il
lusso così nella cella dei frati come nella casa del Signore; e di avere accettato
lasciti e doni, vietati ai seguaci del santo mendico, e allentati i freni della
disciplina, permettendo ai frati di non vestire il saio di tela di sacco,
sdruscito e rattoppato, e di aver gettato via il bastone del pedestre
pellegrino, per cavalcare su ben pasciute e ben bardate giumente. Così si
formarono nel sodalizio francescano due partiti, l'uno degl'intransigenti,
l'altro dei moderati; l'uno che volea rispettata la regola nella sua rigidità,
l'altro che permetteva temperamenti secondo i bisogni e le convenienze
dell'ordine. La lotta fra i due partiti fu lungamente e fieramente combattuta.
Il moderato rimproverava all'intransigente di mirare alla rovina dell'ordine,
il quale se avesse acconsentito a seguitare la vita oscura dei primi tempi,
sarebbe stato ben presto sopraffatto dagli ordini rivali, non guardanti così
per la sottile. E il partito intransigente di rimando ritorceva il rimprovero
contro i suoi avversarii, accusandoli di togliere all'ordine il suo carattere
proprio, e quell'aureola di santità, di povertà e di umiltà, principale cagione
delle sue fortune. I moderati che alla salute dell'ordine del convento
principalmente intendevano, presero il nome di Conventuali, gl'intransigenti, quando le dottrine dell'abate
Gioacchino furon da loro conosciute ed adottate, presero altro nome. Perchè
secondo le divinazioni a cui accennammo del profeta calabrese il mondo deve
passare per tre età, la prima fu il regno del Padre, la seconda è quella del
Figlio, la terza sarà dello Spirito Santo. Nella prima dominava l'antica legge,
legge del terrore e dell'odio tra i popoli di cui un solo era l'eletto e gli
altri consacrati all'ira di Jeova; nella seconda domina la nuova legge di
carità e di fratellanza, ma più a parole che a fatti; nella terza infine la nuova
legge riporterà il suo pieno trionfo e sarà intesa non secondo la lettera ma
nel vero suo spirito. Gli uomini, che pur vivendo nella seconda età anticipano
nei loro costumi e coi loro voti la futura, debbono a ragione dirsi spirituali. E spirituali si chiamarono
gl'intransigenti francescani.
Non occorre
dire che questi intransigenti si misero con molto amore a studiare e commentare
le opere principali di Gioacchino. E uno di loro, fra Gherardo di San Donnino,
non senza la collaborazione di un generale stesso dell'ordine, fra Giovanni da
Parma, le ripubblicò a nuovo con introduzione e commenti addimandandole con
nome non ignoto a Gioacchino, l'Evangelo
eterno, vale a dire l'Evangelo inteso nel suo vero spirito, e che non
perirà come quello letterale dell'età seconda. Questi nuovi intransigenti, che
mescolavano le dottrine della povertà assoluta con le mistiche dell'abate
Gioacchino, miravano come si vede ben più alto degli antichi. Perchè Gioacchino
avea profetato essere per cessare nella terza età tutte le distinzioni tra
clero e laicato, e tutti i figli d'Adamo dover comporre una società sola
informata alla più austera castità e alla povertà più rigorosa. Dalle quali
profezie gl'intransigenti minoriti non tardarono a inferire che fra non molto
la regola loro, distendendosi ed imperando su tutti, avrebbe trasformato la
cristianità intera in un vasto cenobio francescano. Fortuna per noi che il
profeta calabrese e i suoi seguaci non ebbero la vista lunga, e che il loro
sogno non s'avverasse nè nel 1260, l'anno fatale indicato da Gioacchino, nè per
i secoli che gli successero; e non è probabile per fermo che sia mai per
avverarsi.
Ammesse queste
idee apocalittiche, non parrà strano che dal labbro dei minoriti uscissero
contro il clero le stesse rampogne che correvano di bocca in bocca fra gli
eretici del tempo. E la Chiesa se ne insospettì, nè solo condannò l'Evangelo
eterno, ma fece rinchiudere il suo autore in una perpetua prigione, e il
generale frate Giovanni, deposto dal suo ufficio, fece relegare come in esilio
in un lontano ed ignorato monastero. Ma non per questo furono soppresse le idee
spiritualistiche, le quali ebbero nuovi e arditi difensori in frate Pier di
Giovanni Olivi per la Provenza, e per l'Italia in frate Ubertino da Casale,
quello stesso ricordato da Dante, là ove dice il vero religioso francescano non
essere
... nè da Casal
nè d'Acquasparta
Là onde vengono
tali alla scrittura
Che l'uno la
fugge, l'altro la coarta.
Dante
librandosi sui due partiti opposti, lo spirituale rappresentato da Ubertino, e
il moderato dal generale Matteo d'Acquasparta (più tardi cardinale e legato del
papa a Firenze) li condanna entrambi. E giustamente mette le surriferite parole
in bocca a Bonaventura, perchè questo santo francescano, successo nel
generalato a fra Giovanni da Parma, fu capo d'un terzo partito, che accettava
in parte le dottrine sulla povertà assoluta, ma respingeva affatto le idee
Gioacchinitiche e le conseguenze che ne derivavano. A questo partito si
accostarono in Italia alcuni degl'intransigenti medesimi, i quali, sebbene
anch'eglino avessero fede nelle profezie di Gioacchino, le mettevano in seconda
linea, e quello su cui fortemente insistevano era soltanto la stretta
osservanza della regola. E non che pretendere che tutto il mondo abbracciasse l'assoluta
povertà, confessavano invece che una gran parte dei minoriti stessi non si
sarebbe mai piegata ad adottarle. Domandavan quindi d'essere riconosciuti come
una corporazione a parte, e sottratti al dominio dei conventuali. Così la
pensavano alcuni frati di Toscana capitanati da frate Enrico di Ceva, ed altri
di Romagna guidati da fra Liberato e frate Clareno. E par che tutti fossero
conosciuti sotto il nome di fraticelli, in quanto per umiltà e nello spirito
della regola francescana si credevano ancor minori
dei minori, e portavano degli abiti
corti o di rozzo panno, e vivevano una vita austera di stenti e di sacrifizii.
In seguito alla
quale scissura l'ordine francescano andò diviso non più in due ma in tre parti:
i moderati o Conventuali, i seguaci dell'Olivi o Spirituali, e i seguaci di
frate Enrico e di fra Liberato o fraticelli. Il destino di questi partiti fu
diverso. Quando dopo alternative di trionfo e di disfatte gl'intransigenti
furono percossi fieramente da papa Giovanni XXII, che ordinò di sottoporli
all'Inquisizione e di punire i ricalcitranti col rogo, la maggior parte dei
frati si disdisse. Non in tutti era la stoffa eroica dei quattro di Marsiglia,
arsi vivi nel 1317 per non aver voluto sconfessare le loro dottrine, e a poco a
poco le credenze spiritualistiche cessarono nel primo ordine francescano, ma si
conservarono intere nel terzo, i cui membri vivendo nel seno delle proprie
famiglie erano meno esposti ai sospetti ed alle minacce.
I terziari in
Francia si chiamavano anche beghini e in Italia bizochi o pinzocheri, e
d'allora in poi gli spirituali si tramutarono in beghini, nè altro nome di lì
innanzi fu loro dato, nè altro si trova nei processi inquisitori che furono
aperti contro di loro. È strana la storia delle parole beghino, pinzochero e
bigotto, e vale la pena per il proposito nostro di toccarla almeno di volo. Al
principio si dicevano beghine le donne raccolte nei ricoveri fondati al tempo
delle Crociate da Ugo Le Bégue. Non prestavano voti solenni, e ciascuna abitava
la propria casetta di una o due camere, nè si riunivano se non in determinate
ore per le preci da recitare in comune. Anche oggi esistono simili case nel
Belgio, disposte in bell'ordine intorno a un oratorio centrale, e si dicono
anche oggi beguinages. Nel secolo
XIII dopo la creazione degli ordini mendicanti, quando si pensò a restringere
il numero delle corporazioni religiose cresciuto a dismisura, le beghine e i
beghini surti sul loro esempio si ascrissero all'ordine terziario o di San
Francesco o di San Domenico. E poichè il numero degli ascritti al francescano
era maggiore, beghino divenne presso a poco sinonimo di terziario francescano,
come in Italia e in Toscana le parole di oscurissima etimologia bizochi e
pinzocheri. Più tardi si diffusero presso i beghini e i bizochi le idee poco
ortodosse degli spirituali minoriti nel mezzogiorno della Francia e in Italia,
e degli Almariciani o fratelli del libero spirito nel Belgio e nella vicina
Germania, e allora beghina e bizoco o pinzochero divenne presso a poco sinonimo
di eretico, come appare dalle bolle di scomunica di Bonifacio VIII, di Clemente
V e di Giovanni XXII. E la stessa sorte toccò al nome begutten, o begotten trasformazione
tedesca dello stesso vocabolo beghine. Oggi bigotta, beghina e pinzochera non
vuol dire più la terziaria o francescana o domenicana che sia, nè l'eretica
spirituale o begarda, ma invece si adopera per indicare la donnicciuola più
superstiziosa che religiosa, che vive più in chiesa che in casa, e snocciolando
rosarii non è mai stanca di biascicar preci senza intenderle.
Più fortunosa
ancora è la storia della parola fraticello. Al principio, come vedemmo,
s'applicava per antonomasia a quella parte dei Francescani, che volean vivere
conforme alla più rigida regola, ed erano tenuti in tale voce di santità, che
due di loro, frati Liberato e il Clareno furono beatificati dalla Chiesa, e le
loro idee sulla necessità della separazione delle due parti rivali dopo molte
persecuzioni trionfarono alla fine nel 1368 per opera di Paolo dei Trinci, il
vero fondatore dei frati dell'osservanza. In seguito fraticelli furono detti
quegli eretici che al paro dei beghini credevano: il papa non potere nè
dichiarare nè attenuar la regola, perchè, dicevano, la regola è intangibile
come il Vangelo di Cristo, e fu rivelata a San Francesco dallo stesso Spirito
Santo. Infine, quando Giovanni XXII per tagliare il male dalla radice, con
bolla del 1323 dichiarò solennemente non essere la povertà nè la sola nè la
vera virtù evangelica, furon detti fraticelli coloro che resistendo al papa
sostenevano non essere a lui lecito di revocare le sentenze dei suoi
predecessori, e cadere in iscomunica e non dovergli obbedire in nessun modo
quando tanto osi. Questi fraticelli, non ostante le più attive persecuzioni, di
cui avanza un noto ricordo nella descrizione del supplizio di fra Michele da
Calci, perdurarono per molto tempo, ed a Firenze principalmente attecchirono
così tenacemente che il Comune fu obbligato d'inserire nei suoi statuti uno
speciale capitolo contro di loro. Tutto questo movimento vi mostra di nuovo a
chiare note come sia breve il passo dal più rigido ascetismo all'eresia.
E la stessa
conclusione s'ha da trarre ove s'attenda ad un'altra eresia medioevale, quella
degli apostolici fondati da Gherardo
Segalelli e continuata da fra Dolcino da Novara. Questi eretici pensavano la
vita degli ordini mendicanti non essere conforme a quella degli apostoli, che
non si riunivano in cenobi, nè formavano una vera comunità, ma ciascuno di essi
senza pane e senza tetto andava per la sua via di città in città predicando
l'Evangelo. Nè vestivano di nero ma di bianco, nè si radevano la barba ma la
portavano lunga ed incolta, e nei loro pellegrinaggi non impedivano che le
donne si accompagnassero con loro, anzi parecchi di essi menavan seco le mogli
e i figliuoli. Per queste ragioni il Segalelli, e più ancora fra Dolcino, pur
accettando le idee Gioacchinitiche, sostenevano non essersi inaugurata cogli
ordini mendicanti un'êra nuova della storia, ma in essi invece dover finire
l'antica, alla cui corruzione tutti, i minoriti non meno degli altri,
prendevano larga parte. E non dubitavano di profetare che fra non molto
s'inaugurerà una quarta età del mondo col trionfo dei nuovi apostoli, che il
nemico dei papi, Federico d'Aragona, salendo sul soglio imperiale, dovea porre
a capo di tutti i Cristiani. A differenza degli altri eretici contemporanei gli
Apostolici sembra non inculcassero nè tenessero in gran pregio il celibato. E
il loro stesso capo fra Dolcino, convertita in Trento un'educanda umiliata a nome Margherita, la fece sua
sposa e l'ebbe sempre al suo fianco intrepida ed amorevole compagna. Non fa
d'uopo dire che la setta degli Apostolici fu perseguitata non meno
vigorosamente delle altri rivali. E quattro dei più riottosi e lo stesso capo,
il Segalelli, furono bruciati vivi nel 1300, e frate Dolcino potè appena
campare con tremila dei suoi negli aspri e invalicabili gioghi di Val Sesia,
dove per parecchi anni tenne testa alla crociata che a nome di Clemente V il
vescovo di Vercelli gli aveva bandita contro. Senonchè alla fine i Crociati non
potendo sopraffare gli eretici col ferro, si decisero di prenderli per fame,
facendo il vuoto intorno a loro e distruggendo per larga distesa i campi e i
villaggi, dove avrebbero potuto rifornirsi di viveri. Così i giorni di
resistenza erano contati, ed a ragione Dante con postuma profezia cantava:
Or di' a fra
Dolcin dunque che s'armi
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Sì di vivanda
che stretta di neve
Non rechi la
vittoria al Novarese.
La vittoria
infatti, dopo tanti rovesci non si fece lungamente aspettare ai Crociati, che
dato l'ultimo assalto, molti degli eretici passarono a fil di spada, ed altri
trassero prigioni, tra i quali lo stesso fra Dolcino e Margherita, che anche
negli ultimi momenti non volle da lui separarsi. Ed entrambi senza proferire un
grido patirono le più crudeli torture, ed ebbero le carni a brani a brani
dilacerate da tenaglie roventi, e più morti che vivi furono dati alle fiamme.
Nello stesso
anno 1260 in cui erano sorti gli Apostolici, e da tutti si aspettava trepidando
la tremenda catastrofe profetata da Gioacchino, un altro moto ebbe principio,
quello dei Flagellanti. Anche prima di quel tempo s'erano adoperate le
fustigazioni sulla nuda carne dapprima soltanto come pena pubblica per certe
specie di misfatti, e poscia come specie di espiazione o mortificazione
volontaria. E fin dal 1233 si narra di gente che, uscendo dalle prediche di
Sant'Antonio da Padova si percuoteva sulle pubbliche vie per penitenza dei
proprii peccati. Numerose torme di devoti vestite di bianco andavano in
processione da una città all'altra, flagellando le nude spalle, e cantando pie laudi non nel latino della Chiesa, ma
negl'idiomi volgari. Dovunque capitavano, ogni negozio e pubblico e privato era
sospeso, i partiti politici facevano tregua e promettevano di riconciliarsi in
perpetuo, e di null'altro si davan cura e uomini e donne fuorchè del far
penitenza in attesa delle terribili calamità che doveano precedere il
rinnovarsi del mondo. Il pnitentiam
agite o volgarmente penitenzagite era stato anche il grido del Segalelli, e
non tarderà molto che la Chiesa avrà in sospetto queste insolite e spasmodiche
esplosioni del sentimento religioso, e se non i primi, certo i posteriori
flagellanti furono accusati di eresia e sottoposti anch'essi all'Inquisizione.
Intorno allo
stesso tempo infine si propagò un'altra setta ereticale, quella dei Guglielmiti
che riguarda più da presso voi, mie longanimi uditrici, come l'unico esempio
che s'abbia in quell'età di sovvertimento religioso iniziato dal sesso gentile.
A capo di questa setta fu una donna di sangue regale a nome Guglielma, figlia
della regina Costanza di Boemia e venuta in Milano per diffondere la sua
dottrina. Ai suoi fedeli si annunziava come l'incarnazione dello Spirito Santo,
sceso anche lui come il Figliolo sulla terra per fondare la nuova religione
spirituale, che dovrà tenere dietro al Cristianesimo. La banditrice di queste
dottrine, fornita di parola eloquente e di non comune coltura, seppe guadagnare
alla sua causa parecchi seguaci, fra i quali alcuni preti e una Menfreda o
Maifreda parente a quel che pare dei Visconti. Forse a cagione del nobile
lignaggio e delle potenti amicizie e delle condizioni politiche del Milanese
non fu molestata Guglielma finchè visse, e nel 1281 quando morì le furono resi
solenni onoranze. Ma quando Maifreda pensò di succederle nell'apostolato, e non
dubitò di celebrare la messa e di spezzare il pane eucaristico ai suoi fedeli,
l'Inquisizione se ne mescolò. E non solo Maifreda e un suo compagno, Andrea
Seranita, perirono sul rogo, ma furono bruciate e disperse al vento le ossa di
Guglielma, che da più di diciotto anni riposavano in ricco mausoleo
nell'abbazia di Chiaravalle.
Ed ora dopo che
i nomi e le dottrine di tante sette ereticali abbiamo ricordate, ci sia lecito
domandare qual valore ha tutto questo moto religioso nella storia dell'umanità?
Che non fosse un moto superficiale lo prova il fatto della sua lunga durata e
dei terribili espedienti a cui si dovè ricorrere per distruggerlo. Noi
guardiamo il Medio Evo sotto una falsa luce quando lo presentiamo come l'êra
della più rigida ed universale unità di fede che siasi data al mondo. Tutto al
contrario quando la fede è viva, come fu nel Medio Evo, quando il problema
religioso agita migliaia di anime, le soluzioni che se ne porgono, non sono nè
possono essere uniformi. Anche nella religione come in tutte le opere dello
spirito, più ancora che in quelle della natura, la lotta è una condizione di
vita. Ed aspra e terribile fu la lotta che sostennero le diverse sette
ereticali, e nessuna dette quartiere all'altra, e tutte produssero a dovizia e
martiri ed eroi. Perchè dunque il movimento religioso del Medio Evo non
perdurò? Perchè le sette ereticali l'una dopo l'altra, disparvero pressochè
tutte in un oblio tanto più profondo, quanto più rigogliosa ed agitata fu la
loro vita? La ragione principale a prescindere da parecchie altre che carità
per voi mi vieta di esporre, sta in quello che dissi fin dal principio, che
cioè la maggior parte delle sette ereticali del Medio Evo era informata ad uno
spirito d'intolleranza ed esagerazione ascetica e qualunque di esse fosse stata
vittoriosa, avrebbe mosso alla famiglia, allo Stato e alla coltura una guerra
più rovinosa e implacabile che alla Chiesa stessa. Per dirla in una parola
sola, l'eresia medioevale, procedendo a ritroso del progresso dello spirito
umano, ragion voleva che nel rifiorire dell'umanesimo, non che prosperare,
andasse ferita a morte. All'intristire delle sette ereticali del Medio Evo una
sola eccezione si conosce, e ci è porta dalla Chiesa valdese, la quale però
solo per questo seppe sfuggire al fato inesorabile della storia che, messi da
parte i vecchi ideali di povertà e di astinenza, non dubitò di attingere nuovo
spirito e indirizzo nuovo dalla nascente Riforma.
LE ORIGINI
DELLA LINGUA ITALIANA
DI
Pio Rajna
L'argomento che
mi rassegno a trattare tocca signore e signorine più da vicino di quel che
forse non credano. No davvero - guai a me se neppur ci pensassi! - per via
dell'opinione, tutta mascolina, che attribuisce alla donna una predilezione
particolare per l'esercizio di quel prezioso strumento che è la lingua. I
motivi miei sono di natura ben differenti. Mi s'affaccia quel luogo della Vita Nuova (§ xxV), dove Dante afferma
che «lo primo che si mosse a dire siccome potea volgare si mosse perchè volle
fare intendere le sue parole a donna» - alla donna del suo cuore - «alla quale
era malagevole ad intendere le parole latine.» Che se qui s'ha a fare con
un'idea personale, dove la critica inesorabile anche coi grandi e coi massimi,
trova che al vero è frammisto l'errore, Dante non immagina nè argomenta -
ripete ed osserva - quando per bocca di Guido Guinizelli designa coll'epiteto di
«materno» il nostro linguaggio, insieme con uno de' suoi stretti parenti
d'oltralpe:
O frate, disse,
questo ch'io ti scerno
Col dito (e
additò uno spirto innanzi)
Fu miglior
fabbro del parlar materno.
(Purg., xxvi, 115.)
«Parlar
materno»: quello che il bambino impara dalle labbra di chi, dopo avergli dato
la vita, «vegghia», per dirla ancor con Dante, «a studio della culla» sua, ne
regge i primi passi, ne desta con pazienza instancabile le facoltà
intellettive. Così la nuova favella ci viene innanzi doppiamente illuminata dal
sole dell'amore: dell'amore nella più intensa e nella più santa delle sue
manifestazioni.
Dichiaratamente
nelle parole della Vita Nuova,
tacitamente eppure in modo altrettanto sicuro in quell'epiteto di «materno»,
che suppone di necessità qualcosa che materno non sia, di fronte al volgare sta
la lingua latina. Se ne sta maestosa, superba di una nobiltà due volte
millenaria, che nell'ordine suo non ha assolutamente l'uguale. La sua storia è
la storia stessa di Roma. Al pari di Roma e insieme con lei il latino prese le
mosse da principii umili ed oscuri, e a poco a poco arrivò ad una grandezza da
sbalordire. Non era già nemmeno all'origine il linguaggio di Roma soltanto.
Prima ancora che presso alle rive del Tevere sorgessero sul Palatino i tugurii
destinati a diventare un giorno i palazzi dorati degl'imperatori, la favella
che qui aveva a rimbombare sonava in altre parti del Lazio, più salubri e più
fertili. E il Lazio continuò sempre a parlar latino, e il latino non cessò mai
di chiamarsi così, vale a dire per l'appunto «lingua del Lazio». Ma cosa
importa mai ciò? Solo in quanto era la lingua di Roma, il latino si venne
estendendo fuori del suo proprio territorio. La conquistatrice del mondo fu
Roma, non il Lazio, che al pari del resto dovett'essere domato e conquistato
ancor esso. E il latino che si propagò, fu il latino quale s'era venuto
foggiando e modificando dentro nella città, la quale, alla stessa maniera come
nel rimanente, dettò la legge anche per ciò che riguarda il linguaggio. Però il
parlare elegante fu detto «sermo urbanus», parlar cittadino, intendendo per
«urbs» la città per eccellenza: Roma, e nient'altro che Roma.
È una storia
meravigliosa quella della conquista romana: compiuta passo passo attraverso a
fiere dissensioni interne ed a rivolgimenti non pochi, con una tenacia ed una
coerenza rare a trovarsi negli individui, e che qui viene ad aversi in un
popolo, per una serie interminabile di generazioni. Ma non è troppo meno
meravigliosa neppure la storia della propagazione del latino. La conquista
linguistica tien dietro alla politica: la rafferma, e le mette il suggello. E
le due conquiste hanno un'intima analogia. Politicamente, la conquista viene ad
essere come un immenso dilatarsi della città, e l'effetto suo finale si
riassume nella qualità di cittadino romano conferita alle genti che s'erano via
via soggiogate, soffocando a poco a poco il sentimento, così vivo un tempo,
delle molteplici nazionalità. Urbem
fecisti qui prius orbis erat, - tu facesti città ciò che prima era il
mondo, - dice al principio del quinto secolo un Gallo, Rutilio Namuziano (1,
66), con un gioco di parole che racchiude un concetto sublime. E nell'ordine
linguistico, abbiamo il linguaggio di questa nostra medesima città che si va
facendo comune a una immensa estensione di terre, e che colla sua voce tonante
prima impedisce che s'odano, e poi riduce ad ammutire una moltitudine infinita
di parlate, e non già unicamente di parlate rozze ed incolte. Solo il greco,
grazie alla portentosa civiltà di cui era stato ed era tuttavia strumento ed
espressione, potè mantenersi prospero, pur dovendo rassegnarsi ancor esso a
vedersi mozzati quei rami che sporgevano ben rigogliosi sul suolo occidentale.
Questa
meravigliosa unificazione della favella fu possibile appunto per via della
trasformazione che il sentimento della nazionalità venne a subire dovunque, se
non in tutti; le genti più disparate si condussero a parlare a somiglianza dei
Romani, non solo perchè ciò riusciva praticamente utile sotto molti rispetti, ma
anche per il motivo che il chiamarsi Romano - Romano, si badi bene, non Latino,
nè altra cosa - era per ciascuno argomento d'orgoglio. Dentro ad ogni animo
s'avevano, più o meno in confuso, sentimenti analoghi a quelli coi quali
ineggia a Roma Claudiano, un nativo della greca Alessandria; a Roma «della
quale», egli dice (De cons. Stil.,
iii, 131),«nulla in terra di più eccelso ricopre il cielo;.... madre dell'armi,
madre delle leggi, che stende su tutti il suo impero, prima culla al diritto.
Quest'è colei che nata in angusti confini, mosse all'uno e all'altro polo, e
allargò le mani quanto è il corso del sole;.... quest'è colei che sola accolse
nel suo grembo i vinti, e carezzò il genere umano con un unico nome, madre, non
signora; e chiamò concittadini coloro che aveva soggiogato; e le cose lontane
congiunse con vincolo pio. All'opera sua pacificatrice noi tutti dobbiamo che
in paese straniero siam come in patria: che ci è lecito mutar sede; che....
penetrare in ciò ch'era un tempo spaventosa solitudine, è divenuto un gioco;
che ora beviamo il Rodano, ora l'Oronte; che tutti siamo un sol popolo.» Quod cuncti gens una sumus! Del
linguaggio Claudiano non parla: ma quanto sia grande l'efficacia sua nel fare
che si senta di essere un popolo solo, sa l'Italia unita, e meglio ancora
sapeva l'Italia divisa e fatta a minuzzoli.
Così al quinto
secolo dell'êra volgare il mondo presenta uno spettacolo davvero invidiabile.
Il bel sogno di una lingua universale, ben prima che dall'inventore e dagli
adepti del volapük vagheggiato da intelligenze veramente sovrane, si poteva
dire allora una realtà. La favella che s'ode sul Tevere, s'ode sul Danubio,
sulla Senna, sull'Ebro, lungo le spiagge settentrionali dell'Africa; quella
favella è intesa negli stessi dominii dell'ellenismo, ai quali d'altronde sono
state sottratte le coste e le isole italiane, e le colonie galliche ed
iberiche, dove il latino non giunge, o non è civiltà, o sono civiltà appartate
e ignorate. E gli effetti di questa condizione di cose si mantennero poi lunghissimamente,
grazie sopra tutto al cristianesimo, che nell'unità romana trovò una
preparazione indispensabile all'opera sua; e che, innestandosi su di essa,
cooperò quanto mai a perpetuare il latino, qual lingua del culto e della
coltura, procacciandogli anche nuove e ben ragguardevoli espansioni. E lingua
del culto essa rimane tuttavia per quella chiesa che chiama sè stessa
«cattolica», cioè universale; e ad essere lingua della coltura non rinunzia che
lentissimamente, e ben a malincuore. È un danno di sicuro sotto certi rispetti;
ma è tuttavia una necessità inevitabile. L'amore della vetusta e poderosa rocca
dove gli antenati abbian gioito e sofferto, e dalle cui feritoie abbiano
respinto un tempo Dio sa quanti fieri assalti, non persuaderà nessuna nostra
gentildonna a ridurre là dentro la propria vita, a meno di trasformare
siffattamente ogni cosa da snaturarla affatto. Da quelle mura, da quelle vôlte
scende un gelo che mette un brivido nelle ossa. Le seggiole, le cassapanche,
gl'inginocchiatoi, i letti su cui posarono le membra le castellane del secolo
dodicesimo e tredicesimo, paiono strumenti di tortura alle nipoti; le quali
d'altronde non trovano tra quelle pareti di che soddisfare a un'infinità di
bisogni, che l'età moderna ha creato ed imposto.
Questo mio
discorrervi del latino e della sua propagazione, viene - ben lo capite -
dall'idea di uno stretto legame colla lingua che diciam nostra, ed anzi in
genere colle cosidette lingue romanze: l'italiano, il francese, il provenzale,
il catalano, lo spagnuolo, il portoghese, il rumeno, e, se non vi adontate,
anche l'umile romancio, che tutti, colla loro stretta somiglianza, rendono
ancora l'immagine dell'umanità romana, e ce ne consentono sempre in parte i
benefici. E un legame è così potente da essersi sempre visto e conosciuto da
chiunque, anche in età tuttora inesperte, ebbe a fissare poco o tanto
l'attenzione su questo soggetto. Di tempo in tempo non mancarono tuttavia
certuni, che, senza proprio mettere fuor dell'uscio il latino, non disposto
davvero a tollerare un trattamento siffatto, lo accompagnarono fin presso la
soglia. Costoro si fecero paladini delle lingue che dal latino si dicono
sopraffatte, costringendo a prendere le loro parti quella sciagurata creatura
che è l'etimologia: una gran dama ridotta spesso a servire a tutte le voglie.
Così mentre vi parlo, quasi immagino di veder qui apparire Pier Francesco
Giambullari, a rintronarci gli orecchi coll'etrusco, ch'egli beninteso,
conosceva anche meno assai - ed è tutto dire! - di quel che si conosca noi
moderni. Ma le beffe toccategli da Lasca forse lo avranno indotto, se non a
mutar idea - giacchè un erudito che consenta a disdirsi è un po' difficile da
trovare - a credere prudente il tener chiusa la bocca. A ogni modo poi a lui
dovrebb'essere difficile il ricomporre e dare un aspetto presentabile alle sue
ossa, ridotte chi sa in quale stato dentro alla sepoltura più che trisecolare
di Santa Maria Novella. Vero che il modo di risorgere pare averlo trovato un
contemporaneo di Pier Francesco, Gioacchino Perion, che analogamente sostenne
greca - facendosi puntello di Marsiglia, greca di origine e per più secoli - la
derivazione del francese, e l'anima del quale dev'essere passata nel bollente
abate Espagnolle «du clergé de Paris», che da alcuni anni scaraventa volumi
dietro volumi nel viso di quella che presume di essere la scienza moderna.
Povero Perion! Egli non deve tuttavia essere troppo contento di questo suo
ritorno nel mondo. Prima o poi bisognerà bene che si stanchi di non destar
altro che risa e che s'accorga di far la figura di un guerriero di Carlo Magno,
che con lancia e mazza tutto vestito di ferro, si gettasse nel fitto di una
nostra battaglia. Continui del resto, se così gli piace, il signor Espagnolle a
rallegrarci colle sue etimologie, degne di tener compagnia a quelle che per il
suo dialetto ebbe ad escogitare il «Varon Milanes»: «Biot. Nudo, povero. È tratto
dal greco Βιοτος (sic), quale significa la vita e per questo si chiama Biot uno qual
ha la vita solamente....» «Bobaa. Si usa co' figliuoli piccoli e significa male. Credo veramente sia stato tolto
dal greco, ancorchè sia alquanto corrotto, imperciocchè
Βολαι appresso i greci dicuntur dolores qui sentiuntur in partu.» Ma per verità faccio
torto al Varon dandogli un compagno siffatto; che egli è ben lontano dal
farneticare quanto l'abate parigino, del quale d'altronde non ha nemmeno per
ombra la sicumera e la spavalderia.
Abbandoniamo
alla loro sorte questi timonieri, che in una notte cupa guidano la nave a
capriccio, dopo aver sdegnosamente gettato in mare la bussola. Quanto a noi,
teniamoci sulla terra dove ci troviam davanti una strada, resa sempre più
solida, sempre più ampia, dalle assidue fatiche dei lavoratori che si succedono
numerosissimi.
Rispetto dunque
alla derivazione sostanzialmente latina delle lingue romanze in generale, e
dell'italiana segnatamente, cui nessuno contrasta il vanto d'essere tra le
sorelle quella che più da vicino ritrae le sembianze materne, non può esserci
dubbio se non in chi abbia la disgrazia di esser cieco d'occhi o di mente. Gli
è solo quando si viene alle particolarità, che dei dissensi erano lecitissimi
in addietro e che in parte sono leciti ancora. Un tempo prevaleva il concetto
che i nuovi linguaggi fossero usciti da una corruzione prodottasi nel latino
quando sopraggiunsero le orde barbariche, e quando la civiltà romana si venne
offuscando e spegnendo. Era naturale, date le conoscenze d'allora, che si
immaginassero le cose in questa maniera; e coloro che pensavan così ragionavan
per solito con miglior logica di taluno, che sostenendo invece parlato di già
l'italiano dal popolo di Roma fin dai tempi della repubblica, ebbe a scroccarsi
(porta in pace la verità, ombra di Leonardo Aretino!) fama di precursore. Forse
che la corruzione del latino non appariva evidente? Si ficchino gli occhi
dentro alle pergamene notarili del medioevo che ci son pervenute a decine e
decine di migliaia, e che paiono portarci la voce, nonchè d'ogni secolo, d'ogni
anno, d'ogni mese, e pressochè d'ogni giorno. Che sorta di latino è mai quello!
Per non dir nulla del vocabolario, la grammatica è ita tutta a soqquadro; i
casi, le terminazioni, i suoni, la sintassi, ballano una ridda assolutamente
pazza; nessuno sa più, o vuol più sapere quale sia il suo ufficio, e in cambio
di contentarsi di quello, adempie indistintamente qualsivoglia funzione;
insomma, suppergiù uno spettacolo quale s'avrebbe se un bel giorno ciascuno di
noi si destasse dimentico affatto di ciò ch'egli è; e la moglie mettesse, non
solo metaforicamente, ma proprio anche in realtà, i calzoni del marito; e il
marito entrasse nelle gonnelle della moglie, e così vestito corresse alla
chiesa a dir messa; e il magistrato scendesse in toga a spazzare le strade, per
poi ritornarsene a render giustizia colla granata fra le mani. O non è questo
il caos donde avrà poi ad uscire il nuovo ordine?
Non è, nè poco
nè punto. In fatto di lingue realmente parlate il caos non esiste. Anche il più
barbaro, anche il più incolto tra i linguaggi è regolare nella sua struttura, e
irregolare apparisce unicamente a chi s'è fitto in capo l'idea di volerlo
diverso da quel che è. Bensì avviene - e ciò soprattutto per l'appunto nelle
lingue colte, o per opera loro - che si producano parziali disordini: ma questi
non sono tali da turbar l'armonia dell'insieme più di quel che facciano in
musica certe dissonanze. Perfino nei casi in cui due linguaggi si compenetrino
e si mescolino intimamente, l'uno assume il predominio, l'altro gli si
subordina, ed è un assetto, non uno scompiglio, che viene ad aversi. I signori
anarchici potranno mandare all'aria tutte le istituzioni sociali; ma nel
dominio della favella, del pari che nella natura, bisognerà che si rassegnino a
lasciar imperare dispoticamente la legge.
Però, nessun
dubbio che il parlare dei nostri antichi, e nel sesto, e nel settimo, e
nell'ottavo secolo, e giù giù fino al milledugento, non fosse in sè stesso
regolarissimo, non altrimenti da quel che sia ora. Variamente regolare: non
conforme cioè da luogo a luogo, per l'appunto com'è anche adesso; ma ciò fa
meno che nulla, e di ciò s'avrà da toccare più tardi. Era regolare il
linguaggio che usciva dalle labbra dei cittadini di Venezia, di Amalfi, di
Genova, di Pisa, che insieme con loro correva i mari, intrecciava commerci,
stabiliva fattorie, conquistava terre vicine e lontane; era regolare il
linguaggio di ciascuna delle città lombarde che si stringevono in lega contro
il Barbarossa; regolare il linguaggio delle generazioni oscuramente gloriose
che avevano fecondato e propagato i germi di quelle libertà comunali, di cui
allora s'intraprese la difesa e si conseguì il trionfo; regolare il linguaggio
del popolo di Milano, raccolto a combattere dattorno al carroccio di Eriberto;
e come parlavano una favella regolare gl'Italiani che si rivendicavano comunque
a grandezza e libertà e che sapevano restituire ai molteplici frammenti della
gemma lo splendore che un tempo era stato nella gemma intera, una favella
regolare parlavano ben anche coloro che s'erano lasciati asservire dai Franchi,
asservire dai Longobardi, e che inermi s'erano ridotti via via in uno stato di
abbiezione.
Quanto alla
confusione caotica offertaci dalle carte, non è già una lingua, bensì
unicamente l'effetto dello sforzo di servirsi di una lingua, che si conosce
come Dio vuole. Corrisponde al francese, che parecchie volte ebbe a richiamare
un sorriso sulle vostre labbra, o signore, all'indirizzo di qualche mal
capitato; al tedesco che a me accade di usare trovandomi in regioni germaniche;
all'italiano dei visitatori stranieri delle nostre gallerie e dei nostri
monumenti, e un pochino altresì a quello che s'ode da bocche lombarde,
piemontesi, liguri, veneziane, napoletane e da quanti insomma, me compreso, non
ebbero fortuna di nascere in questa terra benedetta. Ma fate che il tedesco
parli tedesco, inglese l'inglese, bergamasco il bergamasco, genovese il
genovese, e ciascuno di loro discorrerà corretto, sì da poter essere nel suo
genere un vero testo di lingua. Non altrimenti quei notai che ci fanno così
inorridire coi loro spropositi, eran gente che nella vita comune, quando nulla
li costringeva ad usare un linguaggio oramai loro estraneo e quando potevano
esprimersi liberamente nel loro particolare dialetto, non commettevano nessuna
sgrammaticatura e non avrebbero fatto la ben minima offesa alla più umile tra
le lettere dell'alfabeto. Sicchè quel loro scrivere ci dice solo due cose: da
un lato, la loro ignoranza del latino, e in genere il difetto d'ogni coltura,
una volta che il latino ne era il solo strumento; dall'altro, la differenza ben
ragguardevole che doveva esserci tra il latino e la loro favella nativa.
Ma perchè mai
costoro non ricorrevano dunque al partito così semplice di scrivere come
parlavano? Forse per quel benedetto vizio che trascina noi tutti a far ciò che
non sappiamo, e che ha per effetto di renderci ballerini goffi, cantanti
stonati, conferenzieri infelici! - Non per questo, o signori; bensì per la
ragione stessa per cui al contadino lombardo, che, sapendo appena tenere la
penna in mano, dall'America o dall'Australia dà conto di sè alla famiglia,
dotta al pari di lui, non passa nemmeno per il capo di valersi del dialetto suo
proprio. Dalla sua penna il dialetto stillerà ciò non ostante sulla carta: ma
suo malgrado e in una forma mista, ibrida, che se non è italiana, è tuttavia
lontana altrettanto dall'essere schiettamente dialettale. Già, volendo scrivere
il dialetto, egli si troverebbe di fronte ad una difficoltà, da parer forse
lieve finchè solo ci si pensi, ma gravissima invece non appena si provi: la
difficoltà del rappresentare colle lettere i suoni che facili e spontanei
escono dalla bocca. Ma contro questo muro, così arduo da scalare, egli non
arriva nemmeno a dar di cozzo, perchè nella sua mente scrittura e italiano son
due cose da non potersi scindere; quei pochi scarabocchi che imparò fanciullo
nella scuola del villaggio, li imparò tracciando parole italiane; ogni volta
che si mise a decifrare qualcosa di scritto o stampato - l'avviso esposto al
pubblico sulla parete della casa comunale, il vecchio volume delle Vite dei
Santi o la storia di Bertoldo, il Secolo
riportato di città dal suo vicino - fu sempre coll'italiano ch'egli ebbe a
combatterla. Così, un linguaggio che ha adempiuto a funzioni letterarie mentre
era vivo, continua ad adempierle anche dopo morto; il cadavere mummificato del
re defunto è lasciato sul trono per generazioni e generazioni, e a lui i
sudditi continuano a far riverenza, finchè a poco a poco il bisogno di un
signore effettivo e che possa muovere braccia e gambe, non porti a ribellarsi a
quel mero simulacro. Figuriamoci quanto durevolmente, qui da noi soprattutto,
vale a dire in patria, si dovesse continuare a prestar omaggio al latino, che
aveva dietro di sè un passato così splendido di gloria! Poi, quel tanto di
coltura che rimaneva, e che per scarso che fosse in generale, era ben lontano
dal ridursi a ciò che s'immaginerebbe guardando solo ai notai, si trovava nelle
mani della Chiesa: della Chiesa, cui una lingua da potersi dire universale
riusciva indispensabile, e che questa lingua aveva trovato nel latino da
secoli. Per tal modo nel latino la vita s'era spenta da un pezzo, e ancora
nessuno s'era accorto della morte sua. Bisognerà venire fino al tempo di Dante,
perchè dell'atto di morte si stenda la minuta, salvo l'esserci poi ancora per
quasi due secoli chi s'arrabbatti per buttare quella minuta sul fuoco. E per
Dante stesso gl'Italiani saranno «Latini,» e «Volgare Latino» il loro
linguaggio abituale.
Il loro
linguaggio! Ma donde era mai uscito questo linguaggio, se le sue origini sono
latine, e nondimeno esso non è una degenerazione del latino classico? - Per
rispondere bisogna che prenda le cose più di lontano di quel che sarebbe nei
vostri desiderî. Ringraziatemi tuttavia ch'io non le prenda più di lontano
ancora! Quel titolo insidioso di Origini
me ne darebbe il diritto; giacchè quando si discorre di origini ci si trova
nelle condizioni di chi salga un monte, di cui crede via via di vedere la
sommità. Si trascina lassù, e arrivatoci, vede sopra di sè un'altra cima, che,
superata, gli giocherà poi anch'essa il medesimo tiro. E il monte per lo più è
così alto, che il povero ascensore cade a terra sfinito avanti che gli sia dato
di scorgere la cima vera. E quand'anche poi gli riuscisse alla fine di
raggiungerne il piede, essa sorgerebbe sopra di lui qual roccia inaccessibile,
colla vetta perpetuamente avvolta tra le nubi. Così in questo caso sarei nei
miei diritti, se, chiamato a discorrervi delle origini della lingua italiana,
mi mettessi a parlare delle origini del linguaggio umano.
Non è dunque discrezione
il contentarsi ora (non me ne contentai prima!) di muovere dagli ultimi tempi
della Roma repubblicana e dai primordi dell'imperiale, salvo lo spingere più
addietro unicamente qualche occhiata fugace? Siamo al periodo classico della
letteratura latina: a quello in cui rifulgono Cicerone, Cesare, Livio. Dando
ascolto al parlare di questi grandi, dovremmo subito avvertire una diversità
dal linguaggio delle loro storie, delle orazioni, delle epistole medesime. La
diversità viene in parte da quella tendenza che porta inevitabilmente chi
scrive, anche quando non vorrebbe, ad essere più raffinato che non sia
discorrendo; in parte si deve a ciò, che la lingua scritta è di sua natura
essenzialmente conservativa, e però tende a mantenere una condizione di cose
rispondente al parlare di un tempo trascorso; in parte è l'effetto di una
speciale elaborazione che le lingue subiscono nella tradizione letteraria, e
che già fino dal principio le condusse ad essere fissate tanto o quanto
differenti da quel che fossero nell'uso, come son fissate le sembianze di una
donna non troppo favorita dalla natura per mano di un artista abile e
compiacente. Quest'ultimo punto ha davvero nella storia del latino
un'importanza ragguardevole, sebbene lontana dall'essere chiarita quanto si
desidererebbe. In forza dell'elaborazione letteraria si restituirono in tutta
la loro pienezza certi suoni, che nel parlare erano oscillanti, o divenuti
addirittura quasi muti. Colori sbiaditi, e anche pressocchè svaniti del tutto,
furono resi alla loro vivezza originaria. Si fece qualcosa di analogo a quel
che si farebbe quand'anche si cominciasse ora soltanto a scrivere il
fiorentino. Poichè si dice la hasa,
ma accasa, in casa, si scriverebbe casa
dovunque, come tutti facciamo, senza tener conto della sorte toccata in certi
incontri a quella prima lettera, gravissimamente malata in Firenze, e morta di
già a Pisa e a Livorno, dove la gente bassa non ha più la su' hasa, ma soltanto la su'
asa.
Sicchè, una
prima distinzione dal latino scritto al parlato. Ma poi il latino parlato era
necessariamente vario di esso stesso. Tra il fiorentino di quante tra voi, o
signore gentili, son nate all'ombra del Cupolone, e quello del popolino di «San
Friano», la differenza non è piccola. Differenza di suoni, di forme, di
vocaboli. O come mai non sarebbe stato il medesimo a Roma, dove le disparità
sociali non erano minori davvero che presso di noi, e dove il patriziato e la
plebe continuarono a trovarsi a fronte, sicchè si può dire che tutta la storia
interna sia storia della lotta tra queste due classi? Però dal latino scritto
non differiva troppo profondamente quello della gente nobile e colta; e perchè
questa, conservatrice in tutto, tendeva a conservare anche in fatto di lingua;
e perchè la lingua letteraria s'era modellata su quella de' suoi antenati; e
anche perchè sul parlar suo i libri esercitavano efficacia. Ma le differenze
venivano via via aggravandosi mano mano che si scendesse, e finivano per essere
massime quando s'era fra l'ultimo proletariato. Quindi una moltitudine infinita
di varietà, non altrimenti da quel che s'abbia fra di noi, dove qualcosa di
particolare, per quanto non s'avverta, viene ad esserci nel parlare d'ogni
famiglia, d'ogni singola persona. Queste innumerevoli varietà, e neppure i loro
estremi, non costituiscono neanche per ombra differenti linguaggi; il latino
tutte quante le abbraccia; per sfumature insensibili noi passiamo da un verde
cupo a un verde chiaro, ma il colore fondamentale è sempre il medesimo.
Ebbene: le
lingue cosidette romanze sono - con un arricchimento di voci straniere e
specialmente germaniche non dissimile da quello che s'era avuto anche per
l'addietro, segnatamente da fonte greca - la continuazione non mai interrotta
del latino parlato, e in generale, non del latino aristocratico e neppure di
quello dell'infima plebe, bensì del popolo di condizione media, accessibile del
resto così alle azioni che vengon dall'alto come a quelle che muovon dal basso.
Che proprio sia così, dice la ragione, dacchè è l'uso dello scrivere, non già
del discorrere, che si viene affievolendo; e confermano mille e mille prove, in
quanto ogni spiraglio che s'apre per un verso o per l'altro sul latino
popolare, ci fa scorgere attinenze coi linguaggi neolatini ignote al latino
delle scritture. Questo latino popolare a poco a poco si venne in sè stesso
trasformando: lentamente prima, finchè la civiltà romana stette in piedi,
abbondarono le scuole, e la letteratura potè avere un'efficacia ritardatrice;
più rapidamente d'assai, una volta che tutto ciò venne meno. Il fiume che prima
si moveva tardo, prese a correre precipitoso, trovandosi arrivato ad un forte
pendio. In questo senso, e non già in nessun altro, si può dire che la
formazione dei nuovi linguaggi venga a cadere tra il sesto secolo ed il nono od
il decimo.
Ma questi
linguaggi diversificano tra di loro. O come mai, se sgorgano da una stessa
sorgente? - Trasportato fuori di Roma, il latino dovette sonare alquanto
differente a seconda che se lo appropriavano popolazioni avvezze ad una favella
o ad un'altra: a quel modo che suona diverso l'italiano, nonchè in bocca
francese, inglese, tedesca, in quella dei nativi di ogni nostra città, di ogni
nostro villaggio. La continuità dell'azione romana, la forte unità, ed i mille
contatti, attenuarono per un certo tempo gli effetti di questa condizione di
cose, e poterono anche dar luogo a una convenienza maggiore e più durevole
assai di ciò che a prima giunta si penserebbe; ma diversità s'ebbero e si
mantennero. Orbene: queste diversità, fattesi assai maggiori una volta che
l'impero cadde in isfacelo e l'unità fu spezzata e accresciuta dal tempo che
permette alla gocciola di scavare la pietra, sono la prima causa che ha dato
origine alla moltiplicità delle lingue e dei dialetti. Insieme se n'ebbero bene
anche altre; ma di fermarci a considerarle da vicino, a noi manca qui il tempo.
Se v'ho
inflitto il supplizio di questa esposizione, col cuore del chirurgo che taglia
le prime sue.... cioè, non sue gambe, non vorrò certo che v'insudiciate col
buttarvi a terra per accostare l'orecchio al suolo, e sentire il rumore, qui
tenue e confuso, più là invece ben distinto, del torrente che scorre sotto
invisibile; e nemmeno, s'intende, vi farò correre il rischio di slogarvi i
piedi e scorticarvi le mani per venire colà, dove, tra un ammasso confuso di
rottami di rocce, spiando intentamente, si vede spumeggiare qualcosa nel fondo.
In altre parole, non verrò raccogliendo le tracce innumerevoli del volgare dai
monumenti stessi della latinità e dalle scritture dei primi secoli del
medioevo, dove il volgare si rivela, per lo più inconsciamente, collo
spropositare continuo, ma non di rado anche consciamente, sopratutto nelle
denominazioni dei luoghi.
Alla fine, se
Dio vuole, un filo d'acqua esce fuori; un filo d'acqua soltanto, ma più che
bastevole per rivelare in modo non dubbio a tutti quanti i sensi la presenza
del sospirato elemento. È il 960, e siamo a Capua, nel tribunale del giudice
Arochisi. Davanti a lui stanno Rodelgrino Aquinate, e Aligerno abate di
Montecassino, contendendo per la proprietà di certe terre tenute dal monastero.
L'abate ha condotto con sè dei testimoni: Teodemondo, diacono e monaco, Mario,
chierico e monaco, Gariperto, chierico e notaio. E ciascuno di costoro,
separatamente e successivamente, tenendo in mano una pergamena dove sono
indicati i confini delle terre contestate proferisce queste parole: «Sao ke
kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte
sancti Benedicti.» Signori facciamo un inchino ben profondo. È questa, nella
sua gretta povertà, la prima proposizione risolutamente e volutamente volgare,
sia pure con uno sprazzo di latinità ancor essa, in cui accadde d'imbattersi.
La mascherina che finora aveva sempre falsata la voce, ha avuto un momento di
abbandono e ci si è manifestata per ciò che essa è. Se prima si ostinava a
parlare una favella non sua, e della favella sua vera ci faceva accorti
soltanto collo spropositare continuo, coi costrutti, e con parole e frasi
staccate, ora s'è proprio lasciata andare per un momento a discorrere nel suo
linguaggio nativo.
Di questo
abbandono par tuttavia che la maschera si penta; e, salvo qualche ripetizione
di quelle parole medesime o press'a poco, noi siam costretti a starcene in
ascolto forse un secolo - un secolo che non ha per buona sorte il potere
d'invecchiarci - perchè il fatto si rinnovi. E fortunati noi, che insieme col
privilegio dell'eternità ci troviamo avere pur quello, quind'innanzi ancor più
necessario, di passare colla rapidità del pensiero da un luogo all'altro! Per
stavolta tuttavia basterà che ci si trasporti a Roma, sotto le vôlte della
basilica inferiore di San Clemente, sepolta fra le macerie nel 1084 per le
devastazioni di Roberto Guiscardo, e ricomparsa alla luce vent'anni fa. Fu
dunque avanti quell'anno fatale che un cotal «Beno de Rapiza», insieme colla
moglie Maria, fece ornare le pareti di pitture, che rappresentano scene della
vita del santo titolare, e la traslazione, a quel che sembra, del corpo di San
Cirillo. Tra queste pitture ce n'è una, dove si vedono tre uomini adoperarsi a
trascinare un fusto di colonna, ed un quarto, rivestito di manto, in atto di
comando. Accanto alle figure si leggono parole che i personaggi hanno da
pronunziare: «Fàlite dereto codo palo, Carvoncelle! - Albertel, trái! - Fili
de.... cani, traìte.» Ho detto «fili de cani»; ma veramente l'espressione non
sarebbe questa; giacchè, ciò che nel secolo XI si poteva scrivere sulle mura di
una chiesa, ritraendo i fasti di un santo, non si potrebbe sempre nel XIX
ripetere in presenza di signore.
Da Roma un volo
alla Sardegna; non già perchè vi ci attirino certe famigerate Carte d'Arborea,
che all'olfatto di chiunque abbia un po' di naso danno odor di tutt'altro che
di muffa. Ma di muffa, e di quella buona, sa il privilegio che tra il 1080 e il
1085 il «judice Mariano de Lacon» concede agli «homines de Pisas, per ca», egli
dice, «li sso ego amicu caru e itsos a mimi», determinando che nessun
comandante che vada a reggere una certa terra «n'apat comiatu de levàrelis
toloneum». Come? Si tratta di esenzioni di tributi? Ahimè: scappiam più che di
fretta, chè questi son discorsi proibiti per orecchie italiane!
Ritorniamocene
alla terra ferma, e ripieghiamo le ali sopra non saprei qual punto dell'Umbria,
delle Marche, lì d'attorno. Poichè la Pasqua è imminente, molti sentiranno il
bisogno di accostarsi ad un confessionale. Ed eccomi qui pronto a dar
l'imbeccata al penitente o alla penitente, pur sapendoli ben lontani dall'esser
lordi di nessuno tra certi peccatacci, di cui, s'io ridicessi tutto quel che mi
sussurra un mio suggeritore, dovrei fare la lunga enumerazione: «Domine, mea
culpa! Confessu so ad me senior Dominideu, et ad ma (t) donna sancta Maria....
de omnia mea peccata ket io feci da lu battismu meo usque in ista bora, in
dictis, in factis, cogitatione, in locutione.... Me accuso de lo Corpus Domini,
k'io indignamente lu acceppi.... Me accuso de lo genitore meo et de la
genitrice mia, et de li proximi mei, ke ce non abbi quella dilectione ke me
senior Domnideo commandao», ecc., ecc.!» Come si vede il volgare, è chiazzato
di latino, cosa che nella chiesa troppo ben si capisce. Viene ad aversi - e per
ragioni non dissimili - un impasto di linguaggio analogo al dialetto, che
stando alle commedie di Carlo Maria Maggi, solevano parlare nel secolo passato
le dame milanesi:
Donna Quinzia.
Don Leli, che
la sort
Sia tant
inviperì
Contro la
nostra Casa;
Che il noster
sanguu tant limpid fin'adess
S'abbia da
intorbidar con altra sfera,
L'è düra; ma
giacchè col fier destin
Contrastar non
si può,
Convien, stringend
i ogg, mandarla giò.
(Consigli di Meneghino, Atto I, sc. I).
Finora non s'è
avuto che prosa. Chiamiamo versi, per modo di dire, quelli che si leggevano un
tempo sopra l'arcata del coro del Duomo di Ferrara:
Li mille cento
trenta cenqe nato
Fo questo
templo a San Gogio donato
Da Glelmo
ciptadin per so amore;
E mea fo l'opra
Nicolao scolptore.
Versi potranno
esser chiamati con qualche maggior ragione quelli del cosidetto Ritmo
Cassinese: forse (pur troppo non s'è ancora trovato l'appiglio per una
datazione sicura) il più antico tra i nostri documenti volgari che mostri in
chi lo compose una certa quale intenzione e pretesa letteraria.
L'interpretazione dà molto filo da torcere; ma nella somma non par dubbio che
per via di un dialogo tra due personaggi alquanto enimmatici, l'uno dei quali
s'è mosso dall'oriente, l'altro dall'occidente, si miri a staccar gli uomini
dalla terra ed a volgergli alle cose celesti:
Quillo
d'oriente pria - altia l'occlu, sillu spia,
Addemandaulu
tuttabia, - como era, como gia.
«Frate meu, de quillo mundu bengo:
Loco sejo et ibi me combengo.»
Quillu, auditu stu respusu, - cuscì bonu 'd amurus
Dice: «Frate,
sedi josu! - non te paira despectusu;
Ca multu fora
coleiusu - tia fabellare ad usu.
Hodie mai plu
non andare,
Ca te bollo
multu addemandare.»
Ma se qui si
vuol «multu addemandare», di rimanercene a sentire a noi manca il tempo; chè ci
arriva il suono di un altro dialogo assai più animato, tra gente che desta
molto più la nostra curiosità: il trovatore Rambaldo di Vaqueiras - colui che
«Trovò per Beatrice in Monferrato», il compagno d'avventure del prode e
cavalleresco marchese Bonifazio - e una popolana di Genova. Il trovatore prega
d'amore costei nel tuono ch'egli è solito usare colle nobili castellane: ma le
risposte che riceve sono ben diverse da quelle a cui è avvezzo. Ascoltiamo un
momento. Tradurvi il provenzale di Rambaldo avrebbe ad esser superfluo. O
quando mai un uomo innamorato, o che tale si finge, ha saputo dire a una donna
qualcosa di nuovo, che tutti e tutte non conosciate a menadito?
«Donna genta et
eissernida,
Gaia e pros e
conoissens,
Vaillam vostre cauzimens,
Quar jois e jovens vos guida,
Cortezia e
pretz s sens
E totz bos ensenhamens;
Per q'ieus soi fizels amaire
Senes totz retenemens,
Francs, humils e mercejaire;
Tant fort me destreinh em vens
Vostr'amors que m'es plazens!
Per que sera jauzimens
S'eu sui vostre
bevolens
E vostr'amics.»
«Jajar, voi
semegliai mato,
Che cotal razon
tegnei:
Mal vignai e mal audei!
Non avè sen per
un gato:
Perchè trop me descbazei,
Che mala cossa
parei
Nè non faria
tal cossa,
Se sia figlio
de rei.
Credi vo che e'
sia mossa?
Per mia fè, non
m'averei!
Se per amor vo
restei,
Ogano morrè de
frei.
Troppo son de
mala lei
Li provenzal!
E Firenze? -
Oh, anche la voce di Firenze ci arriva presto. E qual voce! «M. cc xi. Aldobrandino, Petro e Buonessegnia
Falkoni no dino dare katunu in tuto libre. lij. per livre diciotto d'imperiali
mezani, arrazione di trenta e cinque meno terza, ke demmo loro tredici di anzi
kalende luglio, e dino pagare tredici di anzi kalende luglio: se più stanno, a
.iiij. denari libre il mese, quando fusse nostra volontade.» Sicuro: il più
antico testo fiorentino è finora il frammento di un registro di non sappiamo
quali prestatori o banchieri, che vediamo esercitare il mestiere loro, oltrechè
in Firenze, a Bologna, per la fiera di San Procolo, o come qui si dice, «San
Brocoli.» Come si vede, si prelude assai bene alla condizione di cose per cui
più tardi tante mogli fiorentine «Eran
per la Francia nel letto diserte», ma
in pari tempo la città cresceva a meravigliosa ricchezza. Che se di lontano
s'ode altresì lo scroscio della fragorosa rovina del Peruzzi e dei Bardi, di
sotto a quella rovina la prosperità di Firenze riuscirà bene a sollevarsi.
Non seguitiamo più
oltre la rassegna. Era opportuno tender l'orecchio ai passi mattinieri che
rompevano il silenzio della notte ed annunziavano il giorno; ma ora l'oriente
s'imporpora, la vita si ridesta, il rumore si fa assordante ed altro ci
vorrebbe per badare ad ogni cosa. L'Italia tutta man mano si leva in piedi;
ogni volgare, poco o tanto, o bene o male, o in verso o in prosa, si vien
cimentando. Una folla di gente, sconosciuta per la massima parte, ma tra cui si
riesce anche a coglier dei nomi - quel Cielo da non so che, stato fino a ieri
Ciullo d'Alcamo, Patecchio da Cremona, Uguccione da Lodi, Pietro di Bescapè,
fra Bonvicino dalla Riva, fra Giacomino da Verona, il veneziano fra Paolino,
Ristoro d'Arezzo - ci si stringe dintorno e minaccia di soffocarci. Ciascuno fa
ressa, presentando scritture romane, umbre, toscane, venete, lombarde, liguri,
e che altro so io: svariatamente insomma dialettali, come in generale sono
stati dialettali i pochi saggi avuti finora.
Sta bene: i
dialetti dunque si vengono scrivendo ogni giorno più. Ma noi non ci si contenta
di sapere di loro: si vuol anche saper della lingua. - Per giungere ad essa la
strada da percorrere era più lunga ed ardua d'assai. La lingua, signori miei, è
un ideale; e quanto sia faticosa per l'uomo la ricerca di un ideale, tutti più
o meno sappiamo per prova. E anche la semplice rappresentazione delle cose
riesce tutt'altro che agevole. Come non avrebbe ad essere difficile render
conto della lingua al secolo XIII, se, dopo settecento anni di letteratura,
ancora non siam ben d'accordo cosa questa lingua abbia ad essere?
Cominciamo dal
determinar bene la questione. Dicendo lingua
per contrapposto ai dialetti, noi
intendiamo l'universale di fronte al particolare; l'unità di contro alla
moltiplicità; in termini più chiari, una forma di linguaggio che si adotti per
gli usi del parlar colto e dello scrivere dagli abitatori di tutta una regione,
rinunziando per cotali usi alla svariatezza delle proprie favelle domestiche.
Orbene:
nell'Italia del medioevo un ufficio siffatto continuò per gran tempo ad
adempierlo il latino, e il latino soltanto. Volete avere un'idea delle
condizioni di allora? Ve la possono dare facilmente le condizioni nostre
stesse. Supponete l'Italia molto più ignorante che ora non sia, e quindi,
facendo astrazione dalla Toscana, mettete il latino al posto dell'italiano. Era
esso il linguaggio dei libri, delle scuole, delle occasioni solenni; esso il
linguaggio che ravvicinava e accomunava da un capo all'altro dell'Italia, per
non guardar fuori di casa nostra, i nativi di qualsivoglia provincia. Ma poi
bisognava bene che si avesse sentore anche di un'unità di favella differente da
questa. Le parlate, varie quanto si vogliano, avevano pur sempre, nella massima
parte almeno della penisola colla Sicilia per giunta, un'affinità così stretta,
da sentirsi membri di una stessa famiglia. Era l'unità del genere, o della
specie; quell'unità che vi fa comprendere sotto la comune designazione di uomo
individui tanto differenti tra di loro. Così l'unità del linguaggio esiste come
a dire in ispirito, prima di essersi potuta tradurre in atto.
Ma di cotale
unità non s'ha meramente il sentore: si prova il bisogno. Di un linguaggio che
non sia già proprio di questa o quella città, ma che possa dirsi comune, ogni
paese che la natura o la storia abbian foggiato veramente in un tutto, prova
vivissima la necessità. Ora, se a questa necessità provvedeva abbastanza il
latino finchè l'Italia sonnecchiava o alle funzioni più elevate della vita
partecipavano relativamente pochi, così non era più, una volta che la vita
s'era fatta ben altrimenti intensa, con carattere schiettamente laico ed
essenzialmente democratico.
Tutto ciò in un
ordine astratto e mai definibile. Concretamente, s'ha il gran rimescolio
prodotto dai commerci, dalle istituzioni religiose, civili e scientifiche,
dalle leghe, dalle guerre, dalle paci. I frati che lontano dalla loro patria si
trovano a predicare a popolazioni cui sarebbe vano rivolgere la parola in
latino, i pellegrini che accorrono alla tomba degli Apostoli e ad altri
Santuari, la moltitudine raccolta insieme alle fiere, i podestà che con un loro
seguito vanno ad esercitare fuor di casa l'ufficio di supremi reggitori, la
folla dei giovani che trae da ogni parte alla dotta Bologna e ivi s'affratella,
son tanti fattori di ravvicinamento tra le varie parlate, le quali imparano
così a conoscersi a vicenda e acquistano scambievole familiarità. E i canti che
anche allora probabilmente erravano da questa a quella provincia, e i proverbi
che erravan del pari, gli uni e gli altri subendo bensì nel loro vagabondare
una trasformazione, ma una trasformazione imperfetta, portavano all'opera che
si veniva compiendo un contributo tutt'altro che disprezzabile. E un contributo
stragrande veniva a portarlo il latino stesso, in quanto dappertutto il
volgare, nella bocca, e più assai poi sotto la penna della gente più o meno
colta, tendeva a tenerglisi stretto a' panni. Ne seguivano convenienze senza
bisogno d'accordo: a quel modo che anche oggi il milanese e il bergamasco di
chi ha la familiarità coll'italiano, si assomigliano maggiormente che il
milanese e il bergamasco del popolo rozzo.
Questi non son
che bagliori; bagliori, che rendono lo nostre antiche scritture dialettali
assai meno dissimili di quel che sarebbero se fossero specchio ben fedele delle
singole parlate. Ma di bagliori noi non ci si contenta: vogliamo arrivare a
veder la luce. E la luce, per uno spiraglio, cominciò a penetrare ancor essa di
buon'ora. La scuola poetica, che si suole dir sicula, ma che abbraccia gente di
ogni nostra regione, fu la prima manifestazione letteraria comune a tutta
Italia. Ebbene: stretti com'erano gli uni e gli altri dal pensiero e dall'arte,
imitatori degli stessi modelli provenzali, raggruppati dattorno a una medesima
corte, cui appartenevano o guardavano, quei poeti ebbero ad avvicinarsi molto
tra di loro anche nell'espressione. Quindi, non una piena uniformità, ma una
minore difformità che non s'avesse fuori di lui. Cosa incomparabilmente più
facile da conseguirsi, in quanto, non solo tutti poetavano unicamente d'amore,
ma poetavano movendosi in una cerchia di idee convenzionali singolarmente
angusta.
Così
l'apparenza di un linguaggio letterario comune incominciò ad aversi; e
quell'apparenza potè ancora per un certo tempo sembrare realtà, e realtà da
appagarsene pienamente, nientemeno che a Dante. Ma egli s'ingannava; e il
massimo sfatatore delle sue proprie convinzioni aveva ad essere lui stesso.
Al rigoglio
meraviglioso di vita civile, politica, economica che nel secolo XIII prese ad
agitare la Toscana, cominciò a corrispondere un rigoglio non meno meraviglioso
anche in fatto di arte. E l'arte della parola ebbe ancor essa cultori in gran
numero. Alle cause generali del fenomeno, s'aggiungeva questa: che la Toscana
capiva di avere nel suo linguaggio uno strumento ben opportuno del pensiero; e
a ragione davvero, dacchè nessuna parlata italiana possiede un'egual somma di
pregi esteriori ed intrinseci. Di questa coscienza può esserci indizio
quell'arido frammento di un libro fiorentino di banco di cui v'ho letto qualche
linea. Già nel 1211 - anzi, già qualche decennio più addietro, a dir poco,
dacchè è troppo chiaro che il fatto non principia di lì - Firenze osava
bravamente servirsi del suo volgare per usi che hanno pure un carattere pubblico.
E a questa coscienza di forze corrispondeva altrove una coscienza di debolezza.
In quasi tutta l'Italia settentrionale, vale a dire nella regione che per molti
rispetti non aveva nulla di certo da invidiare alla Toscana, i dialetti si
sentivano poco italiani - poco latini pertanto - e, vergognandosene in certo
modo, si sforzavano nelle scritture di conseguire coll'artifizio ciò che la
natura aveva loro tolto, e si venivano così ad accostare al tipo di cui le
parlate toscane erano l'esemplare più puro, e geograficamente il più prossimo a
loro. Il più prossimo ed ecco qui uscir fuori una ragione molto importante
ancor essa. La situazione centrale tornava essa pure di grandissimo vantaggio
per la Toscana, e la rendeva più atta d'ogni altra provincia a esercitar
l'impero su tutta la penisola.
La Toscana
aveva dunque già molto in suo favore, e già tendeva ad arrogarsi il predominio
ed a vederlo accettato, quando apparve la gran figura di Dante. Questi cominciò
dall'essere, nonchè uomo del tempo suo, uomo oso dir del passato. Scrivendo la Vita Nuova, - intorno al 1292, - egli
non si perita di riprovare coloro «che rimano sopra altra materia che amorosa.»
Il povero volgare, in cambio di poter spaziare libero dovunque, dovrebbe
contentarsi di starsene chiuso dentro un recinto. Ma le mura di quel recinto
non tardarono ad esser scavalcate anche dallo stesso Dante, che però, quando
appresso, al principio dell'esilio, si dette a comporre il De vulgari eloquentia, segnò confini d'assai più vasti. Nè qui egli
si fermò. Pochi anni più tardi, mosso tra l'altre cose da un santo sdegno
contro i «malvagi uomini d'Italia che commendano lo volgare altrui» - il
provenzale e il francese - » e lo proprio dispregiano», si servirà nel Convivio del volgare nostro per trattare
le più astruse e sottili quistioni scientifiche; e a proposito di questo
volgare proromperà, al termine di una lunga difesa o panegirico, in quelle
parole fatidiche: «Questo sarà luce nuova, sole nuovo, il quale sorgerà ove
l'usato tramonterà, e darà luce a coloro che sono in tenebre e in oscurità per
lo usato sole che a loro non luce.» Il sole di cui si presagisce il tramonto è
il latino. Come si vede, il nuovo linguaggio ha acquistato piena coscienza di
sè. La fanciulla che finora se n'era stata timida in gonnelle corte accanto
alla madre, s'è accorta che quelle gonnelle non fanno più per lei, e si rifiuta
di portarle più a lungo. La madre continuerà ad essere circondata di affetto e
venerazione; ma si rassegni ad esser matrona, e non presuma più di adempiere
lei le parti giovanili.
Che la
predizione del Convivio si avverasse
prontamente, fu opera dello stesso Dante, il quale giusto allora veniva
innalzando uno dei monumenti più portentosi dell'arte e del pensiero umano: la Divina Commedia. Questa, imponendosi
d'un tratto all'ammirazione universale degl'italiani, decise, senza possibilità
di opposizioni efficaci, la questione della lingua. Ed essa veniva col fatto a
risolverla in favore del toscano non solo, ma proprio del fiorentino,
sbaragliando e dissipando, checchè Dante potesse forse ancora addurre in loro
difesa, le teoriche artifiziose e le troppo sottili distinzioni del De vulgari eloquentia. Ho detto che la
lingua è un ideale. La ricerca dell'ideale aveva stavolta quel più lieto fine
che possa mai avere nella vita. Si rinunziava a cercare più oltre, per stendere
le braccia ad una fanciulla sfolgoreggiante di salute e leggiadria, che, se non
era l'ideale, era più e meglio di esso. Certo ci vollero ancora due secoli
perchè la decisione voluta dalla Commedia
avesse pieno effetto; nè cessarono mai del tutto le resistenze, parte
irragionevoli e meschine, ma parte anche ragionevolissime, e tali da dover
dissuadere noi pure dell'acquetarci nella formola troppo angusta che alcuni -
sia pure autorevolissimi - propugnano. Ma, considerando bene, tutto ciò
riguarda semplici particolari. Quanto alla sostanza, nessun dubbio che la
lingua letteraria dell'Italia non sia stata, non sia, e non voglia quanto mai
desiderarsi che abbia ad essere anche in futuro, la favella di Firenze.
Abbia ad
essere: poichè importa moltissimo che il nostro linguaggio non perda il
privilegio invidiabile di poter attingere alle fonti vive del parlar popolare;
e importa altrettanto che queste fonti siano quelle medesime da cui esso sgorgò
e di dove attinse in passato. Solo così il linguaggio potrà mantenersi
durevolmente limpido e fresco. Ora, un certo qual pericolo sovrasta. L'Italia
s'è ricomposta, ha conseguito una capitale, e quella capitale non è, nè poteva
esser Firenze. Essa è invece la città su cui s'impernia tutta la vita italiana:
come s'è visto, insieme colla vita politica, colla civile, colla religiosa,
anche la vita linguistica. C'è luogo quindi a temere che il centro di gravità
tenda a spostarsi. Contro un pericolo siffatto non vedo quale altro rimedio
possa esserci all'infuori di un fervore di vita intellettuale, che mantenga a
Firenze, così mirabilmente disposta dalla natura e dalla storia, il carattere
di Atene italiana. A quest'opera, sommamente salutare e benefica, non solo per
la patria piccina, ma anche per la grande, tutti possono efficacemente
contribuire. Contribuisca anzitutto ciascuno col coltivare la mente sua
propria. E cooperatrice efficacissima, anzi indispensabile senz'altro, è a dire
la donna. Chè, ivi non è coltura durevole e schietta, dove la donna non è
colta; la donna, prima educatrice delle nuove generazioni; stimolatrice insieme
e riposo dell'ingegno umano; allettamento e anima di quei ritrovi, per opera
dei quali il pensiero e la parola - ce lo dica la Francia del passato - possono
meglio che con qualsivoglia altro mezzo ingentilirsi e affinarsi. Ma badi bene
la coltura di non lasciarsi salire in groppa quella odiosa strega che è la
pedanteria. Se questo avesse a seguire, bisognerebbe correre a sbarrare le
strade e chiudere il passo anche a lei. Meglio allora sempre per la donna
rimanersene coi pregi che si trova aver da natura.
APPENDICE.
Sarà, credo,
opportuno, ch'io non lasci vagare stampata questa mia conferenza, senza dire
aperto cosa pensi di certe opinioni messe fuori di recente, alle quali vedo
farsi un'accoglienza, che non avrei immaginato quando parlavo al pubblico della
sala Ginori.
Nel 1884,
quell'insigne romanista che è Ernesto Monaci, sostenne, in un articolo
ingegnoso pubblicato nella Nuova
Antologia (15 agosto), che il vero focolare della nostra prima scuola
poetica, fosse, nonostante il nome consacrato dall'uso già ai tempi di Dante,
Bologna, non la Sicilia. Ivi si sarebbe primamente fissata anche la nostra
lingua letteraria. Alcuni anni appresso il prof. Augusto Gaudenzi - uno
studioso che dalla sua rocca della storia del diritto può, bene armato e
arredato, far proficue scorrerie in altri dominii - prima in una rivista (L'Università, iii, 204 seg.), poi
soprattutto in un libro (I suoni, le
forme e le parole dell'odierno dialetto della città di Bologna, Torino,
Loescher, 1889), riprese la seconda parte dell'idea del Monaci, determinandola
in modo considerevolmente diverso; e alla teorica mise per fondamento dati suoi
proprii, e antiche scritture, di cui egli stesso era stato ritrovatore sagace.
Stando a lui, la lingua letteraria avrebbe la sua culla nelle scuole di arte
notarile dell'Università bolognese.
Non è senza
meraviglia che alle deduzioni del Gaudenzi ho visto assentire, dando conto del
libro, due cultori valentissimi degli studi linguistici: il Salvioni (Giornale storico della letteratura italiana,
xvi, 378) e il Meyer-Lübke (Literaturblatt
für germanische und romanische
Philologie, xii, 25). Almeno, che il Meyer-Lübke assenta, mi par chiaro da
certe frasi e dalla mancanza di ogni obbiezione; quanto al Salvioni, il suo
assenso è esplicito, con certi allontanamenti tuttavia. Mentre cioè per il
Gaudenzi la lingua prevalsa a Bologna fu la toscana, per il Salvioni invece,
più ragionevolmente di certo, era un contemperamento delle varie parlate
italiane. Con ciò egli ritorna all'idea primitiva del Monaci; ma non si perita
di dire che il Gaudenzi «dimostra il fatto in modo ben più sicuro.»
Ora, dove stia
codesta dimostrazione, per mia parte confesso proprio di non capire. Se i testi
del Gaudenzi sono assai notevoli e se è da essere riconoscentissimi a chi ce li
ha dati, i ragionamenti che muovono da essi si trascinano innanzi a fatica di
congettura in congettura e non reggono a un esame, per poco attento che sia.
Bologna, gran fucina di coltura, ha di certo anche nella storia della nostra
lingua un'importanza ragguardevole; ma ridurre dentro di essa soltanto la
formazione del volgare illustre, è un rimpicciolire il problema; quanto poi al
metterne per l'appunto la nascita nelle scuole di notariato è un immiserire le
cose in modo addirittura compassionevole. Nè si capisce che si dia tanto peso a
Guido Fava, che, se fu bolognese, scrisse la maggior sua opera in Toscana, e
non si pensi a Buoncompagno, che, toscanissimo e insegnando lettere a Bologna,
tra tante sue opere non ce ne lasciò nessuna in volgare. Ai documenti del
Guadenzi basterebbe contrapporne due soli: da un lato l'iscrizione di Ferrara,
che molto tempo prima ci dà esempio di un volgare scritto che non è davvero il
ferrarese, pur contenendo elementi dialettali, ed uno emiliano caratteristico;
dall'altro, i frammenti fiorentini del 1211, di cui s'è vista la portata
cronologica. E dov'è la ricca fioritura di carte volgari, di cui, se la teoria
del Gaudenzi fosse vera, noi avremo bene diritto di far domanda, soprattutto
alla sua Bologna? Se il volgare deve per solito servire ai notai solo per le
spiegazioni verbali alle parti contraenti, non sappiam davvero che importanza
abbia da avere questo ordine di fatti per la fissazione della lingua scritta.
Ben altro ci
sarebbe a dire; ma rimetto l'esposizione a miglior tempo. Intanto mi basta di
aver levato la voce per mettere in guardia contro di ciò che a me pare un
errore non meno grave che nuovo.
LE ORIGINI
DELLA LETTERATURA ITALIANA
DI
Adolfo Bartoli
Non congiunti
più da nessuna affinità psicologica al Medioevo, riesce difficile a noi sentire
quello che fosse, nei suoi aspetti bizzarri e multiformi, l'età delle febbri
ascetiche e degli entusiasmi cavallereschi, dei barbari e dei santi, dei
feudatari e dei servi, delle crociate e dei tornei; quella lunga e lugubre età
nella quale il pensiero umano sembra vicino al suo ultimo disfacimento, e che è
pure l'ingenuo tempo dei sogni e delle fole. Se una caratteristica possiamo
cogliere in quel caotico agitarsi di elementi tanto diversi, questa sola sarà,
che una puerilità universale ha invase le menti, che gli uomini sono divenuti
fanciulli. La ragione sembra essersi coperta del lenzuolo funebre, per
discendere nel sepolcro, dove dormirà molti secoli. I suoi radianti fulgori
sono spenti. Il mondo colle sue gioie, la natura colle sue bellezze non parlano
più al cuore degli uomini; le più alte aspirazioni dello spirito sono giudicate
un peccato; il cielo incombe sulla terra, e nell'immane abbraccio la soffoca.
Si è perduto quasi il concetto della successione dei tempi: ai funerali di
Alessandro il Macedone si fanno assistere i frati colle croci e i turiboli;
Catilina sente la messa a Fiesole; Orfeo è un contemporaneo di Enea,
Sardanapalo un re della Grecia, Giuliano l'Apostata un cappellano del papa.
Tutto in quel mondo prende un colorito fantastico. Gli uomini dell'antichità
come i contemporanei, se appena si sollevino dal livello comune, hanno tosto la
loro leggenda, la loro storia poetica, che la tradizione abbellisce,
ingrandisce, trasforma, e dove s'abbracciano fraternamente gli anacronismi più
grossolani e le più strane invenzioni. Si confonde la storia di San Gregorio
Magno con gli incerti ricordi di Edipo; si crede che il Barbarossa viva
nascosto nel fondo di una foresta, e si aspetta che torni per liberar
Terrasanta; di Virgilio si fa un mago; si narra che papa Gerberto ha stretto un
patto col diavolo.
E pure da una
tale prodigiosa credulità, da questo stato infantile dell'umano intelletto, che
caratterizza il Medioevo, derivarono appunto i frutti della letteratura
romanza. Come proprio dei fanciulli è l'amare tutto ciò che sappia di
meraviglioso; come in essi è prepotente il desiderio dei racconti, tanto più graditi
quanto più uscenti dai limiti del verosimile, così un popolo fatto latino dalla
conquista, ringiovanito poi dal connubio colle fantasiose stirpi germaniche, e
dalla loro antichissima epica eccitato, innestava sull'epopea merovingia
l'epopea nuova, celebrando Clotario e Dagoberto, Carlo Martello e Carlomagno. E
così sulla terra di Francia risuonava il primo cauto romanzo, che poi, traverso
ai secoli, dispiegandosi, come albero rigoglioso ed immenso, in mille e mille
rami, toglieva argomento dalle leggende intorno agli antenati di Carlo, intorno
alla sua giovinezza, alle sue guerre, ai prodi compagni delle sue imprese. Nè
solo dalle leggende Carolingie il trovèro francese attingeva materia pei suoi
canti infiniti. Tutto in quell'epoca di trasformazione, di inconsciente poesia,
di balda giovinezza de' cuori, prendeva un colorito uniforme; tutto era
guardato traverso un velo di fantastico tessuto: la guerra di Troja, come le
imprese di Alessandro Magno; le prodezze di Arturo, come gli amori di Tristano,
come i miracoli di Sant'Eulalia e di Sant'Alessio. Si accoppiava quindi alla
solennità religiosa feudale della canzone di gesta, il cavalleresco romanzo
d'avventura; si intrecciava al canto epico il romanzo allegorico dell'amore
simboleggiato nella Rosa, mentre, quasi araldi dell'avvenire, ghignavano
beffardi il poema della Volpe e il procace Fabliau.
Tutta questa
lussureggiante fioritura romanza sbocciava e si allargava nella Francia
settentrionale e centrale, dal settimo al tredicesimo secolo.
E nella Francia
meridionale intanto più presto che altrove si apriva uno spiracolo di luce nel
buio del Medioevo. Sotto quel limpido cielo, in mezzo a quella inebbriante
natura ed a quelle popolazioni facili ad ogni impressione, avide di piaceri e
di feste, agitate da un forte sentimento della vita; in quelle città
intelligenti e fiere, dove la libertà si sviluppava così nobilmente, dove i
pregiudizi occidentali erano distrutti dalle intime relazioni coi Musulmani e
cogli Ebrei, dove regnavano sovrani lo spirito cavalleresco, l'amor della
gloria, la difesa del debole, il culto per la donna, la liberalità, la
magnificenza, nella Francia meridionale sorgeva un'altra letteratura, che
cantava l'amore, la gioia, la cortesia; che affratellava in una specie di
democrazia poetica il povero al ricco, il vassallo al signore; che univa in
nozze ideali il popolo all'aristocrazia. Il poeta Provenzale, il trovatore, è
sopratutto un artista, un artista lirico, che spesso mette in musica le sue
proprie poesie, e da sè stesso cantandole, si accompagna col suono; che vive
nei castelli dei principi e dei nobili, ne rallegra i conviti e le feste,
riceve doni di cavalli, di bardamenti, di armi, di vesti; si aggira per le sale
sontuose del maniero feudale, sogguardato dalla bella castellana, che sa di
essere amata da lui, e se ne compiace nel suo segreto, ed aspira come un
profumo il suo canto. Fra codesti trovatori ci sono i più potenti baroni della
Provenza, ed insieme paggi, servi, soldati, giovani poveri e avventurosi. C'è
Guglielmo Conte di Poitiers gran corteggiatore di donne, che oggi ama e domani
abbandona; grande scettico che ride dei vescovi, e corre in Terrasanta a capo
di trecentomila crociati; prode soldato che vive d'armi e d'amore, di canto e
di cortesia. C'è Bernardo di Ventadorn, il figliuolo dell'uomo che scaldava il
forno nel castello feudale, che ama prima la moglie del suo signore, e poi in
Normandia la celebre Eleonora di Poitiers, e alla corte di Tolosa una bella
italiana, Giovanna d'Este. C'è Goffredo Rudel che s'innamora, senza averla mai
vista, della contessa di Tripoli, traversa il mare per lei, giunge malato e
muore, muore felice perchè ha potuto per un istante contemplare la bellissima
donna e riceverne un dono. Ci sono cento e cento altri, di questi cavalieri
poeti, di questi guerrieri innamorati, di questi servi ardimentosi, che dal
secolo XI al XIII fanno eccheggiare delle loro canzoni quella terra benedetta
dalla natura.
Che cosa
accadeva frattanto in Italia? Quando già le due letterature della Francia erano
giunte al loro più alto sviluppo, in Italia si continuava a scriver latino.
Sebbene anche qui si parlasse da tempo immemorabile una lingua volgare, questa
lingua che pur serviva alla preghiera e all'amore, che era pure strumento ad
esprimere i più cari ed intimi sentimenti dell'anima, pareva sdegnosa di
assorgere a più elevato ufficio. La lingua della letteratura seguitava ad
essere il latino, non solo nel VII, nell'VIII, nel IX e nel X secolo, ma anche
nell'XI e nel XII.
Le ragioni di
questo fatto sono complesse, ma si possono tutte riassumere in una sola,
nell'influenza esercitata sugli Italiani dal grande nome di Roma. Per essi le
memorie classiche fanno parte della loro vita: ogni città pone la sua gloria
nel ricongiungersi all'antichità; Pisa, Genova, Verona si dicono fondate dai
compagni di Enea: Firenze si crede edificata da Cesare e chiamata la piccola Roma; Padova si vanta di
possedere le ceneri di Antenore; Venezia di essere stata costruita e abbellita
colle pietre, colle colonne, colle vasche avanzate alla distruzione di Troja.
Roma, anche
vinta, soggioga i suoi vincitori. Eruli, Ostrogoti, Longobardi, si succedono,
ma non penetrano la società, non la trasformano: Teodorico invade Roma, ma la
sua reggia resta più romana che gota. Questa fu certo per noi una sventura
politica. Mentre la Gallia rinnovata dai suoi stessi invasori diventava la
Francia, e la Bretagna diventava l'Inghilterra, e l'Iberia la Spagna; noi
soffrimmo tutti i danni delle invasioni, senza che questi fossero compensati
dalla creazione di nessuna forza novella. Se Teodorico o Liutprando fossero
stati il Clovi dell'Italia, chi sa quale diversa condizione si sarebbe
preparata al nostro paese, chi sa quanti dolori, quanti martirii, quante
umiliazioni di meno registrerebbe la nostra storia. Ma così non accadde. Noi
fummo appena spruzzati del sangue barbarico, e rimanemmo Romani: Romani nelle
idee, nei sentimenti, nelle leggi ed anche nella lingua come strumento
letterario. Onde agli Italiani mancò quella infanzia d'intelletto e di cuore
che fu per altre genti latine fonte d'ispirazione poetica. Là l'evoluzione
letteraria si operò nel popolo e per il popolo, e fu spontanea, viva, feconda.
Noi avevamo tutto un glorioso passato che ci gravava le spalle, che ci faceva
esser maturi quando gli altri eran fanciulli, che ci dava i pregi della
virilità, ma ci privava della vivacità infantile. Noi eravamo i continuatori di
una civiltà antica di secoli, non i cominciatori di una civiltà nuova. La
storia imperava tiranna su noi, e poco ci commovevano le prodezze dei paladini
o la rotta di Roncisvalle o le bianche mani d'Isotta. Noi non avevamo, come gli
altri popoli d'Europa, un eroe fantastico, nel quale s'incarnasse idealmente la
nazionalità italiana. I nostri eroi seguitavano sempre ad essere i vecchi Scipioni.
Noi eravamo pratici: le nostre città marittime si arricchivano coi commerci,
nelle nostre Università si studiava il diritto romano, i nostri Comuni
combattevano per la loro libertà: pratici e sempre un po' increduli, sempre con
un po' di paganesimo nelle ossa. Il nostro scetticismo non ci concedeva di
creare leggende, e le leggende degli altri popoli accoglievamo freddamente, non
aggiungendovi nulla di nostro, anzi spogliandole spesso del loro colorito
poetico, riducendole in prosa, ed in prosa latina. Perchè quello che accadeva
per il contenuto, accadeva pure per la forma. La lingua latina non era per gli
Italiani quello che per gli altri popoli, sui quali passò vincitrice l'aquila
romana. Quei nostri padri antichi amavano il latino come loro lingua nazionale:
esso faceva parte del loro sentimento di patria, era un ricordo della gloria
passata, il segnacolo della loro grandezza, il labaro delle memorie e delle
speranze. Gli Italiani del Medioevo scrivendo il latino, potevano illudersi
nella credenza di aver messi in fuga i Barbari; e abbandonare quella lingua che
aveva accompagnati nel loro giro trionfale i conquistatori del mondo, che aveva
risuonato solenne e terribile nel Foro, che aveva servito alle immortali
creazioni di Virgilio, doveva parere come perdere un'altra volta la patria.
Questo tenersi
stretti al latino era poi potentemente favorito in Italia dalla Chiesa, che ne
aveva fatto la sua lingua officiale, e non permetteva intromissione di volgare
nei suoi riti; era favorito dalle magistrature e dagli scrittori. E così la
chiesa, le leggi, la scienza, le condizioni sociali e intellettuali, le memorie
del passato e le aspirazioni del presente, tutto cospirava a ritardare
l'apparizione della nuova letteratura.
Vero è che
quella povera lingua dei poeti, degli storici, degli ascetici, quella miserrima
lingua della liturgia e delle leggi, era piuttosto che un latino, un volgare
latinizzato: vero è che già quasi appartiene alla letteratura italiana il canto
del nono secolo per l'imprigionamento dell'imperatore Lodovico II, e quello dei
soldati modenesi del decimo; e che in latino volgare noi abbiamo una
ricchissima letteratura di poemi, di canti storici, di cronache, d'inni sacri.
Ma, insomma, il volgare schietto, la lingua parlata non osa ancor farsi avanti,
diventare lo strumento dell'arte nuova. Siamo già alla fine del dodicesimo
secolo, e nulla ancora apparisce.
Però, i semi si
vanno gettando. Le due letterature della Francia saranno quelle che
determineranno il primo sviluppo della letteratura italiana. Prima di
arrischiarsi al loro volgare, gli Italiani scriveranno in provenzale e in
francese.
Numerosi legami
unirono già anticamente la Gallia meridionale all'Italia, e come l'Italia diede
alla Provenza le sue istituzioni politiche, così questa ci mandò un alito della
sua poesia. Molti furono i trovatori che nel secolo XII e nel successivo
vennero in Italia, aggirandosi per le corti feudali dei marchesi di Monferrato,
dei Malaspina, degli Estensi; visitando la Lombardia, la Marca Trevigiana,
Como, Verona, Firenze. Il Monferrato divenne una seconda Provenza. I trovatori
più famosi visitarono quella corte. Pier Vidal, dopo aver percorsa la
Catalogna, l'Aragona, la Castiglia, dopo avere sposata a Cipro una greca ed
avere sperato di assidersi sul trono imperiale di Costantinopoli, arrivava nel
Monferrato, ed ivi scriveva verso il 1195 una poesia, dove palpita un certo
sentimento di nazionalità italiana. Press'a poco nel tempo stesso si avviava
verso l'Italia un altro celebre trovatore, figliuolo di un povero cavaliere
della Contea di Orange, Rambaldo di Vaqueiras. Fermatosi a Genova, s'abbatteva
in una donna, e la richiedeva di amore, ma ne era respinto, e componeva intorno
a ciò una canzone bilingue, che può considerarsi come uno dei documenti più
antichi dove rimanga vestigio di un dialetto italiano: ve ne lesse due strofe
il professor Rajna parlandovi delle origini della lingua italiana. - Rambaldo,
proseguendo il suo viaggio, giungeva appresso alla corte di Monferrato, dove lo
attendeva la protezione del marchese Bonifazio e l'amore della sua avvenente
sorella Beatrice, ch'egli cantava in molte poesie, sotto il nome di Bel Cavaliere, avendola una volta
furtivamente veduta esercitarsi colle armi del fratello.
Spuntò per le
Provenza un giorno terribile. Serpeggiava là una di quelle eresie medievali,
che volevan ridurre gli uomini allo stato di angeli. Se ne indignarono i
difensori dell'ortodossia papale che aspiravano ad essere i padroni delle
coscienze; e contro i poveri Albigesi fu bandita da Innocenzo III una crociata,
alla quale accorsero migliaia di avventurieri che avean tutto da guadagnare e
niente da perdere. Costoro, a cui il papa concedeva perdoni, indulgenze, e, più
appetitoso premio, l'affrancazione dai debiti, costoro che intravvedevano i
ricchi castelli da saccheggiare con tutto quello che tien dietro al saccheggio,
si rovesciarono sulla Provenza come torrente devastatore. In una sola città si
scannarono più di sessantamila persone, vecchi e giovani, uomini e donne,
persino bambini lattanti. Questi sgozzatori domandavano al Legato del Papa come
potessero distinguere i fedeli dagli eretici, e costui rispondeva: ammazzateli
tutti, che saprà dopo distinguerli Dio. Si trucidava dappertutto, nelle case,
per le vie, anche sui gradini degli altari. Tutta la Provenza fu inondata di
sangue, e su quella terra insanguinata divamparono le tetre fiamme dei roghi
che l'Inquisizione accendeva.
I lieti cantori
dell'amore, atterriti, fuggivano, e molti di essi prendevano la strada
d'Italia, dove si stabilivano come in patria novella. Se prima essi accorrevano
alle nostre terre in cerca di fortuna e di amore, dopo la nefanda strage
venivano frementi d'ira a cercar la vendetta, e sperandolo vendicatore, si
affollavano intorno a Federigo II, tanto in Sicilia come negli altri luoghi
dove egli teneva sua corte.
Ai Provenzali
poi, che empivano dei loro canti d'amore o di sdegno l'Italia, si
accompagnavano non pochi italiani che scrivevano poesie provenzali. Alberto
Malaspina non solo accoglieva i poeti occitanici nei suoi castelli di Lunigiana
e del Tortonese, ma egli stesso tenzonava con altri trovatori. Maestro Ferrari
da Ferrara rallegrava dei suoi versi la corte Estense e quella di Gherardo da
Cimino. Lanfranco Cigala di Genova in una fiera serventese rampognava il marchese
Bonifazio di Monferrato della sua instabilità politica; un altro genovese, il
Calvo, gridava contro le discordie della sua patria; un veneziano, Bartolomeo
Zorzi, difendeva contro Genova la sua Venezia; un piemontese, Nicoletto da
Torino, celebrava le imprese di Federigo II; un altro piemontese, Pier della
Carovana, esortava alla concordia le città strettesi nella seconda lega
Lombarda; un mantovano, Sordello, dopo avere rapita al marito Cunizza, la
sorella del terribile Ezzelino, dopo aver corse mille avventure d'amore,
assorgeva ai più alti argomenti politici, faceva sentire la sua libera parola
ai principi e ai popoli.
In tal guisa
l'Italia tutta risuonava della poesia occitanica, la quale imponeva la propria
lingua ai poeti dei paesi dove essa si stabiliva; in tal guisa trovatori della
Provenza e trovatori italiani, si mescolavano nelle nostre corti, cantavano le
nostre donne, i fatti della nostra storia, le imprese dei nostri principi. Ed
al tempo stesso faceva sentire la sua influenza tra noi anche la poesia della
Francia settentrionale; onde, come ci furono Italiani che scrissero in
provenzale, così ci furono pure altri Italiani che scrissero in una lingua che
è un francese italianizzato.
Il canto
provenzale diede impulso alla nostra lirica; il canto francese alla poesia
narrativa e morale. La prima si sviluppò nell'Italia del mezzogiorno e del
centro; la seconda, nell'Italia settentrionale.
La più antica
lirica italiana è quella, che, sorta circa nel secondo o terzo decennio del
secolo tredicesimo, si chiamò della scuola Siciliana, perchè ebbe il suo
focolare alla corte di Federigo II; e di essa fecero parte non Siciliani soli,
ma anche Pugliesi e Toscani: i più famosi, lo stesso imperatore Federigo, Enzo
suo figlio e Pier della Vigna suo ministro.
Federigo II fu,
giova qui ricordarsene, una delle più grandi figure storiche del suo secolo.
Egli promosse la scienza, protesse i dotti, difese la libertà dei culti,
emancipò i servi, fondò biblioteche ed università. Questo imperatore che viveva
di guerra, di amore e di scienza, mezzo orientale e mezzo romano, chi
crederebbe non dovesse portare nella poesia tutto l'impeto delle sue passioni?
Chi non crederebbe che, pure ispirandosi ai canti dei trovatori, non dovesse
preferir quelli nei quali bolliva lo sdegno contro il suo terribile nemico, il
papato? E chi non crederebbe ancora che Pier della Vigna, autore di versi
latini ferventi d'ira contro i frati, non facesse sentire nei suoi versi
volgari qualche cosa delle passioni che gli agitavano il petto? qualche cosa
delle vicende a cui si trovò mescolato?
Eppure niente
di questo. Federigo II come il suo ministro, come tutti gli altri rimatori
della sua scuola, non furono che languidi imitatori della poesia amorosa dei
Provenzali, e al pari di tutti gli imitatori, riuscirono peggiori dei loro
modelli. Misera cosa, invero, quella nostra antichissima poesia, scarna,
estenuata, gelida, anemica. Nessun impeto di passione l'agita mai, niun accento
individuale vi si può cogliere. Tutte quelle migliaia e migliaia di rime somiglian
tra loro, paiono una processione interminabile di pallide ombre che ci sfili
davanti nel crepuscolo d'una giornata nebbiosa. La vita, la natura, l'amore,
non danno mai un sussulto di verità a quei verseggiatori noiosi e monotoni, che
spogliati di ogni personalità, scrivono tutti secondo un tipo comune, girano e
rigirano intorno all'eterno tema dell'amore con giuochi di parole e di
concetto, e con un frasario puramente di convenzione; sbadigliano i loro
sospiri a donne che non son donne ma larve; e paurosi di ogni libero volo, si
tengono strettamente afferrati ai loro modelli, come vacillanti bambini alla
gonna materna. L'arte della scuola Sicula è, come ha detto un moderno, il
balbettare infantile della decrepitezza; e non poteva essere che così. Lo
spirito cavalleresco onde era sbocciata, come fiore a pomposi colori, la poesia
provenzale, agonizzava oramai in tutta l'Europa; la stessa arte trovadorica era
giunta a un periodo di estrema decadenza. La scuola Sicula al difetto
dell'imitazione aggiungeva dunque quello di essere un frutto fuor di stagione,
venuto troppo tardi e avvizzito prima di maturare.
Ma la spinta
era data. Se Federigo e i poeti della sua corte amano di trastullarsi
fabbricando stentatamente le stanze delle loro canzoni dietro le orme dei
Provenzali, altri in quella stessa Sicilia risuonante di quel vaniloquio
poetico, porge l'orecchio alla natura immortale, e compone versi d'amore
vigorosamente sentito. La donna sbiadita, incorporea, insignificante dei
rimatori della scuola cortigiana, si muterà così in una donna nelle cui vene
corre vivido il sangue, sulle cui guancie brillano accesi i colori della
salute. La povera castellana venuta di Provenza in Sicilia a morir d'etisia,
cederà il posto alla donna del popolo non aduggiata dalle ombre crepuscolari di
nessuna scuola, ma cresciuta sotto gli allegri e liberi raggi del sole,
pioventi su lei gioventù e robustezza: un po' troppo veramente plebea e
petulante, che non ha imparato certe raffinatezze e certe ipocrisie
dell'educazione; ma che si presenta sulla scena dell'arte italiana come la
prima che abbia fisonomia, atteggiamenti, parole, non presi in prestito da
nessuno.
Di un'arte
popolare sviluppantesi nel mezzogiorno d'Italia insieme all'arte cortigiana, ci
restano varii documenti: il lamento di una donna che vede partire l'amante per
Terrasanta, il pianto di una fanciulla abbandonata, e, più notabile degli
altri, un contrasto tra un uomo e una donna, dove scattano parole e concetti
molto vivaci, dove parla una passione irruente, senza sottintesi, senza mezzi
termini, e che prova non essere il realismo
un'invenzione del nostro secolo. Chi sia l'autore di questa poesia non
sappiamo. I critici che si sono occupati di storia letteraria lo hanno chiamato
ora Ciullo d'Alcamo ora Cielo dal Camo, e ci hanno scritto intorno pagine e
pagine senza fine. Non sono molti anni che ci fu in Italia una vera alluvione
di queste Ciullomachie. Ma l'alluvione per fortuna è passata, e la poesia
resta: una poesia fresca di sentimento, rude nel suo contenuto e nella sua
forma dialettale, che non ha grande importanza per sè stessa, ma che ci prova
come accanto alla poesia artistica d'imitazione straniera, un'altra ne sorgesse
indigena e originale, la quale s'ispirava alla realtà ed era eco del sentimento
popolare.
Se nel centro
d'Italia e nel mezzogiorno la nostra letteratura s'iniziò con poesie amorose,
diversi affatto furono gli atteggiamenti presi dall'arte nascente nella parte
settentrionale del nostro paese. Neppur là, invero, dovevano mancare i canti
d'amore, e qualche povero avanzo ne è giunto fino a noi. Ma son poca cosa, e
più triviale anche del contrasto Alcamese, tanto triviale che non sarebbe
lecito a me dirvene neppur gli argomenti. Nel nord dell'Italia la più antica
poesia preferì il genere civile, morale, religioso, didattico: non fu lirica,
ma narrativa. Nella regione veneta si ebbe come uno strascico delle canzoni di
gesta francesi; e si imitò l'epopea della Volpe; Girardo Patecchio di Cremona
scrisse (non oso dire poetò) sulle noie della vita e sui proverbi di Salomone;
Ugoccione da Lodi diede ammaestramenti religiosi e morali in un poemetto
d'oltre, pur troppo! duemila versi; un altro poemetto compose Pietro da
Barsegapè sul vecchio e nuovo Testamento; Giacomino da Verona descrisse
l'Inferno e il Paradiso; Bonvesin da Riva scrisse molte poesie di generi
diversi.
Giacomino e
Buonvicino furono i maggiori di questi poeti settentrionali, che adoperarono
una lingua avente a base i dialetti veneti, ma forbiti con intenzione
letteraria.
I due poemetti
di Giacomino da Verona, frate dell'ordine di San Francesco, furono certamente
scritti per essere recitati al popolo, a quel popolo stesso che tanto si
piaceva delle storie romanzesche, e che pendeva dalle labbra del giullare
quando gli cantava le imprese di Oliviero e di Rolando.
Il suo
paradiso, o com'egli la chiama, la Gerusalemme
celeste, ha merli di cristallo, corridoi d'oro, porte di margherite, e alla
sua guardia sta un cherubino colla spada di fuoco. Per mezzo alla divina città
corre un bel fiume, le cui acque danno giovinezza eterna, sulle cui rive
verdeggiano alberi dalle foglie d'oro e d'argento, e crescono fiori ch'empiono
di dolce profumo tutto il paradiso.
Magra
descrizione; ma come poteva essere altrimenti? Dove trovare i mezzi per
rappresentare ciò che trascende la natura e il pensiero? Lo stesso più grande
artista non ha a sua disposizione altri colori che quelli della terra: e
Giacomino, poveretto! era tutt'altro che un grande artista.
Più viva è la
pittura ch'egli fa dell'Inferno: una città di fuoco e di zolfo bollente, con
acque amare e velenose, con ortiche e spine, coperta da un cielo di bronzo,
nella quale se fosse gettata tutta l'acqua del mare, incontanente arderebbe
come cera colata. Il re della dolente città si chiama Lucifero, e i demoni sono
da Giacomino dipinti in quella forma che se li figurava la fantasia del popolo,
con le corna, con le mani pelose, neri come il carbone. Egli li fa urlar come
lupi, abbaiar come cani, li arma di lance, di forche, di bastoni, di tizzoni
accesi. Chi attizza il fuoco, chi batte il ferro, chi strugge il bronzo, chi
spezza le ossa ai dannati; i quali poi colle mani e coi piedi legati sono
condotti innanzi al re della morte, e gittati quindi in un pozzo profondo,
ond'esce un fetore che ammorba tutto l'inferno. Ed accanto alla tragedia anche
un po' di commedia. Ad un dannato capita addosso uno dei cuochi di Lucifero;
ghermitolo, lo mette ad arrostire infilato in uno spiedo, e lo condisce con
acqua, sale, fiele, aceto e veleno, servendolo poi come ghiotto boccone al
signor dell'Inferno, il quale lo trova mal cotto e lo rimanda al cuoco perchè
lo arrostisca meglio in quel fuoco che arde eternamente.
Tragedia e
commedia insieme, dicevo, che nelle povere turbe intente ad ascoltare quei
canti, avranno un giorno suscitato brividi di terrore e convulsioni di risa; e
che a noi oggi fanno tristamente pensare quanto in basso fosse caduto il
pensiero, e quanto faticoso cammino abbia dovuto fare la civiltà per giungere a
redimere gli uomini da questa morbosa condizione del loro spirito.
Il milanese
Buonvicino, anch'egli frate, di quell'ordine degli Umiliati la cui storia si
collega così strettamente con l'Arte della Lana, una delle glorie di Firenze,
Buonvicino ci ha lasciato molte poesie, alcune di argomento leggendario, altre
di argomento morale, come i contrasti tra la rosa e la viola, tra la mosca e la
formica e tra i dodici mesi dell'anno; ed una finalmente di genere civile, le
cinquanta cortesie della tavola. Fu già osservato non essere senza curiosità il
vedere questo frate, che fu maestro di grammatica, autore di una cronaca della
sua città e poeta religioso, farsi anche maestro di costumanze civili.
Volete voi
sentire qualche precetto di quel galateo del secolo XIII, qualcheduna di queste
curiosità del banchetto, vecchie di quasi settecent'anni? Se sei invitato a
pranzo, dice Buonvicino, non correr troppo presto a prendere il tuo posto a
tavola; e poi sta pulitamente al desco, cortese, adorno, allegro; non
incrociare le gambe, non appoggiare i gomiti, non mangiare troppo nè troppo
poco, nè con fretta eccessiva; non empirti soverchiamente la bocca. Se ti vien
offerta la coppa per bere, prendila con due mani per non versare il vino. Se
mentre sei a tavola sopravviene qualcheduno, guardati dall'alzarti. Cerca
mangiando di non far rumore coi denti. Se stranuti o se tossi, voltati
dall'altra parte. Non inzuppare il pane nel vino, non biasimar le vivande, non
guardare nel piatto degli altri, non ti stuzzicar i denti colle dita, non
toccare col pollice la sommità del bicchiere, e giù giù altri precetti, altri
consigli, altre regole per non esser, come egli dice, villano.
E così questa
letteratura dell'alta Italia, dopo aver intrattenute sulle piazze le plebi
avide di racconti, entrava col frate milanese anche nella casa del cittadino,
per insegnare a lui, alle sue donne, ai suoi figliuoli le pulitezze del viver
civile, annunziandoci l'avanzarsi di quella società borghese, che già strappava
al Medioevo gli ultimi brandelli della sua mistica corona.
Abbiamo veduto
quel che accadeva nel mezzogiorno e nel settentrione. Avviciniamoci al centro.
Gli inni sacri
latini furono moltissimi nel Medioevo, ed alcuni improntati di molta forza. Chi
non ricorda il Dies irae coi suoi
cupi suoni, colle sue lugubri immagini, col suo metro stesso che sembra
martellare nell'anima il terribile ricordo della fine del mondo? Chi non
ricorda lo Stabat mater, quella
pietosa poesia dell'amore materno, dove il dolore è così vero, così grande ed
espresso con tanta semplicità?
Sotto
l'influenza del movimento religioso che si operò in Italia nel secolo XIII,
l'inno latino passò alla forma volgare, e si ebbe così un nuovo genere di
poesia che si svolse principalmente nell'Umbria, la patria di San Francesco e
del Beato Jacopone da Todi, San Francesco, l'innamorato di Dio e della natura,
che chiamava fratelli il sole, i lupi, gli uccelli, che amava la musica; il
santo dalle idee cavalleresche, che volle avere una dama a cui servire e si
scelse la povertà; il trovatore di Cristo, che chiamava i pii compagni
dell'opera sua giullari del Signore e
paladini della Tavola rotonda, dicono
che rapito in estasi dettasse ad un suo compagno quello che fu detto il Cantico
del Sole.
E vero giullare
di Dio fu un seguace del poverello d'Assisi, Ser Jacopo Benedetti da Todi, il
quale narrasi avesse per moglie una bella, giovane e ricca gentildonna, che
recatasi un giorno ad una festa nuziale, fu travolta cogli altri nella rovina
della sala ove danzavasi; onde trasportata a casa moribonda non potè nascondere
al marito un pungente cilizio, che, nascosto sotto le splendide vesti, le
lacerava le carni. Quella vista fu per Ser Jacopo come un ammonimento di Dio:
da quel giorno, donate ai poveri tutte le sue ricchezze, e copertosi di
stracci, si diede alla vita della penitenza, e tant'oltre si spinse da
compiacersi d'esser mostrato a dito, d'esser deriso, d'esser seguito da una
folla che gli urlava dietro a dileggio: Jacopone, Jacopone! Diventò sua
passione l'esser pazzo per amore di Dio, e fece pazzie incredibili, come quella
di mostrarsi in pubblico con un basto d'asino sulle spalle e il morso in bocca,
camminando carponi come le bestie, o di cospargersi il corpo di trementina e
avvoltolarsi nelle piume, che rimanendogli appiccicate davano a quel
disgraziato un aspetto del quale non saprebbe immaginarsi il più ridicolo. Per
questa passione dell'amore divino il povero frate andò delirando anni ed anni,
condannandosi ai più duri patimenti. Per l'amore divino egli odiava sè stesso,
godeva di essere vilipeso, chiedeva a Dio tutti i mali, tutti i dolori, tutti i
tormenti: la febbre, l'idropisia, la podagra, la lebbra, il mal caduco,
chiedeva d'esser fatto cieco, sordo, e muto, e che il suo corpo fosse ridotto
fetente e che la sua sepoltura fosse nel ventre di un lupo! Rinnegava il padre,
i parenti, gli amici, aspirava a spogliarsi della sua umanità, raccomandava la
sua fama all'asino che raglia. Noi possiamo figurarci quale poesia uscisse da
quell'anima così profondamente esaltata: una poesia che scoppia in parole, in
accenti, in gemiti, in singhiozzi, che è un'ebbrezza continua, quasi un furore
erotico. Jacopone, poeta popolare, porta nell'arte sua la sensualità del
popolo, e veste d'immagini sensibili, di colori infuocati il mistico amore
dell'anima sua. Egli si esalta fino a chiamare i suoi rapimenti danza dello spirito, e grida questi, non
dirò versi ma singulti di sfrenata passione:
Ciascuno amante
che ama il Signore
Venga alla
danza cantando d'amore,
Di amore
ardente il cor tutto infocato
Sia trasformato
in grande fervore.
Infervorato
dell'ardente foco,
Come impazzito
che non trova loco,
Cristo
abbracciando, non l'abbracci poco,
Ma in questo
gioco se li strugga il core.
Lo cor si
strugga com'al foco il ghiaccio,
Quando col mio
Signor dentro m'abbraccio,
Gridando amor,
d'amor sì mi disfaccio,
Con l'amor
giaccio com'ebrio d'amore.
Pare davvero di
essere, non sul limitare del manicomio, ma dentro addirittura.
Pazzo o no, ad
ogni modo, certo è che il frate di Todi ha impeti lirici forti e sinceri; è
certo ancora che il suo misticismo lo trascina a guardare anche alle cose del
mondo, a farsi severo giudice dei religiosi e dei prelati del tempo suo, a
chiamare al suo tribunale lo stesso papa Bonifazio VIII. Il quale gettò in una tetra
prigione lo sventurato, lo fece incatenare, gli fece soffrire la fame; ed anche
nel carcere, tra i ferri, affamato il delirante asceta seguitò a cantare, e
chiamò quei tormenti la sua più grande consolazione.
L'arte di
Jacopone è sicuramente ruvida e sbrigliata; ma come poeta popolare (dice nel
suo eccellente studio sul Todino il mio dotto e caro amico Alessandro d'Ancona)
«egli ha duplice importanza, perchè ci mostra quali sentimenti fervevano ai
suoi tempi nel seno delle plebi e qual forma potevano assumere nel canto. Sia
ch'ei tratti i misteri della religione in forma lirica o drammatica, sia che
esalti la povertà francescana o vituperi i nemici di quella, egli ha una forza
ingenita che mal gli si potrebbe negare. Come quel gigante della favola che acquistava
vigore toccando la terra, Jacopone è poeta non per arte ma per natura, ogni
qualvolta attinga alle vivide fonti del sentir popolare, e ripeta le voci che
scorrono pei campi e mormorano nelle selve dell'Umbria».
Abbiamo
lasciato la lirica d'arte agonizzante di clorosi in Sicilia; la ritroviamo
galvanizzata da Guittone d'Arezzo, che con faticoso sforzo tenta di rinnovarla
latineggiandola; la ritroviamo che filosofeggia a Bologna, la città della
dottrina, pensosa ed astrusa sulle labbra di Guido Guinizelli.
Ma la Toscana
ormai attira la nostra attenzione. Ecco tuttavia della letteratura francese,
apparisce quivi una schiera di poeti che insegnano moralizzando, e vestendo
d'allegorie i propri insegnamenti. Un Ser Durante riduce in sonetti il Romanzo
della Rosa, e scrive il suo Tesoretto Brunetto Latini; altri da vecchi libri
francesi mette insieme l'Intelligenza,
e Francesco da Barberino compone i due trattati dei Documenti d'amore, e del
Reggimento e dei costumi di donna.
Messer
Francesco di Barberino di Valdelsa, un dotto giureconsulto, un uomo d'alto
affare, visse lungamente in Provenza, e là probabilmente concepì queste due
opere, che sono una specie di enciclopedia morale, e che ci serbano curiose
memorie dei costumi del tempo. Delle infinite cose ch'egli insegna, lasciate
ch'io ve ne dica alcune, o signore, di quelle che riguardano la donna. È un
altro Galateo anche questo, come quello di Fra Buonvicino.
Il Barberino
incomincia da dettare i suoi precetti per la fanciulla, e vuole, con ragione,
ch'ella stia sempre colla madre, che non vada mai sola tra uomini, che tenga
gli occhi bassi, che sappia tacere a tempo, e quando parla, parli
temperatamente e a voce bassa, che sia ordinata nel mangiare e bene acconcia
nel vestire. Vuole pure che, se ella sia richiesta di canto, prima di
acconsentire si faccia un poco pregare; che rida senza far rumore, e che anche
il pianto sia senza voce. Tutto questo però è d'obbligo per la donzella
figliuola d'imperatore o di re. S'ella invece avrà la fortuna di essere figlia
d'un semplice cavaliere o d'un giudice o d'un notaio, allora le sarà lecito
ridere e cantare e andare attorno, e menare allegrezza in balli e canti; allora
dovrà imparare a cucire, a filare ed anche a fare un po' da cucina.
Una terribile
questione si presenta al pensiero di messer Francesco. Sarà bene che la
fanciulla impari a leggere e a scrivere? Egli candidamente confessa che non sa
risolversi: ma dopo aver ragionato un pezzetto su questo arduo argomento,
conclude che nel dubbio è meglio scegliere la via più sicura; e questa via più
sicura è ch'ella impari altre cose, e lasci andare il leggere e lo scrivere
come inutile e pericoloso.
Alla promessa
sposa ordina il Barberino di star sempre nascosta, e che le sembri noia il solo
esser veduta, e che mostri paura d'ogni vista umana. Se le accade di uscire
alcuna volta colla madre, non deve salutare alcuno, ma camminare tutta
raccolta, cortese, soave,
Facendo piccol
passi e radi e pari.
Che se poi alla
fanciulla cominci a passare il tempo da marito, allora occorre raddoppiar le
cautele: non affacciarsi mai alla finestra, non legger libri di novelle nè di
canzoni, sceglier cibi adattati, e finalmente raccomandarsi alla misericordia
di Dio.
Rivolgendo i
suoi insegnamenti alla donna maritata, il nostro autore prende le mosse dalla
cerimonia del matrimonio e vuole che la fanciulla si faccia due o tre volte
ripetere la domanda del consentimento prima di rispondere, come vuole che mangi
prima in camera sua, per mostrar poi di non aver appetito al banchetto nuziale.
Potrei
seguitare ancora per molto a riferirvi i precetti del Barberino, ma la via
lunga mi sospinge, ed i libri suoi, del resto, come quelli degli altri rimatori
di questo ciclo allegorico-morale, nella storia dell'arte non segnano certo un
progresso. Sono un ultimo strascico dell'imitazione straniera, un limaccioso
rivoletto che va a perdersi nel fiume reale della nostra letteratura.
La quale
s'avvia oramai per nuovi e fioriti sentieri, annunziatori della vicina
grandezza. Eccovi un gruppo di toscani, poeti giocosi e satirici: i lontani
antenati del Pistoja, del Berni, del Lasca. È l'arte borghese che
s'ingentilisce e si afferma. L'amore cavalleresco coi suoi inutili sospiri, con
le sue donne valenti e fini, tutte uguali tra loro, tutte insignificanti, vuote,
irrigidite, cede il passo ad altri ideali. Lo scherzo comincia a diventare un
elemento della vita, e la risata del buonumore prorompe dalle labbra del
cittadino del libero e fiorente Comune, dove si vive d'allegria e di fiorini,
dove si ingrassa genialmente da epicurei e si muore stoicamente da eroi, dove
si hanno i presentimenti del mondo moderno e le virtù dell'antico. Curiosi
tempi delle zuffe sanguinose e feroci combattute per le vie della città, e dei
balli giulivi sulla piazze; dei lieti ritrovi, delle feste del maggio, delle
sollazzevoli brigate, ed insieme degli improvvisi corrucci, e delle truci
vendette.
A Siena,
narrano gli storici, dodici giovani nobili e ricchi, avendo sentito da un
predicatore annunziar vicina la fine del mondo, decisero prima che il mondo
finisse di godersi quanto più potessero, scioperatamente, la vita; si
ritrassero in un palazzo con gran moltitudine di servi e di cavalli, recando
ognuno diciottomila fiorini, e là in sontuosi pranzi e allegre cene, gittando
dopo il banchetto dalla finestra i ricchi vasi, i coltelli d'oro e d'argento,
regalando splendidamente ogni ospite che si presentasse al loro palazzo,
cuocendo le vivande colle punte de' garofani, consumarono in meno d'un anno
duecentomila fiorini d'oro.
Questa brigata
. . . . . . . .
. . in che disperse
Caccia d'Ascian
la vigna e la gran fronda.
E l'Abbagliato
il suo seno proferse,
ebbe il suo
poeta, Folgore da San Gimignano, il quale insegnò a quegli scapestrati ciò che
dovessero fare nei varii mesi dell'anno: di gennaio, per esempio,
Uscir di fori
alcuna volta il giorno,
Gittando della
neve bella e bianca
A le donzelle
che staran d'attorno;
di maggio
. . . . .
rompere e fiaccar bigordi e lance.
E piover da
finestre e da balconi
In giù
ghirlande e in su melarance;
di luglio,
mangiare
Di quella
gelatina smisurata,
E starne
arrosto e giovani fagiani,
Lessi, capponi,
capretti sovrani,
E, cui
piacesse, la manza e l'agliata.
Anche Firenze
ebbe le sue allegre brigate, sebbene non così pazze come quelle di Siena. Udite
ciò che narra il vecchio Villani: «Negli anni di Cristo 1283 si fece nella
contrada di Santa Felicita oltr'Arno, onde furono a capo i Rossi con loro
vicinanza, una nobile e ricca compagnia, vestiti tutti di robe bianche con uno
Signore detto dello Amore. Per la qual brigata non s'intendea se non in giuochi
ed in sollazzi e balli di donne, di cavalieri, popolani ed altra gente assai
onorevole, andando per la città con trombe e molti stromenti, stando in gioia
ed allegrezza a gran conviti di cene e desinari. La quale corte durò presso a
tre mesi, e fu la più nobile e nominata che mai si facesse in Firenze e in
Toscana.»
Or quello
stesso Folgore che aveva insegnato ai Senesi i sollazzi dei dodici mesi
dell'anno, a un'allegra brigata di Fiorentini insegnò quello che dovessero fare
per ogni giorno della settimana; e la gaia settimana in questo modo si chiude:
A la dimane,
all'apparir del giorno
Vegnente, che
domenica si chiama,
Qual più gli
piace damigella o dama
Abbiane molte
che gli sien d'attorno;
In un palazzo
dipinto ed adorno
Ragionare con
quella che più ama.
Qualunque cosa
che desia e brama
Vegna in
presente senza far distorno.
Danzar
donzelli, armeggiar cavalieri,
Cercar Fiorenza
per ogni contrada,
Per piazze, per
giardini e per verzieri,
E gente molta
per ciascuna strada,
E tutti quanti
il veggian volentieri.
Ed ogni dì, di
bene in meglio vada.
Come queste
poesie di Folgore ci ritraggono la vita spensierata dei giovani della fine del
tredicesimo secolo, così altre poesie, nello scherzo mordaci, ci diranno di
quel tempo gli sdegni. Sentite con quali tocchi vivi è disegnata da Rustico di
Filippo questa caricatura:
Quando Dio
messer Messerin fece,
Ben si credette
far gran meraviglia,
Chè uccello e
bestia ed uom ne soddisfece,
Che a
ciascheduna natura s'appiglia.
Che nel gozzo,
anitrocco il contraffece,
E nelle reni
giraffa somiglia,
Ed uom sembra,
secondo che si dece,
Nella piacente
sua cera vermiglia.
Ancor rassembra
corvo nel cantare,
Ed è diritta
bestia nel savere,
E ad uom è
somigliato al vestimento.
Quand'egli il
fece, poco avea che fare,
Ma volle
dimostrar lo suo potere,
Sì strana cosa
fare ebbe in talento.
E sentite che
satira profonda sia nascosta in questi consigli che ad un Gingillino del suo tempo dà Pucciarello da Firenze:
Per consiglio
ti do di passa passa,
Voltar mantello
a quel vento che viene:
Chi innalzar
non si può, molto fa bene
Se lo suo capo
flettendo s'abbassa.
E prendi a
esempio arboscel che si lassa,
Quando
inondazion gli sopravviene,
Ello s'inchina,
e così si mantiene
Finchè la
piena, dura ed aspra, passa.
Però quando ti
vedi stare abbasso,
Sta cieco,
sordo e muto, e sì non meno
Ciò ch'odi e
vedi, taci e nota appieno,
Finchè Fortuna
ti leva da basso:
Poi taglia,
stronca, mozza, rompi e batti,
E fa che mai
non torni a simil'atti.
Ma di questo
genere giocoso-satirico della nostra antichissima letteratura è principe un
Senese, che veramente sugli altri com'aquila vola. Cecco Angiolieri, che
qualcheduno ha chiamato un capo ameno, e che io direi piuttosto un grande
infelice, ebbe un padre duro ed avaro, una madre cattiva, una moglie brutta e
vecchia, che consumava il suo tempo a impiastricciarsi il viso col belletto ed
a lisciarsi i capelli. Ed egli che era nato poeta, spensierato, prodigo,
allegro, egli, in quella casa della tristezza e dell'avarizia, diventò un
perverso figliuolo ed un pessimo marito, non amò, com'ei stesso dice, che le
donne, la taverna e il giuoco; concepì odio per il padre e la madre, e dei suoi
odii e dei suoi amori cantò in modo che le sue parole sono qualche volta una
sacrilega bestemmia, qualche altra un pianto dirotto. Io ebbi, egli dice, il
dolore per padre, per madre la miseria, la malinconia per balia; le mie fasce
furono i malanni; tutto m'è andato sempre al rovescio:
Ma sì mi posso
un cotal vanto dare,
Che s'io
toccassi l'or, piombo il farei;
E se andassi al
mar, non crederei
Gocciola
d'acqua potervi trovare:
unico mio
rifugio sarebbe la morte:
Io ho sì tristo
il cor di cose cento,
Che cento volte
il dì penso morire,
Nell'Angiolieri
c'è una mescolanza continua di dolore e di scherzo, di lacrime e di
spensieratezza, di tragico e di comico. Accanto a un sonetto che è un
capolavoro di poesia burlesca, schizza fuori una quartina, una terzina, un verso
che pare un muggito di bestia feroce. Così, per esempio, egli mette in
canzonatura un tale tornato di Francia ricco e burbanzoso, e poi caduto in
basso:
Quando Ner
Piccolin tornò di Francia
Era sì caldo di
molti fiorini,
Che gli uomin
gli parevan topolini,
E di ciascun si
facea beffe e ciancia;
Ed usava di
dir: mala miscianza
Possa venire a
tutti i miei vicini,
Quando sono
appo me sì picciolini
Che mi fôra
disnor la loro usanza.
Or è per lo suo
senno a tal condotto,
Che non ha niun
sì picciolo vicino
Che non si
disdegnasse farli motto:
Ond'io metterei
'l cuor per un fiorino,
Ch'anzi che
sian passati mesi otto,
S'egli avrà pur
del pan, dirà: buonino!
Ed ecco quello
stesso poeta che si è burlato così piacevolmente di Neri Piccino, scrivere del proprio
padre queste orribili parole:
E poi m'è detto
ch'io nol debbo odiare;
Ma chi sapesse
bene ogni sua traccia,
Direbbe: il cor
gli dovresti mangiare.
Perdonatemi, o
signore, se vi ho letto questi versi che nelle vostre anime gentili debbono
destare ribrezzo ed orrore. Ma io doveva pure delinearvi la scapigliata e truce
figura dell'Angiolieri, che è senza dubbio uno dei poeti più caratteristici e
più originali che abbia la nostra letteratura del secolo XIII. E molte cose ho
taciute, moltissime, che pure avrebbero meglio lumeggiato quello strano uomo e
quel poeta, il quale alla distanza di tanti secoli fa pensare ad Enrico Heine.
Molte cose ho lasciate nel silenzio, ma non posso lasciare anche quello che è
il capolavoro del povero Cecco; un sonetto nel quale egli dice ciò che vorrebbe
essere e ciò che vorrebbe potere:
S'io fossi
fuoco, io arderei lo mondo;
S'io fossi
vento, io lo tempesterei;
S'io fossi
mare, io lo allagherei;
S'io fossi Dio,
lo manderei in profondo.
S'io fossi
papa, allor sarei giocondo,
Che tutti li
Cristian tribolerei;
S'io fossi
imperator, sai che farei?
A tutti
mozzerei lo capo a tondo.
S'io fossi
morte, io anderei da mio padre;
S'io fossi
vita, fuggirei da lui;
E similmente
farei a mia madre.
S'io fossi
Cecco, com'io sono e fui,
Torrei per me
le giovani leggiadre,
Le brutte
vecchie lascerei altrui.
Quali suoni si
alternano in questi versi! Par di sentire uno scroscio di fulmine, un urlo di
turbine, a cui succeda lo sghignazzar d'un dannato. I due motivi mescolandosi
fanno come un'armonia diabolica, in mezzo alla quale suonano stridule risa e
colpi di singhiozzo. Ma il fatto è che lo sventurato poeta piange qui lacrime
cocenti; e che questo sonetto è una delle più forti espressioni artistiche
dell'odio che abbia la letteratura italiana.
E se voi
riflettete, o signori, che questa letteratura, quando l'Angiolieri scriveva,
non aveva, tutt'al più, che un'ottant'anni di vita; se riflettete al cammino da
lei percorso in così breve spazio di tempo, vedrete come questo fatto
prodigioso non possa trovare spiegazione che nelle speciali condizioni del
pensiero italiano; in quelle condizioni che poterono ad una letteratura appena
nascente dare il suo scrittore più eccelso.
Ho nominato
Dante Alighieri: Dante che si trova per un momento mescolato a quei poeti
giocosi e satirici, Dante che fu in corrispondenza poetica coll'Angiolieri,
Dante che scambiò con Forese Donati, il fratello di Corso e di Piccarda, alcuni
mordaci sonetti, rivendicati al gran padre Alighieri da Isidoro del Lungo, il
sapiente difensore della Cronaca Diniana contro le jattanze indigene e
straniere.
Correvano gli
ultimi anni del secolo XIII. Firenze era, come altri disse, la prima potenza
denaresca d'Europa. I commerci, le industrie, le feste, le arti, le
rivoluzioni, le guerre, tutto contribuiva a fare di questa nobil figliuola di
Roma il centro del movimento economico, politico ed artistico d'Italia. Qui
fini ed arguti gli ingegni, forti i cuori, operose le braccia; qui persistenti
le tradizioni romane; qui una forte costituzione democratica; qui il senno
pratico e la leggiadria dei costumi; qui una lingua ricca di suoni e di forme.
In mezzo a codesta società cresce Dante Alighieri; cresce disdegnoso ed altero,
coll'anima bollente di passioni, estatico un giorno davanti a un angelo dipinto
da Giotto, curvo domani sulle pergamene di un codice di Boezio o di Arnaldo
Daniello; intento oggi a guardare con occhi cupidi una bella donna che passa,
raggiante un'altra volta di gioia al cospetto di un'immagine celeste che gli
balena nella fantasia; sorridente ai versi che gli dirige il suo Guido
Cavalcanti o il suo Cino, livido di disprezzo quando legge le insolenze di
Cecco Angiolieri, al quale par che risponda egli, il superbo giovine, quel
verso scritto al senese da un altro fiorentino:
Tu mi pari più
matto che gagliardo.
Nella
giovinezza di Dante ci fu certo un periodo di gravi disordini, e ne resta
documento nella sua corrispondenza poetica con Forese, nelle febbrili canzoni a
una donna ch'egli chiama Pietra, nella confessione fattane da lui stesso nella
Divina Commedia. Ed anche quando tenzoneggia d'ingiurie col Donati, od espande
i suoi bollori erotici per la crudele che gli squarta il cuore, la zampa del
leone si sente.
Ma non sono
queste le poesie che fanno a Dante aprire il secondo e glorioso periodo della
nostra letteratura. Se la tirannia dell'argomento non me lo vietasse, io vi
parlerei di quella scuola lirica da lui stesso chiamata del dolce stil nuovo da lui stesso definita
in questi versi famosi:
. . . . . . io
mi son un che quando
Amore spira,
noto, ed a quel modo
Che detta
dentro, vo significando.
Una lirica nei
suoni dolcissima, nella forma aerea, diafana, impalpabile, che pare una musica
celeste, un cantico di Serafini, un sospiro dell'anima; una lirica che sale su,
in alto, come una preghiera devota, che è un'estasi dello spirito innamorato
della più pura e più celeste idealità femminile.
Anche Dante
ebbe prima le sue titubanze. Alcune delle sue liriche risentono tuttavia
qualche cosa della maniera dei Provenzali e di quella del Guinizelli, ch'egli
salutò padre suo nell'arte. Ma poi spiccato il volo divino nel campo infinito
dell'ideale, parve transumanarsi, e dalle sue labbra sgorgarono le note più
soavi che abbia la lirica umana di tutti i tempi e di tutti i paesi. La donna
si mutò in angiolo, e con angelica lingua fu salutata dal suo poeta:
Tanto gentile e
tanto onesta pare
La donna mia,
quand'ella altrui saluta,
Ch'ogni lingua
divien tremando muta,
E gli occhi non
ardiscon di guardare.
Ella sen va,
sentendosi laudare,
Benignamente
d'umiltà vestuta,
E par che sia
una cosa venuta
Di cielo in
terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì
piacente a chi la mira
Che dà per gli
occhi una dolcezza al core,
Che intender
non la può chi non la prova.
E par che dalle
sue labbra si muova,
Uno spirto
soave e pien d'amore
Che va dicendo
all'anima: sospira.
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogni dolcezza,
ogni pensiero umile
Nasce nel core
a chi parlar la sente,
Ond'è beato chi
prima la vide.
Quel ch'ella
par quando un poco sorride,
Non si può
dicer nè tenere a mente,
Si è nuovo
miracolo gentile.
Miracolo nuovo
sono in verità questi versi, nei quali è, come il Carducci ha detto,
dell'afflato divino.
E colla lirica
Dantesca i nuovi destini della letteratura italiana furon segnati.
Povere le
nostre origini, poverissime, se paragonate colla ricchezza d'altri popoli,
all'Italia toccò la gloria d'infondere nei varii generi letterari il sacro
aroma che dona l'immortalità, il soffio avvivatore dell'arte. Le scarne e
torbide visioni oltremondane divennero sotto la mano di Dante il più grande
poema delle letterature moderne; la greggia novella si avvolse maestosa nel
peplo Boccaccesco; la lirica ebbe nel Petrarca il suo cesellatore stupendo; la
monotona canzone di gesta si tramutò nelle meraviglioso fantasie dei Pulci e
dell'Ariosto. E Firenze, la vostra bella Firenze, ha il vanto di essere stata
alla letteratura d'Italia madre e nutrice: essa che le diede la sua lingua, che
nel secolo quattordicesimo fu il focolare del pensiero e dell'arte, e che poi,
accordando gli esempi antichi al sentimento moderno, assimilando le forme
classiche all'arte volgare, si fece il tempio di Vesta delle tradizioni
paesane; essa, la gran signora dell'intelligenza, che prodigò regalmente al
mondo i tesori del Rinascimento. Si direbbe quasi che di questi solenni destini
fosse presago quel povero rimatore Siculo, che, quando appena spuntavano i
primi e pallidi albori della nostra letteratura, mandava alla Toscana il suo
saluto:
Va, canzonetta
mia,
Salutami
Toscana,
Quella ched è
sovrana,
Ed in cui regna
tutta cortesia.
LE UNIVERSITÀ E IL DIRITTO
DI
Francesco
Schupfer
Signore e Signori!
Vi ricorda di
avere negli anni della vostra infanzia udito favoleggiare di una principessa
d'altri tempi, che la virtù malefica di un mago aveva improvvisamente immersa
in un profondo letargo? La bella dormente durò così cento, ducento, trecento
anni, senza che il tempo potesse nulla su lei, finchè un prode e gentile
cavaliero, rotto l'incanto, la ridonò alle gioie della vita o dell'amore.
Così suona la
leggenda, che mi è tornata al pensiero appunto oggi, che il cortese invito di
questa benemerita Società promotrice di pubbliche letture, mi conduce a
parlarvi delle università e della scienza
del diritto negli albori della vita italiana.
Perchè
anch'esse hanno la loro leggenda.
Erennio
Modestino, prefetto dei vigili nel 244 dopo Cristo, avrebbe chiusa la serie dei
grandi giureconsulti romani. Lo studio e la scienza del diritto, dopo essersi
sollevati a straordinaria altezza, sarebbero decaduti. Dirò meglio: quella
gioconda primavera della giurisprudenza, che aveva illustrato il regno dei
Severi, si sarebbe come spenta improvvisamente già sotto i Romani, per far
luogo ad un periodo molto lungo, che avrebbe vissuto di sole memorie.
Ora non vi dirò
quali cause potrebbero aver determinato cotesto fenomeno: certo esso ha del
prodigioso, ed anche più prodigioso è il modo con cui si sarebbe venuti alla
riscossa. La scienza giuridica sarebbe caduta in un letargo mortale appunto nel
momento del suo maggiore rigoglio, per risorgere novecent'anni dopo in tutta la
sua bellezza e freschezza in Bologna per opera d'Irnerio il fortunato
cavaliero.
È una leggenda
simile all'altra; dissimile soltanto in ciò, che molti ci hanno creduto, e
forse ancora ci credono. Ma oggimai la fede è scossa.
In verità,
anche nei secoli buî, che formano il medio evo, in cui la forza cieca prevale,
e in cui parrebbe che non ci fosse posto per la scuola e per la scienza, l'una
e l'altra continuano; e siccome eran due civiltà che si disputavano il campo:
la civiltà romana e la civiltà langobarda, non farà meraviglia di trovare
scuole di diritto romano e scuole di diritto longobardo, scienza romana e
scuola langobarda, l'una e l'altra con la sua impronta e co' suoi caratteri
speciali, e l'una e l'altra dar la mano a Bologna, che forte delle vecchie
tradizioni, riuscirà nondimeno a metterci qualcosa di suo, molto del suo, ed
affermarsi in modo, da parer quasi che altre scuole ed altra scienza non ci
fossero state prima di essa. In sostanza Bologna non rappresenta per noi una
risurrezione; ma obbedisce alla grande legge dell'evoluzione, che governa il
mondo.
Pertanto è mio
proposito di ricercare oggi quali fossero le scuole di diritto che
sopravvissero alla caduta dell'impero e studiarne l'attività scientifica:
insieme vedremo come sorgesse Bologna, e che cosa abbia preso da esse, e che
cosa, alla sua volta, abbia dato alla storia della civiltà.
Comincio
dell'osservare, che, già sotto i Romani, certe nozioni di diritto solevano
impartirsi insieme con le materie del trivium,
specie con la rettorica, all'occasione del genus
judiciale. Le scuole del medio evo non fecero che continuare, anche per
questo riguardo, le tradizioni antiche; e così in quei primi secoli - nel VI
come nell'XI - il diritto forma oggetto di studio in tutte le scuole laiche
superiori, unitamente alla grammatica, alla dialettica, alla rettorica, che
erano appunto le arti liberali del trivio. Ne fanno fede Venanzio Fortunato nel
secolo VI, Alcuino e Teodulfo nei tempi di Carlomagno. Al secolo XI si
riferisce una notizia di Milone Crispino sul beato Lanfranco, da cui si rivela
che, fino dagli anni puerili, era stato istruito nelle scuole delle arti
liberali e delle leggi secolari, secondo l'uso della sua patria. Medesimamente
la Pugna Oratorum di Anselmo
Peripatetico, della metà del secolo XI, mostra che Anselmo, oltre ad essere
addestrato nella rettorica e nella dialettica, era anche versato nel diritto, e
che lo studio delle leggi romane andava tuttavia congiunto con la rettorica.
Anselmo affida appunto alla rettorica la rappresentanza della giurisprudenza; e
lo stesso risulta da alcune poesie del tempo. Una dice, parlando della
rettorica:
Jus civile, forum, curules ipsa perornat;
E un'altra:
Civiles causas judicat esse
meas.
Specialmente
meritano d'essere ricordati i versi che Wipo, un borgognone della diocesi di
Losanna, diresse nel 1041 ad Arrigo III. Il cappellano imperiale contrappone il
buon uso italico d'insegnare di buon'ora ai giovani le arti liberali, compresa
la giurisprudenza, alla crassa ignoranza dei Tedeschi de' suoi tempi, che ci
mettevano ben poca cura ad istruirsi, tranne se volean darsi alla carriera
ecclesiastica:
Hoc servant Itali
post prima crepundia cuncti
Et sudare scholis
mandatur tota juventus,
Solis Teutonicis
vacuum nel turpe videtiur,
Ut doceant
aliquem, nisi clericus accipiatur.
Soltanto non
convien credere che codeste scuole d'arti approfondissero molto lo studio della
giurisprudenza. Si tenevano più o meno sulle generali; e così accade che
perfino i migliori, come Anselmo Peripatetico, non potessero gareggiare coi
giuristi di professione.
D'altra parte
c'erano anche scuole speciali di diritto romano.
Quella di Roma
si è mantenuta anche nei secoli barbarici. Certo, esisteva nel secolo VI; e lo
deduciamo dall'editto di Atalarico sullo stipendio dei professori, e da un
brano della prammatica sanzione del 554, in cui Giustiniano ordina di pagare,
come per l'addietro, le annonæ ai
grammatici, agli oratori, e anche ai giureperiti. Lo stesso Giustiniano indica
chiaramente la scuola di Roma come una delle tre scuole ufficiali dell'impero.
Nè può dirsi ch'essa si perdesse così subito.
È però giunto
un momento, in cui il posto di Roma è stato preso da altre scuole, che già
prima eran venute in fama. Alludo specialmente a Ravenna, dove già da lungo
tempo esisteva uno studio di grammatica e rettorica. E in breve i vanti di
Ravenna doveano ecclissare quelli di Roma, tanto più che le relazioni di
Ravenna con l'Impero eran più dirette. Odofredo racconta, che lo studio era
stato altra volta a Roma, ma che poi era passato insieme coi libri legati nella
Pentapoli e a Ravenna, che in Italia avea tenuto il secondo posto. E anche
cerca di precisare il tempo: propter
bella quæ fuerunt in Marchia, a cagion delle guerre che ci furon nella
Marca; ma non è ben chiaro, nè si sa, quali propriamente fossero. Il Fitting
pensa alle guerre della seconda metà del secolo XI, che si combatterono appunto
fino alle porte di Roma, e nella stessa Roma, contro Gregorio VII, dal 1081 al
1084. Certo una frase del cardinale Atto (morto nel 1083) mostra che, ai tempi
di Gregorio VII, gli studi in Roma eran veramente decaduti; ma il cardinale ne
attribuisce la causa alle condizioni poco salubri della città, per lo che si
durava fatica a trovare professori che volessero dimorarvi. Insieme si vede,
che c'erano altri studi, i quali avevano offuscato quello di Roma.
Comunque la
scuola di Ravenna era molto frequentata e fiorente già verso la metà del secolo
XI; e lo deduciamo da una notizia che si trova in Pier Damiani. Il quale
riferisce una sua disputa, che nell'estate del 1045, avrebbe avuto appunto coi
giuristi di quella città, e ne risulta che il diritto romano era seriamente
insegnato, e che gli insegnanti erano giudici ed avvocati. La scuola tendeva a
mitigare l'impedimento della cognazione, stabilito dai canoni, ed è su questo
tema che si aggirò la discussione. Pier Damiani stava per la interpretazione
canonica. Insieme è osservabile che la opinione dei giuristi ravvennati,
nonostante la confutazione di Pier Damiani, si fece largo sempre più sì da
costringere il Papa a portarla davanti al Concilio lateranese del 1063, e
combatterla poi in una sua costituzione diretta ai vescovi, agli ecclesiastici
e ai giudici d'Italia. Ciò mostra il grado ascendente della scuola. Inoltre i
capitoli pubblicati da Arrigo III a Rimini, l'anno 1047, accennano ad alquanti legisperiti, nei quali era sorto il
dubbio, se i chierici dovessero prestar giuramento, o delegare questo ufficio
ad altri. Quei legati ricordavano una legge, che Teodosio Augusto aveva
indirizzato a Tauro prefetto del pretorio; e la circostanza del luogo, non
lontano da Ravenna, dove Arrigo pubblicò la sua legge, può far credere che la disputa
si agitasse colà. E anche un altro documento attesta in favore di questa
scuola. È un nuovo segno di vita, che essa dà, ancora nel 1080, col libello,
che Pietro Crasso, ravennate, mandò ad Arrigo IV, perchè se ne servisse nel
sinodo di Bressanone. È una scrittura che mostra molta erudizione in chi l'ha
dettata, specie una profonda conoscenza del diritto romano.
Un'altra scuola
appartiene pure a questi tempi: vo' dire la scuola langobarda di Pavia, che non
può essere trasandata nella storia del pensiero giuridico italiano.
Essa nacque da
piccoli germi. I fattori che concorsero a formarla sono: la Curia palatina, che
si stabilì a Pavia sullo scorcio del secolo X; e la scuola di grammatica, della
quale si hanno traccie fino dai tempi di Re Cuniberto, ma che propriamente deve
essersi rialzata sotto gli Ottoni, quando, sedate le lunghe e antiche
turbolenze, gli animi riversarono negli studi la loro gagliardia. La scuola di
diritto si svolse appunto dal seno della Curia palatina; ma l'antica scuola di
grammatica vi ha apparecchiato il terreno. Se più vuolsi, furono i giudici
palatini, o alcuni di essi, che, senza lasciare la pratica, cominciarono ad
insegnare. Infatti Sigifredo, uno dei più antichi glossatori della scuola, era judex sacri Palatii; e parimenti lo
erano Bonfiglio, Armanno, Walfredo; ma anche altri fungevano da giudici o
patrocinavano cause. Le Expositio dà
loro il nome di judices e causidici. D'altra parte, erano uomini
venuti su nella vecchia scuola di lettere; ed è questa loro educazione, che probabilmente
li ha spinti a consacrarsi allo studio ed all'insegnamento del diritto. Certo
è: se riescono a ripulirlo, e ad elevarlo a teoria, fu nel soccorso della
grammatica, della dialettica, della ragione umana imparate in quella scuola; e
senza essa neppur la scuola di diritto avrebbe potuto attecchire. Così Walcauso
è chiamato rethor nella collezione
che va sotto il suo nome:
. . . . .
rectis quod strinxit rethor habenis
Walcausus
meritus.
Il glossatore
Sigifredo, che ricordammo dianzi, era versatissimo nella rettorica, oltre che
nel diritto. Lanfranco, lo abbiamo già detto, era stato educato fino dalla
puerizia in scholis liberalium artium.
Aggiungo una
osservazione! Per comprendere come questa scuola sia sorta, non dobbiamo
dimenticare che correva una età, in cui tutto, o quasi tutto si trovava
abbandonato alla iniziativa individuale, specie in Italia, il paese delle
grandi iniziative. Eravamo ancora molto lungi dai tempi odierni, in cui tutto
si suole attendere dal governo, e di tutto lo si rende responsabile! D'altra
parte c'erano stati sempre maestri, che aveano insegnato privatamente verso
retribuzione. La qual cosa non vuol dire, che tutti sieno riusciti a fondare
stabilmente una scuola. Per lo più la scuola nasceva e tramontava con l'uomo;
ma a volte riesciva a mettere radice. Qualche individuo esercitò un fascino
troppo potente, perchè altri non ne seguisse l'esempio nel medesimo luogo; e
allora non era difficile che la scuola acquistasse un carattere durevole. Così
accade a Pavia.
Quant'è alle origini,
sono d'avviso che risalgano ai tempi di Ottone I. Le glosse alle leggi
langobarde fanno distinta memoria di una giurisprudenza surta in una età, omai
remota, durante cui la teoria del diritto pratico avea ricevuto solida forma.
L'età in discorso corrisponde, senza fallo, a quella degli Ottoni; primamente,
perchè i suoi giureconsulti avean veduto le pratiche osservate nei giudizi di
Leone vescovo di Vercelli, che fu nel seguito di Ottone I e vescovo palatino di
Ottone III; e poi perchè non conoscono altre leggi langobarde di età
posteriore, nè son più citati nelle glosse di questo leggi. I loro successori
della seconda metà del secolo li qualificano col nome di antiqui judices, Antiqui
causidici, o anche Antiqui semplicemente,
e talvolta Antiquissimi, senza dire
chi fossero. Lo studio poi continuava ancora nel secolo XII; e nonostante la
grande fama, in cui era venuta Bologna, lo si frequentava volentieri, e ci si
veniva anche da lontane regioni. Un formulario di lettere, compilato a Pavia
tra il 1119 e il 1124, ne riferisce una di uno scolaro allo zio, che comincia
così: Vestre paternitati, patruelium
piissime, innotescat me exulem Papie studio legum.... vel dialetice.... alacrem
aderere. Lo scolaro, manco a dirlo, si rivolgeva al piissimo zio per quattrini.
Del resto non
conosciamo che pochi giureconsulti di codesto studio pavese. I principali sono:
Walcauso, Bonfiglio, Guglielmo e Lanfranco; ma se ne ricordano anche altri.
La scuola di
Pavia esisteva già quando sorse Bologna; ma anche il nuovo studio bolognese
vien formandosi a poco a poco, appunto sulla base degli elementi che erano
concorsi a formare quello di Pavia. Certamente Bologna aveva, anch'essa, la sua
scuola di grammatica e di rettorica: anzi è da credere che già sullo scorcio
del secolo X e sul principio dell'XI fosse salita in fama, perchè ci si veniva
anche da altre parti d'Italia. San Guido, che poi fu vescovo d'Acqui, vi si
recò sul principio del secolo XI, e così San Bruno, vescovo di Segni, nella
seconda metà. Ma la scuola continua anche dopo, frequentatissima. Riferisco
solo due testimonianze tra molte che potrei ricordare. Il poeta, che cantò le
gesta di Federico I, parlando di Bologna, dice appunto, che era un centro di
studî, dove gli scolari accorrevano a frotte da tutte le parti del mondo, per
impararvi le variæ artes. E Acerbo
Morena spiega la cosa: pollebat equidem
tunc Bononia in literalibus studiis
pre cunctis Ytalie civitatibus. Insieme c'erano a Bologna molti giudici e
causidici e dottori di leggi, prima ancora che ci fosse la scuola di diritto.
Un Leo notarius et judex si ha già in
una carta del 982; e molti se ne incontrano nel secolo XI: un Alberto legis doctor, un Iginolfo, anche legis doctor ed aulæ regiæ judex, Pepone legis
doctor, un Pietro di Monte Armato judex,
un Rusticus legis doctus, per tacere
di altri. Ciò che più importa è il vedere, come questi dottori e giudici
fossero venuti su nella scuola di grammatica. Lo stesso Irnerio, il grande
Irnerio, aveva prima insegnato in artibus,
e fu soltanto dopo che cominciò a studiare nei libri legali e ad insegnare in
questi. Anzi Odofredo, accennando a certa sua tendenza sofistica, che mostra,
qua e là, nello interpretare le leggi, l'attribuisce all'essere egli stato loicus et magister in artibus. La troppa
energia dialettica fa a volte di questi scherzi. Un altro indizio non
disprezzabile degli studii e della coltura di questi giuristi, è il vedere come
amassero di quando in quando dar la stura alla loro vena poetica (mi si passi
la parola), e chiudessero i loro atti con qualche verso. Un Angelo causidicus compie nel 1116 un atto di
donazione, e finisce così:
Angelus his metris causidicus ista peregi
Notarii signo subscribens more benigno.
E due anni
dopo:
Angelus his metris causidicus ista peregi
Notarii signo subscribens robore summo.
Ora, questi
giudici e dottori bolognesi, che certamente nella scuola di grammatica e
rettorica aveano, insieme ad altre discipline, studiato anche il diritto, han
cominciato, alla lor volta, a tener scuola di legge, precisamente come a Pavia.
Nè la scuola è sfuggita a Odofredo, il quale, parlando di Pepone, dico appunto:
cepit auctoritate sua legere in legibus.
Nè importa se l'insegnamento sarà stato in sulle prime saltuario. Oggi era
Pepone, domani sarà stato Irnerio: leggevano come e quando credevano; e gli
scolari ne continuavano l'opera. Così veniva a stabilirsi una tradizione
scientifica, e la tradizione vuol già dir scuola: solo più tardi vi si
aggiungerà uno speciale ordinamento.
La scuola
stessa non è nata con Irnerio. Certamente Pepone lo ha preceduto
nell'insegnamento delle leggi; e quantunque Odofredo sentenzii che nullius nominis fuit, una qualche fama
deve averla goduta, se nel 1076 lo troviamo in un placito della duchessa
Beatrice, e appunto cotesta carta rivela altre contemporanee. Ma ci sono anche
altri indizî di una scienza preirneriana: soltanto non si fanno nomi. Tutto
induce a credere che alcuni giureconsulti ci sien stati a Bologna prima ancora
d'Irnerio; ma nessuno li ricorda. È una scienza che non ha nome; ed è a mala pena
che quello di Pepone, più fortunato degli altri, abbia potuto salvarsi. Subito
dopo Pepone è nominato Irnerio, giudice anch'egli, che oltre ad insegnare a
Bologna, figura più volte nei placiti matildini e imperiali e in altre carte,
dal 1113 al 1125. Dopo non se n'ha più traccia; ma intanto il suo nome aveva
ecclissato tutti gli altri. Odofredo, che pur avea detto di Pepone nullius nominis fuit, soggiunge,
parlando di Irnerio, che fuit maximi
nominis et fuit primus illuminator scientie nostre, sì da meritarsi il nome
di lucerna juris. Odofredo ne loda
specialmente l'ingegno sottile e la forza dialettica. Ciò che più importa,
Irnerio ha lasciato dei discepoli, che hanno anche insegnato, ed assicurato
così le sorti della scuola per tutti i tempi avvenire. Soltanto non si sa di
sicuro chi sieno. Ottone Morena fa menzione di quattro dottori famosi, che
avrebbero insegnato a Bologna circa la metà del secolo XII, e avuto comuni le
ingerenze nei più grandi affari del tempo: Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo di
Porta Ravegnana ed Ugo. Secondo il Morena sarebbero stati gli immediati scolari
d'Irnerio: anzi egli stesso li avrebbe qualificati così in un distico diventato
famoso:
Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,
Mens legum est Ugo, Jacobus id quod ego.
Ma forse si
tratta, più ch'altro, di una tradizione. Checchè ne sia di ciò, è certo che la
scuola si elevò per essi ad una straordinaria altezza, e continuò poi per altre
due generazioni. Mi restringo a ricordare alcuni nomi: Rogerio, Piacentino,
Giovanni Bassiano, Pillio, Vacario della prima generazione; Azone e Ugolino
della seconda. E se ne potrebbero ricordare anche altri. In realtà è una lunga
sequela di illustri giureconsulti; e son notevoli i passi che si son fatti di
generazione in generazione: i glossatori venuti dopo non mancano di trarre
partito da quelli che li han preceduti; ma d'altronde le fonti continuano
ancora a studiarsi, e l'autorità dei nomi non è d'impaccio ad alcun progresso.
Ugolino però è l'ultimo dei glossatori, le cui glosse abbiano una reale
importanza. Dopo lui la scuola decade. Si cominciarono a tenere nello stesso
conto le fonti e le illustrazioni, e tutte, buone e non buone, senza
discernimento nè esame, e si finì con lo studiarle, più che non si facesse
delle fonti stesse, e farne uso, anche là dove non si dovea. La stessa glossa
di Accursio è opera di decadenza, quantunque non ci sia stato forse altro
glossatore, che sia salito in maggior fama.
Tali erano le
scuole sugli albori della vita italiana. Resta che ne vediamo la produzione scientifica,
che deve, per così dire, mostrarcele in azione, rivelandone l'operosità durante
i secoli, di cui discorriamo.
Ci tengo a
ripeterlo, che la scienza giuridica dei Romani non è decaduta improvvisamente,
come si crede dai più; e ad ogni modo non è vero che le tenebre state di lunga
durata. Un barlume di luce appare nel secolo IV e nel V. Allora la letteratura
latina si è migliorata sensibilmente per sollevarsi fino alla filosofia
elegante e solida di Boezio ed alla erudizione illuminata di Cassiodoro: come
avrebbe la giurisprudenza potuto sfuggire all'impulso delle lettere, della
filosofia e della teologia? In realtà si è rialzata alquanto; e ne abbiamo la
prova in alcune opere di cotesti tempi, dovute probabilmente alla scuola di
Roma. Ricordo i Sommari del Codice Teodosiano, l'Interpretatio del Breviario, il Liber
Gaii, la Glossa torinese: tutti lavori, che non rivelano molta originalità
e potenza di mente, ma che d'altronde son chiari e precisi; e nei due ultimi si
può anche scorgere un progresso. Tuttavia sotto Giustiniano la scienza corse un
serio pericolo; perchè l'imperatore, a impedire che la sua opera legislativa
potesse venire offuscata e turbata dalla verbosità dei commenti, ordinò
ripetutamente che nessuno dovesse farsi a commentare il testo. Soltanto permise
di tradurre letteralmente la legge in greco per comodo dei suoi sudditi, e
indicarne sommariamente i titoli, e citare le opinioni dei giureconsulti
antichi, purchè si accordassero col nuovo diritto: ogni altra riproduzione e
illustrazione del testo doveva esser punita con la pena dei falsarî. Ora, il
divieto di Giustiniano paralizzava l'attività della scuola proprio nel momento
in cui, pei grandi mutamenti introdotti nella legislazione, se ne dovea sentire
più forte il bisogno; e la scienza giuridica ne fu seriamente minacciata.
Nondimeno la scuola, pur facendo mostra di acconciarsi alla volontà imperiale,
reagì come potè, ancora durante il regno di Giustiniano, e continuò poi sempre.
L'Epitome di Giuliano, la Summa perusina,
la Glossa pistoiese, le glosse che, nel corso del secolo X, furono aggiunte a
quella di Torino, appartengono a questa prima fioritura giuridica medievale. E
così si arriva al secolo XI, quando la scienza giuridica è già in pieno
rigoglio, tanto è vero che alcune produzioni han potuto mantenersi ancora per
lungo tempo accanto agli scritti della scuola bolognese. Anzi, come
istradamento alla scienza del diritto, son di gran lunga superiori ad essi.
Vogliamo alludere specialmente al Brachylogus
ed alle Exceptiones legum Romanorum,
usciti, a quanto pare, l'uno e l'altro dalla scuola ravennate. Anche il libello
di Pietro Crasso è un modello del genere. Così, già per opera delle scuole di
Roma e di Ravenna, la storia della scienza, da Costantino a Irnerio, si
presenta in una nuova luce; e nondimeno lo splendore di Bologna non ne rimane
punto ecclissato. Non ci sarà più nulla di meraviglioso; ma è certo che lo
studio del diritto romano è diventato a Bologna più speciale e quindi più
intenso. Dopo tutto ogni scuola ha la sua impronta, e anche quelle che stiamo
esaminando han la loro, ben diversa da quella che troveremo a Bologna.
In generale c'è
questa tendenza tanto nella scuola di Roma, quanto in quella di Ravenna, di
mettere la vecchia legge imperiale alla portata dei tempi nuovi e temperarne le
durezze. Essa si rivela già nelle lettere di Gregorio Magno; nè altrimenti il
Brachilogo altera a bella posta il diritto giustinianeo per adattarlo alle
condizioni dei tempi, e anche informarlo ad una maggiore equità. E non c'è
dubbio che siasi proposto una cosa e l'altra. Il giurista si atteggia qua e là
veramente a successore degli antichi prudentes,
la cui autorità non era minore di quella dei Cesari. Come il Principe vuole, e
così anche il giureconsulto dee volere; e in realtà egli assume l'aria di
legislatore: modifica il diritto, e non ne dà neppure la ragione,
restringendosi a dire: vogliamo la tal cosa, concediamo la tal altra. Lo che
non significa che egli proceda a casaccio. Si vede chiaro, che egli modifica il
diritto giustinianeo, o perchè non gli pare pienamente conforme a giustizia, o
perchè lo crede inopportuno, o anche perchè contraddice al diritto del paese. E
non ne fa mistero: sin vero æquitas juri
scripto contraria videatur, secundum ipsam judicandum est. Lo stesso modo
s'incontra nelle Exceptiones legum
Romanorum. Anche qui il giurista si è messo a foggiare il diritto più o
meno liberamente con riguardo all'equità ed alla opportunità, e lo dice egli
stesso nel prologo: Si quid inutile
ruptum æquitative contrarium in legibus reperitur nostris pedibus subcalcamus,
quicquid noviter inventum ac tenaciter servatum tibi.... revelamus. Anzi
ritorna più volte sui principî della giustizia e dell'equità che antepone alla
legge. Egli osserva, che quando la justitia
e la consuetudo, cioè la vera
giustizia intrinseca e il diritto positivo vigente, contrastavano tra loro, non
ci potean essere che gli idioti che si pronunciassero per la consuetudine: i legisperiti davano la preferenza alla
giustizia, che concordava sempre con la verità. Insieme proclama il diritto,
che aveano i giudici, di decampare dalle leggi per ragioni superiori, appunto
come il Brachilogo; ma lo attribuisce solo ai più autorevoli e timorati di Dio,
che non fossero facili a essere subornati per grazia o per denaro. Il giurista
dice che se ciò poteva farsi anche coi sacri canoni, che pur aveano maggiore
autorità, perchè non si avrebbe potuto con le leggi secolari? Così accadde che
più principî estranei al diritto romano penetrassero in questo libro; e d'altra
parte non vorrei nè pur dire che l'autore s'inchini sempre agli usi vigenti:
anzi talvolta vi si oppone per tornare ai vecchi principî.
Una nuova
tendenza della scuola appare dal libello di Pietro Crasso, ed è di estendere i
principî del diritto privato alle questioni di diritto pubblico. Il libello
stesso ne offre più applicazioni. Una riguarda i rapporti di Arrigo IV col
Papa. L'autore comincia dall'osservare che Papa Gregorio teneva la sede
pontificia Julia et Plautia lege
contempta; e nè tampoco poteva richiamarsi a quella costituzione del
Codice, che proibiva al figlio di famiglia di agire contro il padre, perchè non
poteva dirsi padre di Arrigo, essendosi comportato tutt'altro che paternamente
con lui, e anzi lo aveva emancipato, scomunicandolo, tendendogli d'ogni maniera
insidie, e perfino attentando a' suoi giorni. Anzi perciò potrebbe dirsi
incorso nella Lex de parricidiis. Lo
stesso Crasso si occupa poi dei rapporti di Arrigo coi Sassoni; e anche qui la
scrittura formicola di motivi privati. Per provare che avean fatto male a
deporlo, si richiama nientemeno che alle Istituzioni, che riconoscono il
diritto ereditario, e anche ad alcuni principî del Codice, che pareggiano la
consuetudine alla legge. Insieme avverte, che chi invade violentemente una cosa,
senza aspettare che il giudice decida, è obbligato a restituirla, e anche a
pagarne il valore, giusta la L. 7 C. unde
vi 7. 4. E così dovea essere coi Sassoni, che avean deposto Arrigo.
L'opera dei
giureconsulti pavesi non è meno importante, sebbene sotto un altro punto di
vista. Cominciano dal raccogliere le leggi cronologicamente e sistematicamente,
e finiscono con lo illustrarle. Dettano glosse e formule, e anche compilano
alcuni lavori indipendenti, e questioni e trattati, sul possesso, sul diritto
successorio, sul duello giudiziario, ecc., esponendo i principî del diritto
langobardo che vigeva nell'alta Italia, in modo sistematico, con la scorta di
varie leggi, qua e là paragonando il diritto romano e germanico tra loro.
Specialmente l'Expositio, una specie
di glossa perpetua alla Lombarda è opera di molto valore. L'autore non si
contenta di interpretare le singole leggi, ma ritesse, per così dire, la storia
dommatica di esse: espone le opinioni degli altri giureconsulti, le loro
dispute, e il modo con cui si studiavano di conciliare i passi discordi.
Insieme rivela una grande dimestichezza col diritto romano, che studia nelle
fonti.
In generale
solo il gius romano poteva sollevare in Italia la letteratura giuridica; e
infatti le glosse della scuola di Pavia acquistano subito, mercè esso, una
maggiore importanza. Se più vuolsi, possiamo notare fin dalle prime uno spirito
tutto italiano, che anima quei giureconsulti pavesi, ereditato forse dalla
vecchia scuola di grammatica. Comunque, non c'è dubbio, che lo studio pavese,
tutto dedicato a illustrare le leggi langobarde, riconosce subito l'autorità
del gius romano, e il suo valore sussidiario come diritto comune. Anzi la
scuola di Pavia si è resa tanto più eccellente, quanto più si è addentrata
nello studio di quel diritto. Gli antiqui
judices conoscevano certamente le Istituzioni giustinianee, ma non pare che
conoscessero altro: certo non aveano ancora addestrato lo spirito in modo da
sollevarlo oltre la materialità della legge. Talvolta si trovano come impacciati
nel conciliare i vari passi: ad ogni modo la loro interpretazione è sempre
letterale e pedestre. Aggiungo, che se gli Antiqui
si giovarono del diritto romano, lo fecero solo per supplire i difetti del
langobardo, nei casi, a cui questo non provvedeva: allora vi ricorrevano come a
legge generale; se no, no. Invece Guglielmo conosce anche il Codice, e la sua
interpretazione è già più larga. Egli non si appaga più della lettera della
legge, nè si crede in obbligo di star ligio ad essa; ma ne abbraccia lo
spirito, e, con la scorta del diritto romano, cerca d'introdurvi qualche
principio più sano di giustizia e di equità. In questo senso combatte gli
Antichi e Bonfiglio. Ma sopratutto si rivela questo indirizzo nell'autore della
Expositio. Egli approfitta di tutte
le fonti, allora conosciute: le Istituzioni, i primi nove libri nel Codice, il
Giuliano, e non trasanda neppur il Digesto. Nè si contenta di colmare le lacune
del diritto langobardo colle leggi romane; ma come Guglielmo e Lanfranco, e
anche più di essi, lo trae addirittura ai principî romani, interpretandolo con
la loro scorta, abbandonando l'analogia desunta dal diritto patrio per
surrogarvi quella delle leggi romane, sostituendo perfino le disposizioni
romane alle langobarde.
Insieme
interessa di vedere come questi lombardisti citassero le leggi. Abbandonano le
indicazioni generiche e i numeri per appigliarsi ai titoli e alle parole
iniziali, sia pei testi langobardi, sia pei romani; e anche questa è una cosa
che ha la sua importanza. È un metodo, che rivela nuovamente la grande
conoscenza, che aveano delle fonti, e che dovea far fortuna.
Lo studio di
Bologna, lo abbiamo già avvertito, non sorge di punto in bianco a ridestare o
iniziare un movimento scientifico spento da secoli. Anche lo studio bolognese
ha i suoi precursori e non può dirsi che riaccenda per il primo, dopo tanta
caligine medievale, la lampada della scienza. Certamente la tradizione ci ha la
sua parte. A cominciare dalla scuola di Roma, e venendo giù fino alla scuola di
Ravenna e a quella di Pavia, c'era oggimai tutta una tradizione, più o meno
scientifica, dovuta alla scuola: il terreno poteva dirsi apparecchiato già da
lungo per ricevere la nuova sementa. Lo studio di Bologna è, in verità, il
frutto di una lunga evoluzione storica; nè la letteratura giuridica medievale è
andata perduta per Bologna.
E già l'età dei
manoscritti, contenenti opere del periodo prebolognese, fa toccare con mano che
la tradizione di quella letteratura giuridica è penetrata nelle nuove scuole.
Infatti, perchè si sarebbero trascritte se non fossero state lette e studiate e
diffuse? Soggiungiamo, che i più di quei codici appartengono ai secoli XII e
XIII; sicchè non c'è dubbio: la vecchia scienza vive ancora per qualche secolo
accanto alla nuova, e soltanto a poco a poco vien balzata di seggio, quando la
nuova ne ha già tratto partito. Ma c'è di più. Confrontando la letteratura
giuridica e anche i metodi dei due periodi si trova che c'è realmente un legame
molto intimo. Io non esito a dire, che lo studio di Bologna si riattacca per
una parte a Ravenna e per l'altra a Pavia: a Ravenna sopratutto per la materia
giuridica, a Pavia per i metodi.
Certo, la
materia giuridica è venuta ai glossatori dell'antica scienza medievale dal
diritto romano. Alcune glosse preirneriane sono passate di peso nel grande
apparato accursiano; e la stessa coincidenza può trovarsi in talune
definizioni. Qua e là continua l'eco di qualche distinzione, e persino qualche
controversia giuridica formulata e discussa nel periodo prebolognese è tuttavia
viva nella scuola di Bologna. Lo stesso Pietro, autore delle Exceptiones, è citato da Accursio in più
luoghi e anche da altri. Un trattato de natura
actionum si trova adoperato dal Piacentino. La Lectura super actionibus di Pietro Crasso, autore del Libello, è
ancora ricordata nello statuto della università dei giuristi di Bologna negli
anni 1317-1346. Il Brachilogo ha certamente ispirato l'Epitome incerti auctoris, e parimenti presenta delle analogie col Liber juris florentinus.
Insieme vediamo
applicati qua e là i principî di diritto privato a rapporti pubblici, nè più nè
meno che si era fatto a Ravenna. Una glossa esamina la questione se il Papa
abbia la giurisdizione temporale nelle terre dell'Impero che si credevano
formar parte della donazione costantiniana; e ricorre volentieri a testi di
diritto privato. Un'altra volta Federigo I studia certa pretesa accampata dal
Papa sui palazzi dei vescovi, perchè non fossero tenuti a ricevere i nunzî
imperiali; e certamente furono i giureconsulti bolognesi a suggerirgli di
distinguere se il palazzo sorgeva nel suolo proprio del vescovo o in quello
dell'Impero; perchè in tal caso anche il palazzo dovea appartenere
all'Imperatore, giusta il principio che omne
quod inædificatur solo cedit. Era una regola di diritto privato che
Federigo applicava al diritto pubblico. Anche il modo, con cui lo stesso
Federigo procedette contro la eroica Milano, impaziente di freno, trova la sua
spiegazione nei principî di diritto privato applicati alla ragion pubblica. Più
tardi Federigo II vorrà provare che avea tutto il diritto di riprendere le
terre imperiali donate al Papa, e lo farà osservando, che il donante poteva
riprendere le cose donate se il donatario era ingrato. Altre volte i
giureconsulti giustificano con la teoria della usucapione la giurisdizione e
altri diritti sovrani, che le città accampavano contro l'Imperatore. Tale era
la dottrina di Bartolo; nè altrimenti ragionavano Giasone, Angelo Panormitano e
Jacopo.
Aggiungo che i
glossatori custodivano la memoria degli ordinamenti
scolastici giustinianei. Dirò meglio: l'ordinamento di Giustiniano si
riproduce a Bologna e continua a lungo, perchè tale era ancora ai tempi di
Accursio. Nè le illustrazioni dei testi hanno un carattere diverso. Era quel
tanto di scienza, che Giustiniano avea permesso, e i glossatori non hanno osato
di varcarne i limiti. Si tratta di Glosse
e tutt'al più di Summae, più o meno
estese; e fu soltanto in seguito, che la Somma si trasformò in trattato e la
Glossa in apparato e commento. È il merito di Bartolo, che primo ripigliò lo
svolgimento ampio dei testi, cercandone le ragioni, e deducendone le più alte
conseguenze, alterandone anche il concetto per adattarlo alle nuove esigenze
dei tempi.
Dall'altra
parte abbiamo il centro giuridico langobardo, che esercitò pure la sua
influenza su Bologna.
Certo, le
collezioni langobarde eran note alla scuola, e si citavano dai professori di
gius romano, e formavano oggetto di lezioni. Parimenti i legisti di Bologna
ricordano spesso le opinioni dei Pavesi e le discutono. Ciò che più importa, ne
accettano i metodi, e con essi si fanno a studiare le fonti. In sostanza, tanto
la scuola di Pavia quanto quella di Bologna studiano le fonti molto
minutamente, rivolgendosi, più ch'altro, alle particolarità, come non pare che
siasi fatto mai a Ravenna. Perciò anche il lavoro scientifico dei Bolognesi fu
assorbito in gran parte dalla glossa, come lo era stato quello dei Pavesi, e
l'una glossa e l'altra si somigliano. Uno dei cómpiti che i Lombardisti han
sciolto con singolare fortuna fu quello di cercare i passi paralleli, che
confermassero la legge o vi derogassero; e appunto questa tendenza trova il suo
compimento in Irnerio, che, redigendo le Autentiche, non faceva che andare un
passo più avanti dei Lombardisti, i quali si erano contentati di rimandare alla
legge derogatoria. Anche le tabelle, che si trovano aggiunte a qualche codice
di diritto langobardo, a guisa di alberi genealogici, in cui un rapporto
generale di diritto vien distinto nei suoi singoli casi, doveano, sviluppandosi,
condurre presto o tardi a quelle opere della scuola di Bologna, che si
conoscono col nome di Distinctiones;
per non dire di lavori affatto simili usciti dalla scuola dei glossatori.
Medesimamente la Expositio della
scuola langobarda prelude alla glossa di Accursio: certo, l'una e l'altra
riassumono i resultati delle due scuole, tenendo conto delle discussioni
dottrinali. Infine si sa che i glossatori si attengono, nel citare le leggi,
alle rubriche dei titoli ed alle parole iniziali delle leggi, astenendosi dai
numeri. È una pratica che si ricollega al ritorno, che avean fatto alle fonti;
ma già prima essa aveva dominato nella scuola di Pavia.
Nondimeno sta
il fatto che la scuola di Bologna ecclissò in breve tutte le altre; e interessa
di vedere quali cause possano aver conferito a portarla così presto a tanta
altezza.
Alcune sono
affatto estrinseche.
Certamente
molto si deve alla positura della città. Perchè già nel Medio Evo Bologna era
un gran centro del commercio mondiale. Situata nel mezzo di quattro provincie:
la Lombardia, la Marca Veronese, la Romagna e la Tuscia, si capisce che dovea
presto esercitare una grande attrazione per le industrie e i traffici d'ogni
specie, e rendere la vita comoda e aggradevole. Certo, era una delle città più ricche
e fiorenti, sicchè la chiamavano la
grassa; e specie i giovani doveano trovarcisi bene. Anche il poeta anonimo,
delle gesta di Federigo I, quando arriva a parlare degli scolari di Bologna,
non manca di avvertire ciò. L'Imperatore li interroga: perchè preferiscano
questa ad altre terre, e uno di essi risponde:
....hanc terram colimus, rex magne, refertam
Rebus ad utendum multumque legentibus aptam.
La cronaca del
prevosto Burcardo di Ursperg accenna anche alla influenza esercitata dalla
contessa Matilde. Sarebbe stata essa che avrebbe spronato Irnerio ad insegnare.
E non si trattava soltanto di ragioni scientifiche, che certo la contessa, per
la sua coltura, avrebbe potuto comprendere e apprezzare meglio di altri; ma
anche di ragioni pratiche. Nella sua grande devozione per Gregorio VII, essa
certamente non potea veder di buon occhio i giuristi della scuola di Ravenna,
che fino allora erano stati adoperati nei giudizi della Tuscia, dacchè Ravenna
era diventata la sede e il centro della opposizione contro le tendenze papali.
Molto meno le doveva piacere che i suoi sudditi fossero costretti di portarsi a
Ravenna per studiarvi legge. Così si rivolse a Bologna, che nella lotta per le
investiture aveva, a quanto pare, tenuto per il Papa, e vagheggiò l'idea che
l'insegnamento cominciato da Pepone potesse venire continuato. Infine ciò che
le premeva era di emanciparsi da Ravenna: soltanto ha sbagliato il conto.
Insieme giovò a
Bologna la larga protezione che Federico Barbarossa accordò allo studio sin da'
suoi primordi. Era di nuovo una protezione tutta politica, perchè l'Imperatore
vi avea trovato un forte alleato. Correano tempi difficili per l'Impero; tempi
di lotte gigantesche che minacciavano di travolgerne la sacra maestà romana. Da
un lato la Chiesa che gli si voleva imporre col prestigio della grazia divina;
dall'altro i Comuni lombardi, che ne aveano usurpato, uno dopo l'altro, i
diritti, e pur rispettandone la maestà ideale, miravano a ridurla veramente ad
una mera ombra o parvenza di potere. Eran momenti difficili; e l'Imperatore non
poteva avere un migliore alleato che nella lettera del diritto romano, come
l'avea inteso Giustiniano, e come, dopo tanti secoli, l'intendevano nuovamente
i dottori di Bologna. Ora, io ci tengo a dichiararlo altamente: io odio la
lettera morta, la lettera che vuole imporsi alla vita, e non corrisponde a
nessuna realtà della vita; ma capisco come un imperatore del Medio Evo, che si
vantava continuatore dell'antico Impero e chiedeva seriamente ch'esso non
avesse cambiato mai nè d'autorità nè di forme, potesse appigliarsi alla lettera
morta della legge, che gli dava ragione, senza curarsi della vita, che s'era
tutta rinnovellata dattorno a lui, e che gli dava torto.
Bologna ottenne
veramente un largo privilegio da Federigo, e un carme di quel tempo ce n'ha
lasciata la descrizione, che può metter conto di riassumere: è una bella pagina
di vita medievale.
Era la
Pentecoste dell'anno 1155, e Federigo si trovava accampato presso Bologna,
quando gli uscirono incontro i cittadini portandogli doni e distribuendo gran
copia di cose ai soldati. Insieme con essi vennero anche i dottori e gli
scolari, tutti ansiosi di vedere il Re Romano; numerosa turba, che dimorava a
Bologna, affaticando dì e notte nelle varie arti. Il Re li accolse placidamente,
e parlò con essi informandosi con benignità di molte cose. Domandò loro come
fossero trattati in quella città, e perchè la preferissero ad altre; se i
cittadini, come che fosse, li molestassero, e tenesser le promesse senza frode,
e li avesser cari, ed osservassero le leggi dell'ospitalità? Un dottore rispose
ordinatamente, mostrando quali fossero i costumi e la vita beata degli scolari.
Noi, disse, o gran Re, abitiamo questa terra piena di tutte cose necessarie
alla vita e molto adatta ai lettori. Affluisce qui da tutte le parti una turba
desiderosa di apprendere; qui portiamo il nostro oro e argento, i pallî, le
vesti, e prendiamo in affitto le case che ci convengono, nel mezzo della città.
Comperiamo tutto a giusto prezzo, tranne l'acqua, che è d'uso comune. Diamo
opera notte e giorno intensamente agli studi; e nel tempo, che passiamo qui,
questa ci sembra dolce fatica. Confesso - seguita a dire il dottore - che i
cittadini ci onorano in molte cose, salvo in una; perchè a volte ci molestano, costringendo
questo o quello a pagare senza che abbia ricevuto nulla, e pegnorandolo per
debiti non suoi. Imperocchè dopo aver prestato denaro ai nostri compaesani, lo
ripetono da noi, che non ci siamo per nulla tenuti. E dunque ti domandiamo, o
padre, di correggere questo perverso costume, e fare una legge, perchè i
lettori qui possano esser sicuri. Allora il Re, consultati tutti i Principi,
promulgò un editto a tutela dei lettori: che cioè nessuno debba quinci innanzi
impedire coloro che si davano agli studi, e sia che stessero o partissero o
tornassero; e non fossero costretti a pagare pei loro compaesani, se non vi
erano per nulla tenuti. Insieme pregò i cittadini di onorare gli scolari, e
serbare intatti i diritti della ospitalità senza frode; e dopo pochi giorni,
risarcite le forze, mosse il campo per visitare le città della Tuscia.
Bologna stessa
finì col prendere parte alle grandi lotte del secolo; e questa fu non ultima
causa che l'aiutò a salire. La contesa tra il Sacerdozio e l'Impero si è
agitata appunto a Bologna nel campo scientifico, prima ancora di passare
nuovamente in quello delle armi, per chiudersi con la vittoria di Legnano e con
la pace di Costanza. Già sul principio del secolo XII la lotta
scientifico-giuridica si combatteva a Bologna in nome del diritto romano da un
lato, del diritto canonico dall'altro, invocati entrambi ed applicati a
risolvere quistioni, che in sostanza avrebbero dovuto rimanere estranee all'uno
e all'altro diritto. Un gruppo di legisperiti,
capitanati da Irnerio, ha discusso nel 1118 a Roma sulla elezione del Papa e
favorito lo scisma, che dovea protrarsi poi ancora per qualche anno. Nel 1158
troviamo i suoi discepoli, invitati da Federico Barbarossa, a Roncaglia. Si
trattava di sapere quali fossero i diritti della corona, e di affermarli
solennemente in confronto delle città italiane, che li avevano usurpati: quei
giuristi si pronunciarono per l'imperatore in danno della patria; e n'ebbero
taccia di traditori! È una taccia che han meritata, e che pesa sulla loro memoria;
ma ci guarderemo dal credere che lo facessero per sentimento servile. Gli è che
obbedivano al sistema: l'ambizione cosmopolita degli antichi Cesari era, si può
dire, ricomparsa in quei grandi discepoli d'Irnerio! Dall'altro lato c'era
Graziano, c'era il Bandinelli l'amico di S. Bernardo, l'austero abate, c'era
tutta una folla di canonisti, che, forti della grazia divina e della autorità
delle leggi ecclesiastiche, si fecero a combattere i civilisti, i quali
finirono con l'avversare addirittura il diritto canonico. Sono note le parole
irriverenti di Pietro Bellapertica, grande dispregiatore dei canonisti intorno
alla metà del secolo XIII. Dal canto suo la Chiesa reagì, fino a bandire il
diritto romano dalle scuole. Così la lotta tra il Sacerdozio e l'Impero si
riproduceva nel dominio della giurisprudenza; ed io non so, ma dubito forte,
che l'antagonismo abbia maturato conseguenze fatali. Certamente ne derivò un
divorzio solenne tra l'idea del diritto e quella della religione; e gli uomini,
non ben pagani nè ben cristiani, finirono coll'essere balzati fuori dal mondo
morale. Intanto però la scuola s'era mischiata nelle dispute, e ciò bastò ad
alzarla, se non altro per un momento, nella estimazione dei contemporanei. Per
un momento gli sguardi dei migliori e sommi ingegni si fissarono su Bologna, la
grande lottatrice.
Bologna però
deve anche molto a sè stessa. Una nuova causa, e questa volta tutta intrinseca
del suo splendore, sta nel rinnovato studio
del diritto romano, e nel nuovo indirizzo,
ch'esso venne acquistando per opera dei Bolognesi. Vorrei anzi dire che ne è la
causa percipua; e non c'è dubbio che abbiamo a che fare con una vera rinnovazione. Certo, gli studi del
diritto romano destavano nel secolo XI un grande interesse più ancora che nei
secoli precedenti. Era infine un diritto, che, per effetto di circostanze
diverse, tendeva ad assurgere alla dignità di una legge comune in Italia e
fuori. E per il momento si trattava di una restaurazione pura e semplice, che
s'imponeva in tutto e da per tutto, anche a scapito delle condizioni reali del
paese. Le quali, certamente, non mancheranno poi di reagire; ma intanto dovevan
piegare la testa. Il diritto romano trionfava; ed era il diritto romano puro;
cioè il diritto quale era uscito dalla officina di Giustiniano, che, per una
ragione o per l'altra, tendeva a imporsi alla nuova società uscita dalle
crociate, non badando alle trasformazioni, che essa aveva subìto nel corso dei
secoli. Specie gli imperatori favorivano cotesta risurrezione pei loro fini. Se
vogliamo, era un indirizzo diametralmente opposto a quello che vedemmo dominare
da ultimo nella scuola di Ravenna; e non vogliam dire che fosse migliore, ma ad
ogni modo avea il merito di corrispondere alle esigenze del momento. Era
naturale che la scuola, che lo seguiva, se ne avvantaggiasse, e facesse in
breve oscurare i vanti di tutte le altre. E fu il caso con Bologna.
Quell'indirizzo
poi comprendeva più cose. Certo, si deve a Bologna se il diritto romano rimase
alla perfine separato dalla dialettica e dalla rettorica, due discipline con le
quali era stato unito per lungo tempo, in tutto il medio evo. E questo è già un
merito. Insieme si ritornò alla compilazione giustinianea, che si considerava
come un diritto vivo, destinato ancora a reggere il mondo. L'epitome di
Giuliano, e altri rimaneggiamenti del Codice e delle Istituzioni, a cui il
medio evo più antico avea cercato la norma del vivere civile, dovettero cedere
il posto ad uno studio più paziente e accurato e coscienzioso di tutte le parti
del Corpus Juris. Anzi è stato uno
studio fatto indipendentemente dalla vita, senza alcun contatto con essa; e ciò
dette fin dalle prime un carattere tutto dottrinario e teorico all'attività
della scuola. Il solo diritto vero, il solo che dovesse trovare applicazione, era,
a' suoi occhi, il diritto romano; e tutti i suoi sforzi son diretti a questo
scopo: studiare e illustrare il diritto romano nella sua purezza, quale l'avea
foggiato l'imperatore Giustiniano. Nè importava che, nei secoli venuti dopo, le
condizioni della civiltà si fossero mutate e rimutate più volte; e i bisogni e
gli interessi e i rapporti fossero altri; e il diritto stesso avesse dovuto
piegarsi più volte alle esigenze della vita: Irnerio e la sua scuola non
conoscevano, non volevano, che il diritto romano, il puro diritto romano, tutto
il diritto romano; e lungi dal piegarsi alle esigenze della pratica, che in
sostanza erano le esigenze della vita, pretendevano anzi che la pratica e la
vita avessero obbligo di adattarsi al diritto romano ed alla scuola. In questo
senso aveva ragione l'autore della Cronaca Urspergense di dire: domnus Wernerius libros legum qui dudum
neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat.... renovavit.
Soltanto non
vorrei asserire che siffatta tendenza fosse divisa da tutti. L'indirizzo della
scuola era quello; ma si capisce che la pratica non potesse sempre
acconciarvisi di buon grado, e a volte finisse col reagire. In realtà la
pratica sbugiardò più volte le teorie della scuola. Ciò che più importa alla
storia della giurisprudenza è il vedere, come in seno alla scuola stessa ci sia
stato qualcuno che cercò di tener conto della equità e darle la preferenza sulla morta lettera della legge.
Voglio alludere a Martino, che, per questo riguardo, ripiglia le tradizioni
della scuola ravennate. E anche Piacentino, e Alberigo di Porta Ravegnana, e
Pillio, seguono Martino; ma i più gli si mostrano avversi. La stessa glossa
d'Accursio lo trasanda quasi affatto. Certamente i tempi non correvano
favorevoli al suo indirizzo.
Del resto
appunto quel ricorso alle fonti e la tendenza tutta dottrinaria della scuola
han dato buoni frutti. Certamente la scienza ne guadagnò e ne guadagnò la
scuola. La legge fu meglio approfondita, e anzi lo fu in modo, di cui da lungo
si eran perdute le traccie. Ed era naturale! Non distratti da altro, con
l'occhio tutto intento al testo, non vedendo che questo, non volendo saperne
che di questo, non poteva non essere che i glossatori ne cogliessero gl'intimi
segreti e ne indovinassero lo spirito; e si formasse in breve l'opinione, che
chi volea studiare diritto non potesse studiarlo che a Bologna.
Una epistola di
Pietro Blesense accenna già a ciò. Essa è diretta ad un chierico inglese, e
veramente lo sconsiglia dallo studiare giurisprudenza, che era una cosa
piuttosto ardua e difficile e pericolosa per la salute dell'anima, e lo sprona
a darsi invece alla teologia; ma si capisce che, volendo studiare
giurisprudenza, avrebbe dovuto recarsi a Bologna.
E mi si conceda
anche un'altra citazione tolta da queste medesime lettere di Pietro Blesense,
che mostra il vero fascino, che lo studio del diritto romano esercitava su le
menti, cosa che forse farà inarcare le ciglia a più d'uno, e anche mostra la
memoria gratissima, che lo scolaro, a quei tempi, conservava per l'alma mater, che prima lo aveva nudrito
col latte della scienza. Pietro Blesense avea verso il 1160 studiato legge a
Bologna e poi si era ridotto a Parigi a studiarvi teologia; ma anche in mezzo
agli studî teologici, tornava volentieri agli antichi amori, e, scrivendone all'amico,
non gli nasconde quanti amari sacrifici gli avesse costato il cambio. Ecco un
brano della lettera: Vester vobisque
devotissimus operam theologiæ Parisiis indulgeo, Bononiensis castra militiæ
crebro suspirans, quæ vehementer amata citius et premature deserui. Più
sotto passa a discorrere della legge; e dalle sue parole trapela nuovamente un
vergine entusiasmo giovanile per questa legge laica, così attraente, così
seducente, in confronto della severa legge teologica, a cui s'era dato. La
legge romana lo aveva addirittura affascinato. D'altronde non s'era ancora
tanto impelagato nello studio delle leggi divine, che non gli avanzasse un po'
di tempo per darsi alla letteratura del Codice e del Digesto, e lo facea per
mero suo sollazzo e non per uso. La lettera continua osservando il grave
pericolo, che c'era pei chierici di studiar legge, tanto essa assorbiva tutto
l'uomo, da lasciargli poco agio o voglia per le cose divine. - A me non resta
che augurare agli studenti dei nostri giorni, che tutti i loro amori possano
somigliare a codesti ardenti e casti dello scolaro bolognese del secolo XII.
Intanto
Bologna, mercè il suo studio, si meritò presto il soprannome di dotta. Già il poeta, che cantò la guerra
tra Milano e Como, la chiama così: docta
Bononia. Col tempo poi la cosa diventò proverbiale, e il nome di Bologna
finì con l'essere indissolubilmente unito a codesta sua speciale missione
d'insegnare: Bononia docet.
Ed ora, vorrem
dire che Bologna sia meno grande, perchè non spezzò il filo delle vecchie tradizioni,
ma si riattaccò ad esse e ne fece suo pro'? Certamente lo studio di Bologna si
riannoda al passato; ma insieme porta anch'esso il suo contributo alla storia:
lo porta al pari di Roma e di Ravenna, al pari di Pavia, e s'afferma e s'impone
e appare improvvisamente circonfuso di splendida luce, quale non si era vista
per molti secoli, quale forse non si vedrà più. Chiaro è: come al banchetto
della vita, così a quello della scienza, c'è posto per tutti - intendo gli
uomini di buona volontà. Dopo tutto, è una cosa che conforta il vedere che la
parola della scienza non va perduta, ma resta, anche in mezzo alle mille
vicende e traversie e tristizie dei tempi. Simile alle stelle che nel mare Egeo
sornuotavano a indicare dove stava sprofondata la lira di Saffo, anch'essa
sornuota a tutto; e le nuove generazioni la raccolgono, e amorosamente la
custodiscono, e aggiungendovi, o anche non aggiungendovi nulla del proprio, la
trasmettono, vigili lampadofore, alle generazioni venture.
Signore e Signori!
Il progresso
umano è soltanto a questo patto.
LA FILOSOFIA E LA SCIENZA
NEL PERIODO DELLE ORIGINI
DI
Giacomo Barzellotti
Signore e Signori.
Ernesto Renan
in uno dei suoi Nuovi studi di storia
religiosa dice: «Quella gran notte la quale si stende dalla rovina della
civiltà antica al risplendere della civiltà moderna, non è, come molti se la
sono figurata, un'ombra tutta uniforme, ma presenta a un occhio attento linee
assai chiare, d'un disegno facile a scorgersi. La notte non dura realmente che
fino al secolo undecimo. Allora ha luogo un rinascimento in filosofia, in
poesia, in politica, in arte. Di questo rinascimento la parte prima, che spetta
principalmente alla filosofia e a quel pochissimo di scienza che allora le era
unita, può dirsi si accolga tutta nella Scolastica, nella filosofia del
Cristianesimo e della Chiesa, che si estende anche in occidente per tutto là
ove arriva la grande azione intellettuale e la fede della comunità religiosa
guidata da Roma.»
Il momento
storico che io debbo descrivervi e che va dall'entrare del secolo undecimo fino
a Dante, è come l'albeggiare primo e incerto della coltura italiana che ne
precorre il pieno giorno glorioso, già quasi al suo colmo sul finire del secolo
decimoterzo. A guardarlo ora, nelle lontananze della storia della mente e
dell'anima del nostro popolo, cotesto primo momento del suo risorgere rende
immagine di quello che sono sotto il nostro bel cielo d'Italia, là in quella
potente natura dei paesi meridionali, così fosca nelle sue tempeste, ma anche
così mirabilmente precoce nei suoi risvegli di primavera, quelle mattinate
quando a un alito fecondo di vita che la invade tutta, il sereno rompe dai
monti e dalla marina e il sole appena spuntato fa già quasi sentire tutta la
sua forza. È come una vittoria faticosa, contrastata ma rapida della stagione
nuova sull'inverno che si dilegua, dopo una lotta tra il vento e le nubi dense,
abbassate, sotto a cui l'aspetto del mare, mutabile, come un bel volto
meridionale a ogni soffio della passione, cangia di momento in momento dal
ceruleo fosco della tempesta all'azzurro chiaro scintillante di luce. Noi
assistiamo dal lido a questa vittoria crescente del sereno e del sole che
avventa fasci di strali luminosi e fende e respinge sempre più le grandi masse
di nubi, sino a che tutta la curva del golfo di Napoli si apra all'occhio in
piena luce tra la punta di Sorrento e quella di Posilippo.
A questo
rasserenarsi della natura in un paese meridionale fa pensare, lo spettacolo che
dà di sè lo spirito italiano risorgente dopo il mille appena un alito di
libertà, d'ideali religiosi e civili e di nuove forze sociali vi spira dentro.
I due ultimi
secoli declinanti verso il mille, specie il decimo, che fu detto a ragione un'età di ferro, avean veduto in Italia
l'estremo della violenza corrotta e dell'abbiezione, cui aveva potuto
trascorrere una feudalità come la nostra, mista degli elementi di tante
invasioni soprappostisi gli uni agli altri, discorde in sè stessa, agitantesi
in perfide gare di dominio tra, da un lato, gli ultimi fiacchi Carolingi, i
Berengari, gli Ottoni e i primi imperatori ghibellini, tutti impotenti a
contenerla, e dall'altra parte il Papato. Il quale, scaduto dal primo suo
grande ufficio di tutore dei popoli e da quello che si era assunto sotto Carlo
Magno di restaurare la dignità dell'Impero, era divenuto ormai poco più e anche
meno di un feudo baronale di un dogato romano. Nella notte dei tempi delle
Teodore e delle Marozie, l'Italia, minacciata al nord dagli Ungheri, corsa,
occupata al mezzogiorno dai Saraceni, era scesa anche più basso nelle miserie
civili che non quando alla deposizione di Carlo il Grosso una dieta di signori
e di prelati aveva detto nessuna voce
poter bastare ad esprimere ciò che il paese aveva sofferto.
E pure in
codesto buio era rimasto ancora qualche barlume. Se gli studi classici greci e
la conoscenza di quella lingua erano, si può dire, spariti dall'occidente
d'Europa, un sentore della coltura antica e dello studio del latino classico
s'era potuto però conservare nelle scuole dei grammatici non mai morte. Le
enciclopedie di Cassiodoro, di Claudiano Mamerto, di Capella, d'Isidoro, di
Beda l'avevano come fatta passare essicandola in rozzi estratti, che pur ne
rendevano ancora, se non lo spirito, in parte però i materiali e le forme.
E la Chiesa
facendo sue tante di codeste forme, accogliendo, in occidente, il latino come
lingua sacra, molto aveva salvato del sapere e del pensiero antico nelle opere
dei Padri, della tradizione grammaticale e letteraria nelle scuole unite alle
parrocchie, alle cattedrali e nei seminari. Nelle biblioteche benedettine dove,
come narra Benvenuto da Imola, qualche volta cresceva l'erba, s'eran distrutti,
è vero, col raschiarli, non pochi codici antichi; ma spesso anche aveva
brillato nelle veglie di qualche pallido monaco curvo sui libri una lampada
che, come quella del pensatore, secondo la bella espressione di Gian Paolo
Richter «avrebbe rischiarato il mondo.»
Il papato fin
da quando mettendosi dalla parte del popolo respinse da noi il moto bizantino
degli Iconoclasti, aveva concorso a salvare l'avvenire delle arti. E nella
tradizione ecclesiastica del diritto canonico, nelle immunità vescovili
strappate agl'imperatori, e da cui in più luoghi avean cominciate le franchigie
delle città, molti germi di coltura e di consuetudini più umane in età così
violente s'eran potuti preservare. Anche fuori del breve giro delle sette arti,
da cui di rado osava uscire il sapere medievale, una parte delle dottrine
naturali e matematiche coltivate dai Greci s'era con le scienze occulte trasmessa a noi dagli Arabi.
Siciliani, se non altro, di nascita erano un traduttore della Materia medica di Dioscoride vissuto nel
decimo secolo, e nella prima metà del duodecimo sotto Ruggero il Normanno
l'ammiraglio Eugenio interprete dell'Ottica
di Tolomeo. Era compilato in Sicilia per ordine del Re Normanno, e, come crede
l'Amari, da uomini forse la più parte italiani, il celebre libro di geografia
detto il libro di Ruggero e
attribuito ad Edrisi. E accanto a questi studi che poi doveano giovar tanto ai
primi viaggiatori e navigatori d'Italia, un altro ne era sempre sopravvissuto
per tradizione tutta nostra, quello del Diritto
romano, ultimo splendore dell'occaso italico, come lo chiama il Carducci, e
che sembra ritardare resistendo in faccia ai Goti l'oscurità barbarica, sembra
interromperla balenando nella legislazione dei Longobardi. A Roma nella scuola imperiale
d'arti e di giurisprudenza, a Pavia nella scuola regia longobarda, a Ravenna
nell'interpretazione dei libri di Giustiniano, poi a Bologna da Pepone ad
Irnerio, il diritto teneva vivo tra noi quanto di più alto ci era rimasto della
romanità spenta, per poi uscir dalle scuole e mescolarsi alle contese tra la
Chiesa e l'Impero e prestare all'una e all'altro armi di cui poi dovean
valersi, venendo su tra quelle contese, i nostri comuni.
Ma intanto, se
non comuni, città in parte almeno
indipendenti erano cominciate a sorgere qua e là anche innanzi e dopo l'entrare
del secolo undecimo; prime le marinare: Genova a riparo dei monti, Venezia
fatta sicura dalle lagune e ben presto signora dell'Istria e della Dalmazia,
Pisa, coi suoi navigli, uniti poi a quelli di Genova, in caccia dei Saraceni;
nel mezzogiorno Gaeta e Amalfi, che già nel secolo X fioriva di commerci, e
Salerno insigne per la sua scuola, che già aveva medici di grido prima del
mille.
In codeste
forme di reggimento politico, mezzo tra il feudale e il popolare, non s'era
ancora però potuta comporre una società nuova, una società vera. Quando essa,
quasi a un tempo, cominciò a venir su in più parti d'Italia, e prima nelle
città lombarde coll'incremento del comune,
più tardi ordinato sotto i consoli, dal confondersi e contemperarsi del sangue
e delle forze delle classi soggette, dei vassalli inferiori, de' borghesi,
degli artigiani con la vecchia nobiltà feudale, e ne scoppiò un fermento, un
rigoglio nuovo di vita popolare nascente, contro al cui urto doveva poi
rompersi a Legnano la furia dell'Imperatore, allora, o signori, in quelle
origini della forma di società civile che fu nostra e fatta dal genio nativo
del nostro popolo, vediamo concorrere tutte insieme a produrla e più a farla
poi fiorire di arti e di alta coltura quelle che sono state, che saranno sempre
le prime condizioni di qualsiasi grandezza umana nelle cose morali e sociali:
non la indipendenza e la libertà politica sole, che non bastano, ma sopratutto
il forte consentire delle volontà individuali in un grande intento comune, il
loro eroico obliarsi in qualche grande idea impersonale, tale da oltrepassare
la vita e i suoi interessi e i suoi piaceri, e farla gettar via, al bisogno,
con gioia per ciò che vale più di lei.
Questo era il
lievito da cui fermentò, penetrata tutta di una grande idealità di pensiero e
d'arte, la coltura dei comuni italiani. Sorti fra le lotte di due grandi
potestà, che parlavano e combattevano così l'una come l'altra in nome di
un'idea, essi paiono, in quest'ultimo tratto del deserto medievale, avviarsi
esploratori di una civiltà nuova con l'occhio volto a due grandi miraggi
storici: a quello dell'Impero, come di tutto un passato di signoria sui popoli
da restaurare qui da noi; a quello della Chiesa teocratica, quale l'aveva
pensata e riformata un nostro, Ildebrando, come di una grande dittatura delle
menti e degli animi, di una romanità restaurata nel campo della coscienza.
Miraggi, se si vuole, l'uno e l'altro che per secoli sviarono la storia
italiana da quel cammino sicuro dell'unità e della concentrazione nazionale per
cui già nel secolo undecimo s'eran messi altri popoli d'Europa. Ma quante
grandi contemplazioni di pensiero geniale, quante visioni di arte ispirata
fruttarono codesti miraggi da sant'Anselmo d'Aosta a Tommaso d'Aquino, dal
cantico al sole di Francesco d'Assisi, dall'Itinerarium
di san Bonaventura, alla Monarchia,
al Convito e al Paradiso di Dante! Anzi non peraltro io credo che l'Italia, sebbene
la sua lingua sia stata scritta tanto più tardi delle altre lingue romanze, le
abbia precedute nella maturità precoce della sua letteratura, se non perchè qui
da noi sotto questo suolo pieno di così grandi memorie non mai spente, campo
delle maggiori lotte morali e storiche di quel tempo, covava, lasciatemi dir
così, una maggiore semenza fecondatrice d'ideali ispiratori del pensiero e
dell'animo umano. La riforma dei chiostri, che precede ed inizia l'opera di
Ildebrando e la contesa per le investiture; - poichè solo nella solitudine e
nel raccoglimento l'uomo si è sempre apparecchiato ad agire potentemente sugli
altri; - questa riforma muove da Cluny onde esce anche Gregorio VII; ma
l'impulso più potente viene dall'Italia, da grandi solitari come san Romualdo,
san Giovan Gualberto, da pensatori eloquenti come Lanfranco e san Pier Damiano.
Uno dei centri più importanti di tal moto di riforma fu, nella seconda metà del
secolo XI, la nostra Firenze; dove il rogo di Pietro Igneo precedeva nel 1068
il nascere della Repubblica, allo stesso modo che, dice il Villari, doveva nel
1498 precederne la morte il rogo di Girolamo Savonarola. E allora e anche più
tardi dopo che col suo svolgersi in forme più larghe la storia dei comuni e dei
popoli d'Italia trae più della sua materia dagli interessi economici, sociali e
politici dal laicato, il motivo ideale delle sue iniziative più grandi resta
per un pezzo in un ordine di pensieri che accenna al di là e al disopra della
vita. N'è prova la pittura che è tutta, si può dire, fino al cinquecento
un'epopea sacra figurata; n'è prova quella mirabile fioritura di monumenti
ecclesiastici, primavera dell'arte di cui l'Italia si cuopre tutta nei secoli
duodecimo e decimoterzo, mentre le prime ispirazioni alla letteratura appena
nascente vengono dalla pietà e dal sentimento mistico e si esprimono in cantici e laudi, in leggende e vite di santi. Certo quell'impeto di fede
armata che trascinò gran parte d'Europa nelle Crociate investì appena l'Italia.
I nostri comuni ebbero da quelle imprese più che altro occasioni a guadagni e
commerci nuovi, a viaggi avventurosi fecondi di contatti intellettuali con
l'Oriente. Ma s'ingannerebbe chi argomentasse da ciò che quella intensità
d'eroismo religioso non abbia tramandato anche da lontano molto del suo calore
ne' cuori italiani. Quanto se ne siano accese le fantasie lo mostra la parte,
minore certo che in altre letterature, ma pur sempre notevole che ebbero nella
nostra, specie ne' racconti, le avventure dei Crociati. E il sentimento
popolare che li accompagnò veleggianti verso
il glorioso acquisto dovette vibrare anche fra noi intenso, se tanti secoli
dopo potè fare quasi da corpo della risonanza all'eco profonda che la Gerusalemme del Tasso ha destato in
tutta la nazione.
L'idea
religiosa cristiana era, adunque, in quel sorgere della nostra coltura, e
rimase poi fino a Dante, sino a che questa tocca, si può dire, con lui quasi la
sua maturità, il vero motivo dominatore del pensiero e dell'ingegno del nostro
popolo e degli uomini che più ne rendono in sè il tipo; l'idea cristiana, non
però côlta e sentita soltanto, come pur fu nei fervori del gran moto
francescano e dell'arte primitiva, in tutta la sua ingenuità, nuda e quasi
paurosa di forme e molto meno nella rigidità ascetica, nell'immensità cupa del
fanatismo dommatico mistico dei suoi seguaci di altre nazionalità, dei
precursori tedeschi e inglesi della Riforma.
Anche avuto pur
sempre riguardo alla ricchezza di forme e di elementi ideali con cui la varietà
d'indole delle stirpi d'Italia, dalle lombarde alle meridionali, si riflette
nella storia della nostra coltura, una cosa è certa: che la nota caratteristica
tradizionale delle manifestazioni durevoli del genio italiano è un'alta
serenità d'equilibrio tra il sentimento, il pensiero e l'immaginativa, tra il
moto caloroso della ispirazione e la compostezza della forma; è in somma quasi
un abito ereditario di forte disciplina, impresso in noi da Roma, e che ci fa
cercar sempre nell'idea, nella forma, nelle linee, nella parola un senso come
di misura e di riposo monumentale e d'intima armonia di tutta l'anima umana con
sè stessa e con la natura, una decenza come di chi medita, parla e scrive in
cospetto di tutti e ha bisogno di sentir ripercossa la verità e l'efficacia
dell'opera sua in un intento comune, in un forte consenso sociale.
Questa doveva essere
l'impronta del pensiero e dell'arte del cinquecento tornato alle fonti e agli
ideali classici. Ma la corrente dell'immaginare e del sentire che lo penetra
tutto, deriva dal fondo della vena nativa dell'intelletto italiano, quale si
mostra sin dal suo primo sgorgare nel trecento e prima e risale altissima nella
Divina Commedia.
Essa è già
tutta, nonostante le deviazioni che possono imprimerle gli eccessi di qualche
asceta mistico e le fantasie apocalittiche di qualche visionario come
Giovacchino di Fiore o Giovanni da Parma, nell'atteggiamento di forte
disciplina e di larga comprensione organica che la Scolastica dà per opera, in
grandissima parte, d'ingegni italiani o sorti in Italia, alle idee religiose e
alla teologia del Medio Evo da Anselmo d'Aosta a Tommaso d'Aquino.
I quali
esprimono, il primo, quello che oggi si direbbe il programma della Scolastica
nel suo libro Cur Deus homo? il
secondo, la sintesi di essa e di tutta la filosofia medievale nella Summa theologica, e segnano, l'uno,
l'aprirsi, l'altro il culminare della curva immensa tracciata dal pensiero
speculativo dei Dottori della Chiesa a circoscrivere entro i limiti del credo di lei tutto il mondo della
coscienza, della società e della storia.
Tra i termini
storici segnati da codesti due grandi nomi italiani tra la seconda metà del
secolo XI e quella del XIII stanno la giovinezza e la maturità della
Scolastica. Nel primo periodo storico quell'accordo tra il contenuto del
Cristianesimo e la forma nazionale che essa cerca di soprapporgli per trarne
fuori un sistema d'idee ordinato e ben definito, comincia nel credo ut intelligam, (io credo per
comprendere) di sant'Anselmo, e muove dalla sua celebre dimostrazione
dell'esistenza di Dio e dall'interpretazione filosofica che egli dà del dogma
della Trinità e di quello dell'Incarnazione. Nel secondo periodo, che comincia
col secolo XIII e con Alessandro d'Hales e Alberto Magno, maestro di san
Tomaso, il sistema della Scolastica si svolge intero in una sintesi immensa (Summa), la quale comprende tutti i
possibili punti di contatto che l'arte dialettica ormai adulta ha saputo
trovare e fissare tra il domma e la ragione che cerca di compenetrarlo di sè,
senza però, si badi, alterarne di un atomo i dati e i presupposti fondamentali.
Al di là
dell'unico centro, se posso dir così, d'equilibrio tra il peso di codesti dati
del domma, che prevarrebbe da sè, e quello della ragione che vuole invece
preponderare lei - centro che il sistema di san Tommaso ha saputo trovare
secondo i criterii de' suoi tempi e su cui, come su taglio sottilissimo di
squisita bilancia da saggiatore, egli riuscì a far gravitare una mole d'idee
che stupisce - non sarà poi possibile al pensiero medievale spostarsi di un
punto di più senza che codesto equilibrio sapiente si alteri, il dissidio tra
il domma e la ragione filosofica, fatta sempre più esigente, diventi
inconciliabile e la fede sia rimandata nel proprio campo, e il pensiero laico
già nascente seguiti da sè senza tutela il suo cammino verso il Rinascimento.
E notate.
Questo spirito intimo di critica e di libertà d'esame del contenuto del domma,
che poi sul finire della Scolastica (nella seconda metà del secolo XIV) cresce
ed attira a sè quanto di forza viva delle menti si va ormai ritirando da lei,
s'era già mostrato in germe ne' filosofi che l'avevano iniziata, specie nel
primo e in uno dei più arditi tra tutti, in Scoto Erigena, che per uno strano
caso pare abbia avuto comune la razza e la patria (l'Irlanda) con Giovanni Duns
Scoto, col grande avversario dei Tomisti, dalle cui dottrine comincia poi la
dissoluzione finale della Scolastica.
Vissuto nel IX
secolo dopo la grande restaurazione delle scuole medievali fatta da Carlomagno,
e educato in quelle irlandesi che allora serbarono maggiori elementi di cultura
e ne fecero parte anche a noi, l'Erigena aveva ne' suoi cinque libri De Divisione naturae concepito la
creazione, al modo degli Alessandrini e sulle orme del falso Dionigi
Areopagita, come una grande scala di emanazioni digradanti dall'alto dell'unità
primitiva e divina, che tutto accoglie in sè, giù giù per classi di esseri
sempre men generali ed estesi, dagli universali dei generi superiori esistenti
in sè, alle specie, poi agli individui e alle proprietà loro; in quello stesso
ordine in cui nella nostra mente, lungo la scala dell'astrazione, le idee più
generali e più semplici precedono le particolari e complesse.
Così s'era
accennata e spuntava proprio alla radice del sistema della Scolastica per poi
aduggiarlo tutto di una vegetazione di dispute senza fine, quella dei Realisti e dei Nominalisti. Essa doveva prendere occasione da un celebre passo
dell'Introduzione di Porfirio alla Logica d'Aristotele, tradotto da Boezio,
ove è detto «di non voler affermar nulla de' generi e delle specie,
della differenza, della proprietà, degli accidenti, se siano o no sostanze, o esistano solo nelle menti, se
siano o no cose corporee, e se siano separate dagli oggetti sensibili o invece
non separabili da questi.» A tale questione avevano già accennato l'Erigena e i
primi scolastici, ma essa sorse poi e crebbe sempre più per un intimo bisogno
che il pensiero umano ha sentito in tutti i tempi di proiettare al di fuori di
sè l'ombra di sè stesso e dei suoi processi mentali, dandole quasi corpo e
solidità nelle cose e sostituendo ad esse le idee, le astrazioni. È in fondo la
stessa concezione idealistica della natura che faceva dire a Benedetto Spinoza
«l'ordine delle idee va di pari passo con l'ordine delle cose.» Essa è stata in
ogni tempo, anche in tempi prossimi a noi, in filosofia l'analogo di quello che
nelle religioni dei popoli primitivi e fanciulli è l'animazione della natura,
embrione rozzo dello spiritismo. Essa
fa di Scoto Erigena uno dei più arditi precursori dei grandi panteisti moderni
tedeschi, degli Schelling, degli Hegel.
Ma non tutti i realisti trasportavano l'ordine e il
processo delle idee astratte nella realtà dando loro natura di sostanze e di
essenze, preesistenti o almeno superiori per grado o per gerarchia di potenza
causale alle cose particolari e concrete. Così pensavano i realisti estremi platoneggianti, che poi scrissero sulla loro
bandiera: universalia ante rem.
Ma i realisti temperati - scusatemi,
signori e signore, se io vi debbo portare ancora per qualche momento con me
traverso il prunaio di questa terminologia, non più noiosa però nè più vana di
certe terminologie delle infinite parti parlamentari d'oggi - i realisti temperati professavano la
dottrina aristotelica che le idee universali (essere, sostanza, causa, ecc.)
hanno bensì come tali esistenza reale, ma solo, diremmo, incorporata negli
individui e combattevano sotto questa parola d'ordine: gli universali sono
nelle cose: universalia in re. La
dottrina nominalistica sosteneva
invece non darsi esistenza reale che degli individui; le specie e i generi
essere non altro che forme comuni astratte di concepire e di designare collo
stesso vocabolo i punti e le proprietà simili di più oggetti individuali date a
noi dall'esperienza e dall'osservazione: essere, in altre parole, concetti e
nome di classi. E secondo che alcuni tra i nominalisti
si riferivano alla esistenza del concetto astratto delle somiglianze nella
nostra mente, si dissero concettuali (dottrina
a cui si avvicinò Abelardo); e secondo che non ammettevano altro di comune tra
le cose raccolte in classi generali che il nome, si chiamarono nominalisti veri e propri. Gli uni e gli
altri ebbero per grido di battaglia: universalia
post rem; gli universali sono dopo le cose.
Se non che
questa controversia famosa, che è come il nodo primo di tutte le altre infinite
delle scuole medievali, non scende nel campo aperto di queste e non vi porta
con sè schiere di dialettici, armeggianti l'una contro l'altra a colpi di
sillogismo e qualche volta anche di pugnale, se non assai più tardi, alla metà
del secolo XI. Allora Roscellino, un bretone, il Maestro d'Abelardo,
l'avversario di sant'Anselmo d'Aosta, espresse a voce dottrine che contro il
suo volere lo fecero designare dalla Chiesa e condannare come capo di una setta
di nominalisti. Anselmo col patos eloquente dei grandi dottori
cristiani, lo chiama eretico della
dialettica, e vedremo perchè. Guglielmo di Champeaux, suo discepolo, nato
nel 1070, morto nel 1121, vescovo di Chalons sur Marne, amico del gran Bernardo
da Chiaravalle, contrappose a quella di Roscellino una dottrina realistica che
faceva contenuta tutta l'essenza comune del genere in ogni individuo. Il quale
non veniva così per lui a distinguersi dagli altri che per mere varietà
accidentali; in modo che - gli opponeva Abelardo - una stessa sostanza presente
tutta in individui diversi avrebbe perciò attributi repugnanti fra loro. La
stessa cosa, la stessa sostanza verrebbe allora a trovarsi presente nel tempo
stesso in luoghi diversi. «Se tutto l'essere dell'uomo esiste in Socrate, non
esisterà in chi non è Socrate. Ma, siccome esiste anche in Platone, così ne
seguirebbe che Platone sarebbe Socrate, e che Socrate si troverebbe in un solo
e medesimo momento anche là dove è Platone.» Se - giudicatene voi, o signore, -
se Abelardo non avesse avuto per innamorare Eloisa ragioni e discorsi un po'
più attraenti di questi, c'è da credere che egli non sarebbe riuscito a farla
sua. Perchè, è vero, anche il cuore ha pure a momenti la sua logica, ma è di
quelle con cui la filosofia e qualche volta anche, pur troppo! il buon senso
non hanno proprio nulla da fare.
Sottigliezze
dunque che ci fanno sorridere e pure chiudono in sè in germe dottrine che anche
oggi dividono pensatori acutissimi e positivi. Per esempio, la opinione
sostenuta dallo Stuart Mill nella sua classica Logica che le idee universali e persino i principii supremi della
nostra mente siano ottenuti solo per associazione e per astrazione di elementi
simili raccolti poi e fissati nel concetto soggettivo, designato o, come dicono
i logici inglesi, connotato nel
vocabolo, nel termine generale, è un vero e proprio nominalismo. Ma tornando
agli scolastici, il sorriso ci cessa sulle labbra subito, e se si pensa quanta
serietà, quanta importanza aveva per quelle menti e quelle anime dominate da
una fede potente, l'intimo motivo teologico e religioso che era travestito
sotto le strane forme di quei problemi. È che tutta quella vegetazione
apparentemente così vana di fronde dialettiche poteva celare, celava spesso un
verme velenoso per le anime. L'eresia vi strisciava dentro. Nelle varie forme
di soluzioni di una questione, che poteva parere delle più innocenti, si
aprivano vie diverse che potevan riuscire a interpretazioni non ortodosse dei
misteri del Cristianesimo, tra gli altri di quelli dell'Eucarestia e della
Trinità. Codeste interpretazioni avevano avuto quasi tutte i loro antecedenti
nelle sette combattute dai Padri della Chiesa. Ma poichè si ripetevano e in
forme nuove secondo i tempi, i Dottori proseguivano l'opera dei Padri,
confermavano e fissavano con nuove determinazioni razionali il senso del domma
per sottrarlo alle fluttuazioni pericolose delle opinioni individuali. E questa
parte, sostenuta più in ispecie dai grandi scolastici italiani, da sant'Anselmo
a san Tommaso contro gli eretici della
dialettica, è più che due terzi forse della grande opera storica,
disciplinatrice delle menti, compiuta dalla scolastica.
Ne abbiamo un
esempio a proposito del nominalismo di
Roscellino, nella fiera polemica sostenuta contro di lui da sant'Anselmo
d'Aosta. Una conseguenza del nominalismo,
per cui solo gli individui esistono nella realtà, era che le tre persone della
Trinità dovessero esser pensate come tre sostanze individuali e quindi come tre
dei, tre eterni, diceva Roscellino. Anselmo sosteneva la realtà eterna e
l'unità sostanziale dell'essere divino e diceva: «Chi non comprende come più
uomini siano nella unità della loro specie un uomo solo, come potrà capire in
che modo nel mistero della natura divina più persone, ciascuna delle quali è
Dio, siano un Dio solo? E chi ha mente così oscurata da non discernere che il
proprio cavallo non è il color suo, come potrà arrivare a distinguere l'essere
unico di Dio dalla pluralità di relazione tra le persone divine?» L'ironia qui,
come vedete, tocca quasi la satira.
La
preoccupazione assidua, insistente, l'idea fissa della tradizione scolastica
medievale era dunque, o signori, questa: serbare intatto nell'artificioso
tessuto di argomentazioni, a cui collaboravano migliaia d'intelletti fatti più
acuti dal raccoglimento forzato della vita claustrale, l'ordito su cui quella
tela sottile e pericolosa doveva esser condotta, dato dalla fede che era il
sostegno delle coscienze e di tutto l'edifizio sociale e civile dei tempi. E le
difficoltà e i rischi di cotesto geloso lavoro di forma razionale su una
materia già data e intangibile, erano centuplicati dall'intrecciarsi che
facevano con quell'ordito di dommi fila maestre di tutt'altra materia. Poichè
accanto all'autorità della fede e dei libri santi ce ne era un'altra, che
faceva essa pure da testo, quella della tradizione dei filosofi antichi e
specie di Aristotele. Era un'autorità già di per sè stessa repugnante almeno in
gran parte all'altra, resa poi per di più incerta, oscura, disputabile da quel
pochissimo che nell'occidente d'Europa durante la prima parte del medio evo era
restato vivo degli scritti dei filosofi antichi. Di Platone non era
sopravvissuta che una parte del Timeo
nella traduzione di Calcidio, e i
lineamenti veri delle sue dottrine trasparivano appena agli occhi degli
studiosi di sotto alle ombre e ai ritocchi che vi avevan fatto i neoplatonici e
sant'Agostino. Degli scritti logici di Aristotele non furon conosciuti fin
quasi alla metà del XII secolo che le Categorie
e l'Interpretazione tradotte da
Boezio. I libri degli Analitici e la Topica furon diffusi a poco a poco in
occidente dal 1128 in poi, quelli della Metafisica,
della Fisica e dell'Etica ci furono
fatti conoscere prima dagli Arabi e dagli Ebrei, poi il testo ne fu portato da
Costantinopoli, e se ne fece una traduzione latina che però non fu per lungo
tempo apprezzata più delle altre condotte sui testi arabi. Solo dopo che è
venuto a poco a poco in contatto più largo con la forma della grande tradizione
filosofica antica, alla cui efficacia, sebbene modificata profondamente dal
Cristianesimo, la cultura medievale non riesce a sottrarsi, l'organismo della
Scolastica si spiega tutto in un sistema di dottrine che abbracciano ogni parte
della filosofia e Alberto Magno e san Tommaso scrivono le loro Summæ.
La Scolastica
vien su così a un tempo col crescere e coll'allargarsi di quel primo moto di
coltura comune a gran parte d'Europa destato nel nono secolo dalla dominazione
mezzo feudale e teocratica di Carlo Magno. E anche dopo che le forze
dell'Impero si accentrano in mano ai Tedeschi, resta per un pezzo viva in
quelli che erano stati i maggiori focolari di codesta coltura, nei paesi di
stirpe anglo-sassone e franca. Solo più tardi si estende maggiormente fra i
popoli latini e germanici, e così prima come poi non esce dalle mani del clero.
Guardata tutta insieme, essa è la più grande collaborazione intellettuale che
forse abbia mai avuto la storia, e nasce dal bisogno, sentito allora da tutta
la società medievale, di raziocinare il domma, di comporlo a dottrina, in una
forma in cui la mente comune a quella società avesse potuto adagiarsi tutta
d'accordo con le condizioni sociali e morali de' tempi, con tutti i suoi abiti
tradizionali di pensiero e di sentimento.
Mai forse un
codice di legislazione più stretta e più inflessibile nei suoi principii fu
accettato da menti umane, e in tempi più repugnanti da ogni legislazione ne'
costumi e nella vita; tempi in cui se l'individualità vera del lavoro e della
produzione intellettuale non si può dire ancora apparsa, come nota il Burckhardt,
in quella forma che poi prende ne' tempi moderni, era però in pieno rigoglio di
vita un'altra individualità, la barbarica, ribelle a ogni altro freno così del
pensare come del sentire che essa stessa non avesse provato il bisogno
d'imporsi da sè. Ora un tal freno in età, così propensa com'era quella alla
fede, non poteva esser dato se non da un grande sistema d'idee religiose
assolute, inflessibili, ferree, in cui la mente di lei, come in una pesante
cotta di maglia, che noi non potremmo nè anche più alzare, si moveva spedita e
ne prendeva anzi nell'opera una dirittura rigida e quasi ferrata, un impeto
come di braccio che, appunto perchè tutto coperto di acciaio, ripiombi più
pesante. Il chiudersi in una autorità creduta infallibile era così proprio a
quelle menti, che persino i ribelli alla Chiesa, gli eretici, gli scolastici
dissenzienti, e non furono pochi, rinnegavano un'autorità in nome di un'altra.
Tra gli scolastici i primi in specie, meno stretti alle parole e alle decisioni
della Chiesa, che non quelli del periodo successivo e dell'ultimo, si appellano
pure quasi tutti all'autorità de' Padri e la mettono a pari con quella delle
scritture, anche là dove i maggiori tra i Padri esercitavano gli uni contro gli
altri una grande libertà d'esame.
Chi comprenda
bene in tutto il suo valore storico la grande egemonia che la Chiesa romana
esercitò su tutta la società medievale, specie dopo la riforma dei chiostri e
il trionfo del potere teocratico contro l'Impero, comprenderà come e perchè il
moto delle dottrine scolastiche abbia finito con l'essere astratto in ogni sua
parte nell'orbita dell'unità del pensiero e della tradizione della Chiesa. Essa
rappresentava nel processo storico della sua formazione la necessità fatale del
convergere di tutte le forze e di tutti gli ideali del Cristianesimo a un'unità
organica di tipo vitale, da cui il bisogno del conservarsi, intimo alle
istituzioni come ai corpi, doveva spingerlo a non deviar mai. E perciò la
Chiesa con l'autorità immensa che le veniva da un istinto, dirò così, di
altissimo buon senso religioso, aveva
nel suo primo svolgimento storico escluse da sè o contenute per mano dei Padri
le forze eccentriche che avrebbero portato l'organismo della fede al di fuori
del tipo storico più atto a farla vivere. E così ora con l'autorità dei Dottori
recide da sè le eresie, le sette che contraddicono a codesto tipo, e sopra
tutto contiene, tra le forze più vive che esso chiude in sè, quello che vien
più dalla sua radice e che lo alimenta più, ma che anche potrebbe farlo più deviare.
È la forza della libera ispirazione del sentimento mistico individuale, intima
alla primitiva coscienza cristiana e dominante nelle prime comunità
apostoliche, continuata poi sempre lungo tutto il medio evo per una via sua,
accanto e sotto la rigida unità della tradizione ecclesiastica, come corrente
sottomarina che poi sboccherà fuori irresistibile nella Riforma.
Ora anche
questa grande forza, che nelle sette medievali - ve ne ha discorso il mio amico
Felice Tocco - devia dal tipo storico centrale della tradizione della Chiesa,
ci apparisce invece disciplinata sotto la forte unità della Scolastica in
quella delle sue due principali direzioni che è stata chiamata mistica, appunto perchè in essa valse
come impulso e come guida unica al vero e alla salute, non, come nell'altra, il
pensiero metodico, raziocinante, ma il sentimento ascetico, l'ispirazione, il
rapimento dell'estasi, l'impeto dell'assorbimento, e, come dicevano, della
morte in Dio.
È la direzione
tracciata in tutto il secolo duodecimo alle menti avide di spiritualità e a cui
i grandi pensieri, i pensieri migliori venivano,
direbbe Chamfort, dal cuore, nella
scuola di san Bernardo di Chiaravalle (1091-1153), del grande avversario di
Abelardo, e da Ugo e da Riccardo di San Vittore. Per san Bernardo la maggior
beatitudine umana è nel misterioso ascendere dell'anima verso il cielo, nel suo
rimpatriare da questo carcere del corpo nella pura regione degli spiriti,
nell'abbandonarsi e perdersi in Dio. Solo per questa via, egli pensava, nella
quale però l'anima non entra se non per dono della Grazia, ci si può immergere
fino alle profondità più inesplorate del vero ed esser rapiti al di fuori di
noi.
Ugo da San
Vittore diceva: la incorrotta verità
delle cose non potersi trovare per via di ragionamento. E per lui e per
Riccardo si distinguono tre forme di attività della cognizione: la cogitazione,
rispondente all'immaginare, e che ha per termine le cose sensibili, la
meditazione e il discorso della mente che passa di concetto in concetto, e la
contemplazione che senza moto d'idee coglie in sè l'oggetto della mente in modo
immediato. La contemplazione ha più gradi e nel più alto di tutti, ch'è sopra la ragione ed è quanto
all'intensità un'alenatio mentis, lo
spirito s'incontra faccia faccia cogli arcani che oltrepassano ogni nostra
potenza conoscitiva e col massimo tra questi, col mistero della Trinità.
Ricordate, o signori, la fine stupenda del paradiso di Dante, quando egli è sul
punto d'immergersi nel mistero della visione di Dio, e
«all'alta fantasia qui mancò possa?»
E non molto
prima il poeta aveva veduto tra gli spiriti, accolti intorno a quello di
Tommaso d'Aquino, anche «la luce» di Bonaventura da Bagnorea (1221-1274), del
grande mistico francescano, che nella storia della Scolastica fa parte di
questa famiglia di spiriti serafici, di sublimi visionari della filosofia, e
nel Soliloquio, che è un dialogo
dell'uomo con l'anima sua, va dietro ad Ugo, nell'Itinerario della mente in Dio segue le orme di Riccardo di San
Vittore e nelle meditazioni mistiche
sulla vita di Cristo rammenta san Bernardo di Chiaravalle.
San Bonaventura
si serbò per altro con temperanza e con equilibrio grande di mente scevro dagli
eccessi più pericolosi del misticismo. Sebbene, come tutti gli scolastici del
suo tempo, abbia subito l'efficacia dell'aristotelismo, contrappose però ad
Aristotele Platone, la cui dottrina gli parve più conciliabile con quella della
Chiesa; professò come ideale della vita altamente cristiana, la povertà e la
renunzia ascetica, ma non ne fece obbligo a tutti, bastando pei più il primo
grado della virtù che sta nell'osservanza dei precetti della religione. Così
egli espresse anche nell'indirizzo delle sue dottrine quel sano intuito del
giusto mezzo serbato dal moto francescano fra le follie ascetiche di altre
riforme predicate nel medio evo e dopo, e le astuzie e i compromessi pratici in
cui poi andarono a sviarsi nel loro troppo intimo contatto con la vita e la
politica altri ordini religiosi sorti a difesa della Chiesa nella grande
restaurazione cattolica nel secolo XVI. Il moto francescano, che meritò dal
Machiavelli, lodatore non sospetto, l'elogio di aver salvata la Chiesa caduta
un'altra volta abbasso nel secolo XIII, riuscì in tutto il suo complesso, se
non guardiamo agli eccessi tanto meno evitabili nelle cose umane quanto più
esse hanno dell'eroico, opera di alto senno e di pensiero civile nella vita
morale del clero e del popolo italiano d'allora; fu per certi rispetti un metodismo italiano, ma con questo di
più dell'inglese: con l'impulso, coll'ispirazione potente che esso diede alla
spiritualità della letteratura e dell'arte nostra. Ernesto Renan ha dimostrato
come le profezie e le aberrazioni mistiche apocalittiche dell'Evangelo eterno siano nate nel secolo
XIII, ed abbiano preso alimento anche dopo solo dalla parte più esaltata
dell'ordine francescano, che dopo la morte del fondatore interpretò a modo suo
il pensiero ispiratore delle riforme di lui. E del resto, anche fatta la loro
parte a tutti gli eccessi dei mistici francescani, basterebbero a farceli
dimenticare e quasi benedire le pure idealità dei dipinti di Giotto in Assisi e
la prosa dei Fioretti e il canto del Paradiso, ove Dante esalta san
Francesco, sposo della povertà. Di
questa vena di sentimento mistico, che sgorga dal fondo primitivo della
coscienza cristiana, sono in tutto il medio evo e poi derivazione e
continuazione tanti libri ascetici, il cui modello più squisito resterà sempre
il libro dell'Imitazione di Cristo;
libri cercati ormai da pochi, ma destinati però ad aver sempre lettori, perchè
rispondono ad uno stato dell'anima umana, che, a leggerli, fa loro quasi da
sfondo; come, o signori, alla dolcezza indefinibile di certe Madonne e di certi
santi del Perugino e di Raffaello e di Leonardo fanno da sfondo quelle cerulee
lontananze di paesaggi umbri, appena appena ondulati, corse da fili d'acque
chiare, seminate di betule sottilissime e ove si sente che a certi giorni anche
a chi non ama la vita deve parere un sollievo il passarla a meditare. Sono di
quelle vedute delle quali Enrico Federigo Amiel, uno scettico della stessa
famiglia di quei mistici medievali, nel suo ammirabile Journal intime diceva così bene: «Questo paesaggio è uno stato
dell'anima.»
Io vi confesso,
o signori, che ho provato sempre un'intima simpatia per queste grandi anime
mistiche piene di visioni, per questi ammalati
di Dio. Oggi molti incontrandoli nella storia, li guardano con compassione
perchè, dicono, hanno del malato, non spirano in sè forza. Di questa parola si
abusa oggi quasi più che non si sia abusato sempre della cosa che essa
significa. Io ho paura che noi ora per un eccesso di reazione ai languori del
romanticismo, rischiamo un po' troppo di prendere per unico tipo di forza
l'Ercole Farnese; di scambiare la viva, la ricca energia del carattere con
l'aridità del cuore e del sentimento; ho paura che dimentichiamo nei nostri
ideali d'educazione troppo positiva come il voler chiudere tutto l'uomo in
certe nostre formule date, non riesca ne' più de' casi che ad immiserirlo, e
che anche da giovanetti visionari, pieni d'idealità, quali erano Aurelio
Agostino e il Dante della Vita Nuova, son venuti su uomini di vigore
indomabile, tanto più atti a trasfonder sè stessi negli altri, quanto più
accoglievano nell'animo una potenza più ricca, più varia e feconda di elementi
umani. Il secolo XVII non vide caratteri più virili e più forti di quelli degli
asceti e dei mistici solitari di Porto
Reale che, come nota il Renan, attingevano vigore e fermezza appunto in
quel tetro concetto della fatalità della Grazia da cui erano dominati.
Ma, o signori,
è anche vero che le grandi idealità del sentimento e l'intimità della
ispirazione mistica non potrebbero avere una parte troppo larga nella coltura e
nella vita di un popolo senza scemargli nerbo e sicurezza d'intuito del vero e
della realtà. Gli eccessi e le utopie di riforma predicate dalle sette
cristiane medievali avrebbero sovvertito l'ordine civile e la Chiesa, ed essa
non terrebbe anche nella storia delle idee e della filosofia e della politica
di quel tempo, cogli effetti di quella forte disciplina accentratrice che seppe
portare nel regime delle menti, il luogo che certo le spetta, se l'ideale dei
suoi santi e dei suoi filosofi, dei suoi uomini rappresentativi, come li
chiamerebbe l'Emerson, fosse stato quel frate dei Fioretti che vive sempre rapito in contemplazioni, occupato sempre
di sante inezie e che per vilificarsi
si mette una volta per strada a girare sopra sè stesso tanto da cadere per
terra preso dal capogiro. A queste follie sacre resiste sempre la parte sana
delle tradizione ecclesiastica, che ispira tutta la filosofia medievale, e che
come ha i suoi impulsi quasi sempre da Roma, così prende più che altro impronta
da ingegni e da menti italiane. Al misticismo degli asceti e dei visionari che
essa non respinge, ma contiene in giusti limiti, la Chiesa coi suoi maggiori
rappresentanti in filosofia contrappone quello che ho già chiamato qui un alto
buon senso religioso. Esso è la regola sottintesa da cui prende norma il
temperato razionalismo (così lo chiamano parecchi storici della filosofia)
professato con differenze non sostanziali dai due sommi scolastici italiani, da
sant'Anselmo e da san Tommaso.
Il primo
ammette che la fede preceda la ragione e determini coi suoi principii i punti,
da cui alla ricerca del vero la mente umana non può deviare affidata solo alle
proprie forze, ma concede molto anche a queste, e come nel suo famoso argomento ontologico sull'esistenza di
Dio vuol dimostrare che la realtà d'un essere del quale non può pensarsi il maggiore, è implicita necessariamente
nel concetto che ne ha ogni uomo, così nel suo scritto il Monologio si appoggia a sole prove di ragione per costruirvi sopra
la dottrina teologica della Trinità e
nell'altro libro Cur Deus homo? cerca
di dar forma razionale a quella della Redenzione.
In questo libro che è, dice Kuno Fischer, il programma della Scolastica, sant'Anselmo sostituisce
all'antico e rozzo concetto, che anche alcuni Padri avevano della Redenzione, quasi di un riscatto delle anime umane ritolte da
Dio al demonio, il concetto giuridico di una soddisfazione, che non poteva esser data alla giustizia divina se
non dai meriti infiniti di Cristo, offertosi per ciò a morte in luogo
dell'uomo, insufficiente per parte sua a riparare l'offesa infinita della colpa
d'origine. È la dottrina che poi la Chiesa ha fatta sua[16].
Da sant'Anselmo
d'Aosta, che anche prima di Abelardo applica la dialettica ai dommi
fondamentali della fede, sino a Pier Lombardo, il maestro delle sentenze,
autore della celebre Somma, rimasta
per secoli nelle scuole come libro di testo per la teologia; da Alessandro di
Hales ad Alberto Magno, che la fanno entrar tutta poco a poco, pure eccettuando
sempre alcuni dommi, nella forma della dimostrazione metodica, e aprono e
segnano così, specie il secondo, la via a san Tommaso; la Scolastica, in questa
sua elaborazione più che secolare di tanto materiale d'idee su un disegno che
esce a poco a poco dall'opera di molte menti, fa pensare a una di quelle grandi
cattedrali del medio evo, lavoro di più generazioni d'operai e di capimastri e
di artisti, condotto non col rigore di un disegno unico, ma con unità e
continuità d'ispirazione e di fede comune, e che vien su lento sino a che sorge
il grande architetto che lo corona e ne volta la cupola immensa. Agli archi più
antichi, più aerei e, direi così, più ideali di questo grande duomo delle menti
medievali, ove esse non potevano entrare a pensare se non dopo aver pregato,
aveva fatto da céntina l'idealismo platonico. Più tardi, e più specie nella
Somma di san Tommaso, alla curva gigantesca e massiccia di tutto il sistema
della teologia voltato da lui, fa invece da céntina quello di Aristotele,
interpretato dagli Arabi, e che con la sua concezione della natura, ascendente
tutta di forma in forma verso l'atto puro, verso l'intelletto primo che tutto muove, si adatta più al
senso della dottrina teistica della Chiesa, e in questo suo prestarsi a lei ne
esce trasformato. E da vero la costruzione della Somma di san Tommaso per l'ampiezza, per l'eleganza delle linee
nella distribuzione delle grandi masse d'idee che ha in sè, non meno che pel
lavoro finissimo di ricamo intellettuale con cui ne sono trattate le parti, è
una grande e mirabile opera d'arte. Concepita da un ingegno religiosissimo e
vôlto per abito di disciplina potente più a confermare con la ragione e a
comprendere ciò che allora si credeva che ad innovare, essa, per quanto ora non
basti più al nostro pensiero, è uno tra i maggiori esempi del come tutto un
mondo d'idee in cui si è mossa e ha respirato l'intelligenza di una società e
di un'epoca intera, abbia potuto passare traverso una sola mente e imprimersene
tutto e prenderne in ogni parte forma, ordine, misura, trasparenza razionale.
Stupisce e spaventa l'acume con cui il santo, divenuto a un tratto di
architetto grande quasi intarsiatore e miniatore d'idee, penetra nelle parti
più profonde ed ardue del domma, - per esempio, nel concetto della Concezione
Immacolata di Maria - e rasenta di un pelo il punto, oltre il quale si vede che
mente d'uomo non potrà più seguirlo. E pure egli è così cauto, così equilibrato
sempre! Le asperità di alcuni dei dommi più tremendi del Cristianesimo
primitivo, tra gli altri di quello agostiniano della predestinazione, sono
temperati da lui con la scorta del grande buon senso della tradizione
ecclesiastica, che oramai, pur senz'aver l'aria di piegarsi, si adatta alle
nuove esigenze dei tempi mutati. Il rigore del concetto indeterministico dell'assoluto arbitrio divino, a cui più tardi si
spingeranno Duns Scoto e i Nominalisti, preparando così la fine della Scolastica, cede nella Somma al concetto più razionale del
determinarsi del volere in armonia con l'intelletto divino all'atto del creare
le cose. Nel vasto disegno del sistema la natura apparisce tutta, dice il
Fischer, come un ordine di gradi che salgono verso l'ordine soprannaturale
della Grazia compartita nei Sacramenti, e l'estro religioso del
teologo tocca il colmo nel trattato sulla natura degli angeli, che a leggerlo
fa venire le vertigini. Ma nelle altre parti della dottrina tomistica, e
specialmente in quelle relative all'uomo e alla vita civile e politica, spicca
una temperanza e un senso pratico, degno d'un uomo d'azione più che d'un
teologo e di un frate.
È che, o
signori, egli aveva in sè una vena di grande uomo d'azione e di fine
conoscitore delle cose e della vita; ingegno che ebbe forse in sè per eredità
qualche goccia di sangue normanno e tedesco, ma che sopratutto teneva dalla
tempra fra latina e italo-greca delle menti meridionali la vivacità potente e
l'ampiezza dell'immaginativa filosofica temperata da un intimo senso di misura
e di intuito del vero umano. Ingegno, lasciatemelo dire un'altra volta,
italiano nel più alto senso della parola, affine più che non paia a prima
vista, a quello dell'Alighieri, di cui una delle qualità dominanti è il saper
sempre tener fermo il piede nel vero anche quando sembra spingersi più alto con
la fantasia, sapere all'ampiezza e alla profondità della concezione speculativa
far rispondere sempre la determinatezza scultoria della visione poetica. Voi
sapete quanto Dante, che si può chiamare il poeta della Scolastica, debba alle
dottrine di san Tommaso; Dante che attinse ispirazioni e immagini da Boezio e
nel concetto e nella distribuzione delle pene prese molto da Aristotele, ma la
filosofia di Aristotele e gran parte della cosmologia e tutta la teologia del
poema e massime il Paradiso concepì
con la mente di san Tommaso, e quasi direi lucidò dal disegno della Somma.
E ora noi, o
signori, giunti così a Dante, cioè alla seconda metà del secolo XIII, quando
con l'opposizione di Duns Scoto e della sua scuola alle dottrine di san Tommaso
s'inizia quel moto di scissura assoluta tra la ragione e la teologia dommatica,
che poi farà morire la filosofia medievale, noi ora qui ci arrestiamo. Dante
che, come nota bene Giosuè Carducci, osò nel Convito e anche nella Commedia
trarre la filosofia dalle scuole religiose e introdurla nella vita civile, apre
o almeno prenunzia, non fosse che con questa delle sue grandi iniziative, i
tempi nuovi. E pure egli è ancora alle origini, è sull'alba della nostra
letteratura, ma vi spunta come un sole che appena comparso la fa splendere più
che se fosse un pieno meriggio.
Nella
scolastica e nella teologia si accentrava tutta la scienza medievale dominata
in ogni sua parte dall'idea religiosa. Qualche barlume di notizie e di cose e
di fatti naturali apparisce pure qua e là a mano a mano che, per opera più che
altro dei nostri viaggiatori, si comincia a diradare un po' l'ombra da cui era
stata avvolta la scienza della natura in quell'alienarsi dell'intelletto umano
dall'esperienza e dall'osservazione diretta dei fatti. Ma quanto fosse povero e
misto d'errori e di favole puerili il contenuto delle cognizioni positive anche
nel secolo XIII, basta a mostrarlo il Tesoro
di Brunetto Latini, maestro di Dante,
che attinse alle enciclopedie scientifiche più in onore a quei tempi, specie
allo Speculum majus di Vincenzo di
Beauvais, all'Image du monde di
Gautier de Metz; basta a mostrarlo lo strano libro di Ristoro d'Arezzo sulla Composizione del Mondo. Ingegni larghi e
comprensivi come quello di Alberto Magno, divinatori come quello di Rogero
Bacone, poterono abbracciare tutta la scienza naturale del tempo, e il grande
monaco inglese potè proclamare la necessità dell'esperimento in Fisica e
accennare a scoperte fatte più secoli dopo. Ma la via per cui era ormai
l'intelletto de' tempi loro era tutt'altra, e doveva esser percorsa tutta prima
che alla grande voltata storica del Rinascimento apparisse già in cospetto
l'età moderna.
E a ogni modo
fatta pure una giusta parte a quello che le prime iniziative intellettuali dei
nostri anche nelle scienze esatte - Leonardo Fibonacci è dei primi del duecento
- possono avere anticipato delle scoperte e del sapere venuto poi, valore e
importanza vera per la storia della nostra coltura filosofica non ha nel tempo
a cui ho accennato se non solo quel tanto dell'opera della mente italiana che
si spende nell'imprimere un forte indirizzo di accentramento e di disciplina
tradizionale alla Scolastica. Lasciate che prima di finire io richiami ancora
la vostra attenzione su questo fatto: lo
spirito del popolo italiano novatore a un tempo e conservativo, come lo
disse Giosuè Carducci, si mostra già con fisonomia tutta sua nel sorgere della
nostra coltura anche per ciò, che l'Italia riceve, è vero, nei primi tempi
della Scolastica impulsi e uomini da altri paesi, dall'Irlanda, dalla Francia,
dalla Germania, ma più tardi e nel maggior fiorire di quella dà alla tradizione
centrale ortodossa e alle cattedre di Parigi e agli arcivescovadi inglesi
gl'ingegni più larghi e più sani, gli animi più retti che onorino la Chiesa e
la storia. Fatto notevole che attesta il persistere e il prevalere tra noi
della stirpe e della tradizione latina. Come nei primi svolgimenti delle scuole
del diritto, come più tardi nelle dottrine politiche, così allora nelle
religiose e filosofiche lo spirito italiano, pure osando molto, osò e innovò
con senno moderatore, con un sano e largo e pratico intuito del vero e del
reale; si attenne, affine anche in ciò allo spirito inglese, a quella tra le
parti, l'una in contrasto di ideali con l'altra nella grande tradizione civile
dei popoli, che è stata sempre sicura di aver per sè il consenso della parte
più sana e più vera dell'animo umano. Le utopie settarie, pazze, trascendenti,
che pure han luogo anche nella nostra storia ci vennero quasi tutte di fuori.
Quelle che nacquero tra noi andaron per lo più a dare frutti lontano. Gli
eretici e i visionari esaltati che hanno avuto seguito, sono stati, come
Arnaldo da Brescia, o almeno furon creduti, come il Savonarola, riformatori politici.
Di grandi ribelli gloriosi, avversi all'autorità falsa e tirannica e
all'ignoranza, noi ne abbiamo avuti, se non più, non meno certo di altre
nazioni; ma i più grandi, e, oso dire, i più nostri pel consenso della simpatia
universale che provocarono nella coscienza nazionale, furono intelletti come
Galileo, che ebbero di tutte le facoltà costituitive del genio la più alta
forse di tutte: il sommo del buon senso.
E badate io non
voglio dire che la potenza sublime dell'utopia, l'impeto delle grandi speculazioni,
la idealità e la libertà ispirata della coscienza religiosa che rifà a sè
stessa dal fondo la propria fede, non siano come la parte alata dell'ingegno di
un popolo che lo leva alto là ove col pensiero si respira aria più pura: e che
l'essere finora mancata troppo questa parte alla coscienza religiosa del nostro
popolo sia stato un bene per noi. No, io dico solo che nella storia della
Scolastica l'Italia porta di questo felice contemperarsi d'audacia innovatrice
e di tendenza a conservare e a comprendere, propria al suo grande spirito, la
parte migliore, più sana e più forte che prende persona in uomini come Anselmo
d'Aosta, Tommaso d'Aquino e Dante.
In codesto
tratto di storia corsa da noi, nulla mi par così notevole agli occhi di quella psicologia
della mente d'Europa che si va oggi sempre più formando, come il veder già
disegnarsi sotto la superficie uguale del pensiero scolastico, contenuto
dall'autorità dell'ossequio alla Chiesa, tutte quelle che poi saranno le
correnti più vive del pensiero moderno, e aver già in sè ciascuna il getto
primo di quelle attitudini e abiti di mente nazionali e di razza che poi esse
porteranno seco nella coltura comune d'Europa. La forma d'intelligenza che
Amiel chiamava matematica e che egli
dà ai Francesi, portati sempre ad applicare la logica delle astrazioni a priori alle cose e alla vita, è già
tutta nel concettualismo razionalistico
di Pietro Abelardo, egoista voluttuoso e freddo che fa di sè centro all'amore
per Eloisa ed al mondo, che ragiona e sillogizza la passione e non le si
sacrifica mai, e che rammenta a una certa aria di famiglia un Rousseau o un
Saint Preux o uno Chateaubriand d'allora, come nella sua filosofia ha già i
germi di quella del Cartesio. E quel Rogero Bacone, che ha nella sua cella accanto
al breviario le storte e i fornelli dell'alchimista, che alterna le astrazioni
di uno scolastico e i fervori di un mistico ispirato con le fini osservazioni
analitiche pei fenomeni naturali, è già un precursore dei filosofi e dei
naturalisti inglesi dei secoli XVII e XVIII, spiriti liberissimi e religiosi ad
un tempo, potenti nell'indagine minuta, positiva dei fatti e inclinati a
fantasie idealistiche. E ancora in quell'Eckhart tedesco della seconda metà del
secolo XIII, seguace di Alberto Magno e domenicano anche lui, che modifica in
senso mistico e quasi panteistico la dottrina del suo maestro sull'unità di
spirito dell'anima umana con Dio, e si allontana, se non dalla lettera, dal
senso della tradizione romana che lo condannò; in Eckhart senti già la prima
parola dei riformatori protestanti, senti già i pietisti e balena il misticismo teosofico dello Schelling che
s'ispirò anche da lui. E finalmente, o signori, non vi pare abbia, a un tempo,
e del Don Giovanni e del Don Chisciotte della Scolastica quel Raimondo Lullo
spagnuolo del secolo XIII, autore della fantastica Ars magna? Del quale si racconta che, giovane dissoluto, ardente
negli amori, mentre inseguiva una sera la donna da lui più desiderata persino
sotto gli archi solitari di un chiostro, ella, ad un tratto, s'era voltata e
s'era scoperta parte del seno divorato da un cancro; e allora Lullo lasciando
moglie, figli, ricchezze s'era fatto frate minore; anima fervida di cupo
entusiasmo, intelletto geniale e fantastico di sognatore delirante, tra il mago
e l'apostolo, che percorre l'Europa facendo nelle corti esperienze d'alchimia e
predicando l'insegnamento delle lingue orientali per convertire gl'infedeli, e
va più volte e persino vecchissimo in Terrasanta finchè non ottiene il
martirio.
Di tanto moto
di vita non resta ora nella Scolastica che una tradizione formale di dottrine
quasi ossificata per decrepitezza, e che si ritira più e più in sè da ogni
contatto col pensiero laico dei nostri tempi. La Chiesa però non solo tiene a
questa tradizione ma la vuol viva nelle sue scuole e riattinta sopra tutto alle
dottrine di san Tommaso, di cui una celebre enciclica di Leone XIII
raccomandava lo studio come ritorno desiderabile della mente del clero ai
principii della filosofia cristiana. E la sua parola sembra non sia caduta
vana. I libri dei Padri e dei Dottori scolastici e più in particolare quelli
della tradizione tomistica, seguita nella sostanza anche dai Gesuiti, non
furono, mi si dice, da un pezzo mai così ricercati come ora dagli ecclesiastici,
specie dagli stranieri. Nelle pubbliche vendite che se ne fanno a Roma gli
enormi in folio polverosi di quelle
edizioni vanno via a ruba comprati ad alti prezzi dalle università, dalle
biblioteche dei seminari e delle chiese cattoliche di America, d'Irlanda e di
Germania, che fanno a gara a provvedersene per gli studi dei chierici.
Ma è un vero
risveglio di studi? A molti segni la risposta parrebbe non potere esser dubbia.
L'alto clero romano non solo non compra più libri moderni ma lascia vender gli
antichi; e ogni passo che fa oggi nell'insegnamento filosofico e teologico la
tradizione centrale rappresentata da Roma, è un suo chiudersi sempre più in sè,
è un alienarsi dal laicato e da ogni pur lontano sentore d'idee scientifiche
moderne. Ieri appena uno scrittore, mi pare, della Civiltà Cattolica voleva trovare in san Tommaso persino la chimica.
Se san Tommaso, che ai suoi tempi professò e spinse all'estremo la
compenetrazione delle verità religiose con la ragione, e studiò e riferì con
onestà scrupolosa, in tutta la loro forza, le obiezioni che allora si facevano
alle dottrine ortodosse, se san Tommaso tornasse oggi al mondo, io credo che
riconoscerebbe più di sè stesso e della sua filosofia, in Antonio Rosmini
condannato da Roma, e che solo ai nostri tempi ha ravvivata la Scolastica, e
nel liberale e colto clero di Lombardia suo seguace, che non ne' loro
avversari.
Chi segua con
attenzione i segni dei nostri tempi e delle condizioni morali d'Italia, da
qualunque parte vengano, non può restare indifferente, o signori, a quelli che
danno di sè la coltura e l'indirizzo intellettuale filosofico della Chiesa. Il
problema se e come sia possibile in avvenire una trasformazione delle dottrine
del cattolicismo romano d'accordo col pensiero e coi bisogni morali del laicato
e delle classi più culte; questo problema c'è - chi può negarlo? - ed è dei più
vitali ed importanti tra quelli che s'impongono alla nuova vita e alla
coscienza del nostro paese. L'Italia laica, pensante vi porterà, lo spero, un
giorno o l'altro per risolverlo, non apostasie che sarebbero anacronismi,
contrarie a tutta la nostra tradizione e all'istinto del popolo, non mere
negazioni infeconde, ma molto di quel sano buon
senso pratico che ha pur la parte sua anche in materia di religione.
Poichè, se è vero che le vie di quella fede alta, madre di forti caratteri e di
larghe menti e di moralità operosa, di cui vive ogni popolo grande, non sono
state punto chiuse dalla scienza - la quale respinge più indietro l'arcano
delle cose ma non lo toglie - è anche vero che tra codeste vie la più dritta
sarà sempre quella in cui l'uomo potrà entrare con tutto sè stesso: con in
cuore gli impeti di un'anima credente nel bene e nell'ideale, ma anche con gli
occhi volti alla buona scorta di un sapere largo, rigoroso, disinteressato.
LE ORIGINI DELL'ARTE NUOVA
DI
Enrico
Panzacchi
Signore e Signori!
Io credo di non
ingannarmi affermando che, quando da principio voi conosceste il concetto
generale che doveva ispirare, regolare e contenere in una certa unità le Conferenze
che si sarebbero tenute in questo luogo, la vostra mente volò subito al tema
bello e attraentissimo che la Commissione Direttiva - pur troppo! - volle
affidare a me ed alla mia povera parola, per la quale caldamente invoco tutta
la indulgenza del vostro buon volere. - Ho detto che non credo d'ingannarmi
perchè ho più volte fatto l'esperimento in me e in altri che quando si torna
col pensiero a quei «primi albori» della vita italiana, dopo il lungo letargo
del medio evo, con la nostra immaginazione ci pare subito di sentire come un
soffio caldo e potente di rinnovamento artistico, ci pare di vedere una vasta
rifioritura d'arte che da lontano ci rallegri coi suoi bellissimi colori. - Il
rimanente di quel grandioso e complesso fatto storico che è il rinascimento
italiano, o non lo pensiamo o lo penseremo poi, o lo vediamo come in una
penombra e quasi nei piani inferiori del quadro. Gli storici coscienziosi e
corretti intervengono e ci dicono: ma badate; voi commettete un grande errore
di prospettiva storica! L'arte non è mai, per quanto importante essa sia,
elemento primigenio e principalissimo nel sorgere di una civiltà. Tanto è vero
che vi sono popoli i quali risorsero a nobile vita civile senza arte grande; o
l'ebbero molto più tardi, come gli Inglesi e gli Spagnuoli, o l'ebbero in parca
misura. - Tutto vero, o signore, quello che dicono gli storici; ma è altresì
innegabile una legge dello spirito nostro per la quale noi siamo tratti a
sintetizzare e quasi a simboleggiare tutta un'epoca per certi suoi caratteri
dominanti. Quando pensiamo l'antica Roma, noi vediamo subito fasci consolari e
lotte di patriziato e di plebe, vediamo legioni armate moventi alla conquista
del mondo. - Invece quando pensiamo al risorgimento italico e massime Toscano
dinanzi alla nostra fantasia si delineano subito delle magnifiche fabbriche
marmoree sorgenti in luogo dei tristi manieri medioevali, vediamo per la città
un popolo festante ed orgoglioso del canto dei suoi poeti e dei quadri dei suoi
pittori; pensiamo a Dante Alighieri e a Guido Cavalcanti, a Niccolò Pisano e a
Giotto di Bondone; pensiamo alla Cattedrale di Pisa ed a Santa Maria del Fiore.
Insomma quest'epoca è sintetizzata nell'arte; la bandiera che precedette gli
Italiani nel glorioso loro esodo fuori delle tenebre del medio evo è la
bandiera dell'arte, e senza l'arte il rinascimento italico pare che noi non
potremmo nè spiegarlo, nè immaginarlo.
E di questo
argomento, o signore, io dovrò intrattenervi. Una voce autorevole ed amica mi
ha detto che al mio discorso sono prescritti dei limiti che io non potrò
varcare. Ha detto questa autorevole ed amica voce che muovendo dal medio evo
dovrò fermarmi al dugento, al puro dugento. Quegli stessi avvenimenti i quali,
pure avendo la loro origine cronologica in questo secolo, si svolsero
caratteristicamente e si compierono nel secolo che vien dopo, sono
rigorosamente banditi dal mio discorso.
Io starò a
questo limite. Confesso che così la parte forse più attraente del mio tema
viene ad essere resecata, ma si tratta di un principio ed io piego la fronte,
consolandomi con la memoria di quel detto eroico: perano le colonie ma si
salvino i grandi principii!
Ed anche con
questa limitazione, o signore, il mio tema è vastissimo, sterminato; e io fin
d'ora prevedo che sarà passata l'ora che mi è assegnata per parlare ed io avrò
appena segnato nel vasto quadro qualche linea, avrò appena abbozzato qualche
contorno di figura. - Una ragione di più perchè io, senza altri preamboli,
entri subito nel mio soggetto.
Che cosa è, o
signore, esteticamente parlando, il medio evo? Non si può parlare del risveglio
artistico che si manifestò nel dugento senza risalire, un poco o molto,
all'epoca precedente. Lasciamo da parte le quistioni politiche, sociali,
religiose: limitiamoci a considerare il medio evo nel puro aspetto dell'arte.
Per me, lo dico
subito, il medio evo è un'epoca essenzialmente inestetica. I rivendicatori di
quest'epoca insorgono contro questa mia affermazione e adducono fatti numerosi
e importanti per provare il contrario, ma io credo che essi vadano equivocando
e che confondano il vero medio evo con dei fatti che costituiscono appunto la
negazione e il principio della cessazione di quell'epoca. Figuratevi che vi
sono alcuni i quali mettono fra le glorie del medio evo anche la Divina Commedia! Procedendo di questo
passo, chi sa davvero fin dove si arriva, o signore! E perchè, domando io, non
si comprende ancora il Canzoniere del
Petrarca, il Decamerone del
Boccaccio? Perchè non ancora Poliziano e Leon Battista Alberti, la giovinezza
di Michelangiolo e quella di Leonardo da Vinci? Tanto, se si deve stare alle
nozioni, che impartiscono nelle scuole certi compendi di storia, il medio evo
non cessa se non quando Colombo scopre l'America o i Turchi si decidono a
entrare in Costantinopoli!!
Queste cose i
ragazzi, pur troppo, se le bevono. Ma non è così che si può qualificare
un'epoca; non è entro una delimitazione puramente cronologica che è possibile
confinarla. Bisogna che noi ci portiamo nel fitto, nel cuore di quell'epoca
triste, nel lungo tratto di tempo che va, per esempio, dalla calata dei
Longobardi fino alla prima metà del secolo XI, superati d'appena i terrori del
Mille e le aspettazioni paurose dell'imminente finimondo.
In quest'epoca,
che secondo la tradizione popolare d'accordo col retto criterio storico,
costituisce il vero medio evo, o signore, io non riesco a vedere gli elementi
dell'opera d'arte. - L'opera d'arte degna di questo nome, resulta dall'accordo
di quei certi elementi che, secondo la bella frase di Leonardo da Vinci, formano
una «divina simmetria». Bisogna da un lato che l'idea discenda dalla sua vaga
astrazione e comunque si umanizzi; bisogna, dall'altra parte, che la materia si
elevi e si affini. Da questo umanarsi dell'idea e da questo elevarsi della
materia nasce un accordo, un contatto, magari un urto simpatico che fa scattare
la divina scintilla. - Ora se voi penetrate nel vero spirito del vero medio
evo, che cosa trovate voi invece? Trovate per l'appunto un dissidio, e spesse
volte un conflitto aperto e rude tra questi elementi dalla cui unione la buona
opera d'arte dovrebbe scaturire.
Da una parte il
medio evo è troppo idealista, d'altro lato è troppo materiale; da un canto
avete l'ascetismo, il misticismo, l'estasi e le inani sottigliezze del pensiero
umano spinte dalla Scolastica agli estremi limiti. Dall'altra avete il regno
violento della forza ed il grido perpetuo dei forti: guai ai vinti! A ogni
pagina di quella triste epoca vi ricorrono alla mente le parole che Alessandro
Manzoni metteva in bocca al moribondo Adelchi, l'eroe rappresentativo di quella
epoca:
.....Una feroce
Forza il mondo
possiede, e fa nomarsi,
Dritto: la man
degli avi insanguinata
Seminò
l'ingiustizia; i padri l'hanno
Coltivata col
sangue; e omai la terra
Altra messe non
dà....
Le grandi potestà
del medio evo, Chiesa e Impero, adoperavano ognuna i propri argomenti per porre
un'armonia in codesto grande conflitto che dà il carattere e forma come il
dramma vivo del medio evo; ma siccome queste due supreme potestà erano esse
pure in conflitto tra di loro, tante volte avviene che invece di comporre
scompongono, invece di far cessare la discordia la producono in forma più acuta
e più violenta. Oggi avete Arrigo IV ignudo e tremante alle porte di Canossa;
domani avete Gregorio VII che muore in esilio «per avere amata la giustizia e
odiata l'iniquità». E sempre da capo avrete il medesimo conflitto, non
componibile mai, sino alle scomuniche di Leone X e al sacco di Roma pei lanzi
di Carlo V.
Data questa
atmosfera, la vera e completa opera d'arte era impossibile. - Non vi sono fiori
in quella devastata landa, o sono così gracili che appena nati muoiono; o sono
così misticamente pallidi che il loro colore non può giungere fino ai nostri
occhi di carne. Ricordatevi una similitudine di Dante nel Purgatorio:
Come per
sostentar solaio o tetto
Per mensola
talvolta una figura
Giunger si vede
le ginocchia al petto....
Ebbene, in
questa cariatide Dantesca a me par di veder raffigurata in qualche modo la vera
arte medioevale. Vi è qualche cosa di faticoso, di triste, di pesante nella
significazione di quell'arte. Nell'architettura voi notate troppo spesso o una
sproporzione geometrica tra le masse ornamentali e le masse organiche, o una
sproporzione statica fra la pesantezza e la solidità, oppure avrete l'eccesso
opposto. Lo stile ogivale, in favore del quale il romanticismo nel nostro
secolo suscitò tanti entusiasmi, ha una singolare istoria, che sarebbe tempo di
rivedere con criteri più sereni e più esatti. Invece principiamo, al solito, a
generare degli equivoci con una inesatta appropriazione di nomi. Quando
l'architettura gotica o ogivale, uscita dall'Ile-de-France, si stende ai paesi
del Reno e viene in Italia, s'incontra con le tradizioni romaniche, si
congiunge ad esse e in esse trova correzione e temperanza. Allora sorgono degli
edifici davvero ammirabili che danno alla architettura una nuova pagina
gloriosa. Ma quando il gotico non è che medioevale e non si espande che per
forze proprie e si abbandona a tutte le sue passioni, per le linee verticali,
allora abbiamo, come ben disse Giulio Michelet, una specie di vera scolastica
architettonica, con tutti i suoi errori, le vanità e le sottigliezze decadenti,
rappresentati da quelle selve di guglie e tabernacoli, contro le quali non
debbono parere poi tanto ingiuste le invettive, che, a nome del luminoso genio
del Cinquecento, gli volgeva contro il buon Vasari.
Della pittura è
lo stesso. Entrate in quelle tenebrose chiese del vero medio evo, alzate gli
occhi agli absidi, guardate quelle figure che hanno qualche cosa fra il
grandioso e l'elefantesco, e la mente vostra rimane troppo indecisa se quella
sia grandiosità vera o piuttosto una macchinosità inelegante. Manca anzitutto a
quelle pitture la completa individuazione, condizione indispensabile dell'opera
d'arte figurativa. Infatti gli artisti hanno sempre bisogno di aggiungere alla
figura un simbolo che la distingua e la determini. Lo stesso dissidio e la
stessa indeterminatezza voi notate cercando la espressione morale di quelle
figure. Che vi dicono essi? Quegli enormi Redentori vi destano nell'animo un
turbamento irrequieto, un sentimento che non sapete definire. La mano di Gesù
si alza a benedirvi, ma i suoi occhi sono così torvi, la sua faccia è così
corrugata, che voi rimanete in forse se quello sia veramente un gesto di
benedizione o di maledizione.... Insomma, se non fate degli scambietti di
storia ma rimanete entro la cerchia del vero medio evo, voi ci troverete lo
sforzo, il tentativo, la velleità dell'opera d'arte; l'opera d'arte vera e
completa non mai. A tutte le opere d'arti medievali si potrebbe applicare una
frase dantesca e chiamarle «automata in difetto». - Quell'agile e complessa
fusione che darà per risultato la «divina simmetria» è ancora di là da venire;
è ancora troppo lontana.
E come poteva
essere altrimenti, o signore? Guardiamo un poco. Il medio evo è pieno di
terrori, di tristezze, di scoramenti. È inutile che io vada qui enumerando le
cause storiche che danno alla psicologia dei popoli occidentali di quell'epoca
questo carattere; ma è fuori di dubbio che l'arte per vivere, per fiorire ha
bisogno di amore, di giocondità e di speranze. Bisogna guardare a questa vita
con un certo fiducioso compiacimento perchè l'arte fiorisca. La negazione
pessimista, sia essa mistica o atea, è un vento di deserto che impedisce
all'opera d'arte di nascere, oppure, nata appena, la mortifica e la brucia.
E poi nel medio
evo predomina troppo la fantasia del brutto. Il predominio del diavolo che è
incarnazione di tutte le deformità e di tutte le bruttezze fisiche e morali, ha
uno strano, un soverchio ascendente nella vita intellettuale e fantastica degli
uomini e delle donne del medio evo. Il Diavolo è da per tutto. La vita è tutta
una specie d'infestazione diabolica, è tutta un tessuto di tentazioni, di
persecuzioni, d'insidie, di scherni, d'insudiciamenti diabolici. Sapete, o
signore, quando il mondo cristiano cesserà di essere inestetico e quando si
formerà una temperatura favorevole all'arte? Quando, secondo la leggenda
narrata da Giorgio Vasari, il Diavolo comparirà in sogno ai pittori e si
lamenterà con loro e dirà che è tempo di smettere, di farlo così brutto; e che
egli non è poi tanto brutto come lo si dipinge!... Egli è, o signore, che
l'epoca inestetica simboleggiata in questa leggenda comincia a passare, egli è
che una grande redenzione artistica va facendosi nel mondo; e in quella
redenzione anche il Diavolo sarà beneficamente coinvolto. E Belzebù, e
Berlicche e tutta quella iconografia diabolica che infesta e domina il medio
evo darà luogo a delle visioni meno tristi e meno deformi. Avremo in seguito
la, ancora brutta, ma pur grandiosa concezione dantesca:
L'imperator del
doloroso regno;
e poi
ascendendo ancora arriveremo al Satana della Gerusalemme liberata:
Orrida maestà
nel fero aspetto....
I suoi occhi
splendono «come infausta cometa» ma anche quella delle comete è luce siderale.
E ascendendo sempre arriveremo alla concezione di Giovanni Milton. Il brutto e
ridicolo Diavolo delle tregende, lo sconcio Berlicche sconciamente baciato
dalla strega nei sábbati, scomparirà a poco a poco dall'orizzonte dell'arte
cristiana. Sottentrerà Lucifero, l'angelo peccatore, l'angelo caduto, ma che
pure nella fronte fulminata serba, se non un raggio, almeno un vago riflesso
della sua primitiva bellezza.
E altra causa,
o signore, delle condizioni inestetiche del medio evo voi la dovete trovare
nell'abbiettamento del corpo umano che il medio evo prescriveva. Dopo il
Diavolo il grande nemico del medio evo, tenetelo bene a mente, è sempre il
corpo umano; anzi il Diavolo stesso non avrebbe presa e dominio sopra di noi,
se non l'acquistasse per mezzo del nostro corpo. Questo predicava con tutte le
sue voci l'ascetismo medievale. Ora, o signore, io credo di non essere nè
ingiusto, nè irriverente verso di lui. Ebbe anch'esso certamente il suo lato
buono nel grande poema dell'umanità. Il corpo umano nelle civiltà pagane aveva
troppo esultato, aveva troppo tripudiato, aveva troppo tiranneggiato col
fascino delle sue forme; troppo aveva sacrilegamente abusati i misteri dell'amore
e della morte.... Bisognava che gli fosse inflitta una lunga penitenza: questa
penitenza gl'inflisse l'ascetismo cristiano; e fu forse giustizia. Ma voi
dovete ancora comprendere che in un'epoca in cui questo corpo umano era
considerato come il grande nemico, dove continuamente bisognava pensare a
domarlo, a invigilarlo, a correggerlo e sopratutto a nasconderlo, l'arte si
vedeva tolto un grandissimo elemento alle sue rappresentazioni. Quale
differenza coi Greci! Essi invece avevano per la bellezza corporea una specie
di culto, la consideravano come una benedizione degli Dei e quasi
l'equiparavano alla virtù. I bei corpi ignudi lucenti di puro olio d'oliva e
lottanti nelle palestre, erano degni di ammirazione, di premio, quasi di culto;
e allora si capisce che Fidia e Cleomene cogliessero dal vivo quelle belle
forme e le trasportassero nella giovinezza immortale del pario e del pentelico
come una seconda apoteosi.
Questo, o
signori, non poteva accadere nel medio evo, perchè avrebbe troppo avuto odore
di peccato. - Anzi notate un fatto. Visitate certe chiese medievali: entrate
per esempio nella bella chiesa di Santo Stefano a Bologna, esaminate la
cattedrale di Ferrara, quella di Modena, parecchie chiese in Lombardia; in
questa stessa Firenze recatevi in quelle chiese che meglio vi danno il
carattere dell'epoca e osservate una curiosa progressione. Quando la scultura
si ferma al puro mondo vegetale, voi la vedete, malgrado la rozzezza della
tecnica, dare dei saggi di una non ispregevole abilità e anzi assurgere ogni
tanto a forma di rara bellezza. Se dal campo dell'ornamentazione, per via di
steli, foglie e fiori, passate in quello tolto dal regno animale, anche qui non
di rado v'imbatterete in alcuni pregevoli risultati. Invece quando la scultura
entra a cimentarsi con la figura umana, ecco che essa ricade in tutta la sua
impotenza e il goffo e il brutto vi regnano sovrani. Alcuni crederanno di
spiegare questo progresso negativo adducendo essere molto più facile
all'artista ritrarre un elegante convolvolo vegetale o un serpente, un grifo,
un leone che una figura umana. Ma la spiegazione è insufficiente. Quando l'arte
ha potere di cogliere e ritrarre fedelmente le linee esteriori dei corpi, per
quanto questi mutino, una certa abilità dovrà sempre dimostrarla. Nel caso
nostro invece non abbiamo solo gradazione, ma salto a dirittura. La scultura
non sembra più un'arte quando ritrae la forma dell'uomo e della donna. Perchè?
Il perchè adeguato non si ritrova se non si pensa che l'artista medievale, o
consapevole o per abito o per istinto, mettesse nel suo lavoro qualche cosa di
quel disprezzo pauroso del corpo (contemptus
corporis) che l'ascetismo predicava di continuo e prescriveva.
Stando le cose
in questi termini, e tali essendo le condizioni dell'arte, si domanda: come
potè la civiltà occidentale, e la civiltà italiana in ispecie, uscire da queste
condizioni inestetiche e rifornire gli elementi di vita alle arti belle? Come
potè la calda e luminosa concezione del bello rivivere negli intelletti e
dagl'intelletti passare nelle mani ubbidiente?
Sulle rive
della Brettagna raccontano che, al tempo dei tempi, il mare inghiottì una
città. Quella città sprofondata nell'acqua era tutta morta? No. La leggenda
continua che quando la calma del meriggio è profonda, quando è profondo il
silenzio della notte, i pescatori sentono uscire di giù dall'acqua dei suoni di
campane, come indizio che la vita non si è interamente spenta in quella città
sepolta. È il caso della civiltà in Italia. «L'anima italiana» per dirla con
Gébart, anche nel più fitto dell'età di mezzo, non cessò mai interamente di
vivere nelle condizioni e nei caratteri che aveva impresso in lei la civiltà
greco-latina.
La storia, o
signore, non ci presenta solo un grande arringo in cui vengono a conflitto il
Vero e il Falso, il Bene e il Male; è ancora un campo glorioso alle lotte del
Bello e del Brutto; e certe razze hanno portato in queste lotte una
predestinazione di glorie incomparabili.
La Grecia tiene
il primo posto. Accettò i miti dell'Oriente, ma col suo potente genio estetico
vi esercitò sopra una selezione di bellezza. Escluse più che potè il deforme; e
i miti bestiali si tramutarono in Dei raggianti di giovinezza e di beltà. Anche
quando non respinse l'orrido e il mostruoso gli diede forma artistica; quando
ritenne qualche elemento bestiale seppe mitigarlo e innestarlo con grazia
incomparabile. Esempi la Sirena e il Centauro.
L'«anima
italiana» all'uscire del medio evo si mostrò non indegna sorella della greca; e
questo avvenne perchè i germi e i ricordi dell'antica civiltà non furono mai in
lei nè spenti nè oscurati del tutto.
Si potrebbe
occupare una lunga conferenza, o signore, raccontando tanti particolari e tanti
aneddoti della storia provante che di tanto in tanto il fantasma dell'antica
bellezza ripullulava negli animi di quegli uomini accasciati dalla tristezza,
dall'ascetismo e dalle grandi calamità della storia. Quel fantasma era
considerato come il Nemico, era cacciato via come il Maligno; ma questo Nemico
e questo Maligno avevano delle seduzioni irresistibili; e talvolta il povero
monaco apriva la finestra dell'anima a questo seducente fantasma.
E si vide anche
in alcune testimonianze di grandissimo significato.
Il genio
latino, per quanto combattuto e devastato dalle influenze anti-estetiche
medievali, riuscì a conservare belli certi tipi che sovrastavano alla sua vita
ideale; e sopratutto il tipo del Cristo Redentore.
Non so se sia
mai stata segnalata tutta la importanza che ha questo fatto nella storia morale
ed estetica dell'Occidente cristiano. È certo che anche sulla faccia di Cristo,
su questo tipo consolatore del genere umano, cercò di estendersi l'ombra fredda
della bruttezza. Quando si stava per entrare nel medio evo ci fu grande
dissidio nella Chiesa. I Padri Orientali e sopratutto quelli d'Africa
sostenevano che Cristo era stato singolarmente brutto fra tutti gli uomini; e
così argomentavano non senza una certa concezione audace e grandiosa, basandosi
sopra certi testi biblici: che Gesù Cristo essendo venuto a redimere il genere
umano avesse voluto pigliare sopra di sè tutte le colpe e tutte le miserie del
vecchio Adamo, compresa la bruttezza corporea. Ma contro questa teoria insorse
il genio italo-greco e l'istinto estetico della Chiesa latina. E la Chiesa
latina fece trionfare invece il concetto che corporeamente nella figura di
Cristo si erano accumulate tutte le perfezioni, basandosi anch'essa sopra un
testo biblico: speciosus forma præ filiis
hominum. E notate un altro fatto: la figura di Cristo storicamente non ci
viene tramandata da nessuno; nè dagli Evangelisti, nè dagli Apostoli. Le pie
donne che lo seguirono e lo confortarono, «Maddalena che amò, Maria che pianse»
non ci hanno tramandate le sembianze di Cristo; e cominciarono nondimeno a
correre e stabilirsi in mezzo alla Chiesa d'Occidente delle notizie precise
sulle sembianze di lui: la statura elegante e maestosa, le mani lunghe e
sottili, i capelli biondi, inanellati e spartiti al sommo della fronte, il
volto ovale, gli occhi tagliati a mandorla, cerulei, pieni di dolcezza.... È
ben questo il bel profeta che traeva le turbe, che consolava le donne, e che
faceva sì che i pargoli andassero a lui! Chi ci ha lasciato questo ritratto?
Notatelo. Un latino, il proconsole Lentulus, che ai giorni di Cristo vivea
presso Erode e scriveva al Senato romano. La lettera di Lentulus è senza dubbio
apocrifa, ma nel caso nostro prova più che molti documenti autentici; prova che
anche in questo la latinità agì potentemente sull'indole e lo svolgimento del
Cristianesimo. E fu una vittoria importantissima del Bello sul Brutto. Così
rimase fissato e ci fu conservato quel tipo di Cristo, che potè variare in
alcune modalità, ma rimase identico nella sostanza attraverso i secoli:
dall'umile arte delle catacombe, lungo il medio evo, sotto il pennello di
Giotto, sotto la stecca di Donatello; così placidamente bello nella calma della
morte come nella Pietà di
Michelangiolo; così umanamente triste nella Cena
di Leonardo da Vinci; così trasfigurato dalla gloria nell'ultimo quadro di
Raffaello; così potente di pensiero e di volontà nella figura del Cristo
taumaturgo del Rembrandt; così tragico nel Cristo
morto di Holbein; così elegiaco e amabilmente sentimentale nelle teste di
Wandick; così romantico in quelle di Guido Reni.
Ai nostri
giorni pur troppo degli artisti italiani e forestieri, tratti da non so quali
considerazioni archeologiche ed etnografiche, hanno voluto rimpastare il tipo
di Cristo, e ci hanno dato un non so che di siriaco, di cananeo, di
samaritano.... Forse, quanto alla storia, saranno più vicini al vero. Ma la
coscienza popolare ha respinto questa innovazione ed io dico che ha avuto le
sue buone ragioni di respingerla. La coscienza popolare ha capito che, in ogni
caso, non è per considerazioni archeologiche ed etnografiche che l'umanità ama
di veder ancora riprodotte le sembianze del Cristo; ed ha detto agli artisti:
ridateci il nostro bel Cristo latino quale ha attraversato incolume tante
vicende di storia umana, quale ha seguitato a consolare i nostri padri, quale è
stato per tanti secoli dall'umanità amato ed adorato!
Ora voi capite
subito che questo fu un grande coefficiente per la conservazione e
ricostituzione dell'ideale estetico presso le nazioni cristiane. Data la
bellezza di Giove, tutto l'Olimpo greco doveva parteciparne; dato bello il tipo
di Cristo, tutte le gerarchie del Cristianesimo dovevano riflettere alcun che
della sua bellezza; e se voi esaminate i quadri dei più antichi pittori voi
trovate che in tutte le figure degli Apostoli, degli Evangelisti, dei Profeti
viene come a riverberarsi, quasi aria di famiglia, un raggio della bellezza
splendente nel volto di Cristo.
Ma questo certo
non avrebbe bastato. Ripeto che ciò che rese possibile il risorgimento
artistico in Italia ed in Toscana fu l'immanenza dei ricordi della bellezza
classica. Una leggenda rabbinica, resuscitata e commentata molto ingegnosamente
da Ernesto Rénan, racconta che nel medio evo il popolo di Roma (e notate che
quando si diceva Roma s'intendeva tutta la latinità) sotto le macerie che
ingombravano la città eterna teneva nascosta una bellissima statua di donna
nuda; che questa bellissima statua era conservata con mistero; che la sua
esistenza era tenuta gelosamente nascosta alle potestà civili ed
ecclesiastiche; ma che i Romani di tanto in tanto per consolarsi delle dominanti
miserie, delle continue devastazioni, degli spettacoli di reità che venivano
loro da ogni parte, scendevano in quel sotterraneo e si fermavano lungamente a
contemplare questa bella statua, e la baciavano e la bagnavano delle loro
lacrime. - A me par di vedere, o signore, in questo culto di una bellezza
sepolta il ricordo inestinguibile, che durò sempre in fondo alla fantasia del
popolo latino, di quell'arte stupenda che Roma aveva saputo redare dalla
Grecia, e che per molti rispetti aveva saputo così spontaneamente, così
validamente, con tanta genialità, checchè ne dicano alcuni, assimilarsi.
Ebbene, che
cosa abbisognava perchè l'arte risorgesse? Abbisognava che ciò che era fantasia
prendesse parvenza di realtà; bisognava che questa «bella statua» uscisse dalle
tenebre delle catacombe e splendesse novellamente alla luce del sole d'Italia;
bisognava che, o collettiva o individuale, sorgesse un'opera di ricostituzione,
di ripristinamento. - L'Italia non poteva risorgere all'arte se non
rinvigorendo questo ricordo classico al punto di renderlo, come per opera di
spirituale contagio, così attuoso che da quelle stesse mani che avevano
conservato l'antico capolavoro uscisse se non il capolavoro completo, almeno
una degna opera artistica.
E così accadde,
o signore. L'opera, prima che collettiva, fu individuale. Dove sorse l'uomo che
operò questo miracolo? Chi fu l'evocatore della bella statua antica? Se fosse
nato a Roma, coloro che trattano la storia dell'arte con molta ingegnosa
filosofia ma con dei procedimenti che qualche volta somigliano un po' troppo ai
processi buoni per la botanica e per la chimica, avrebbero esclamato: vedete!
L'uomo è nato a Roma, nè poteva nascere altrove che a Roma. Invece la storia,
che spesso si compiace di schernire certe generalità, ci narra che quest'uomo
nacque in una città tutta dedita ai traffici ed alla combattuta vita del mare.
Niccolò Pisano! Ecco l'uomo che evocò il fantasma della classica bellezza
addormentata per tanti secoli e tenuta gelosamente sepolta nelle catacombe dal popolo
di Roma.
Niccolò Pisano
è uno dei nomi che suonano più gloriosi nella storia dell'arte poichè, ripeto,
la sua è opera grandemente individuale. V'è un salto, e si potrebbe dire anzi
un abisso fra quel che egli fa e quel che facevano gli artisti di poco
precedenti o contemporanei a lui. Guardando alla sua opera, non vediamo neanche
quella preparazione e quel certo rapporto di avviamento che pur notiamo nei più
prossimi Bizantini i quali, nella pittura, precedettero, apparecchiarono
Cimabue e ne accompagnarono l'opera. Si è costretti a riconoscere che
quest'uomo fu privilegiato dalla natura di doni singolarissimi. Quanti erano
passati davanti ai ruderi dell'antichità, quanti avevano veduto il mito di
Meleagro e di Ercole e di Fedra e di Ippolito balzare, sorridere inutilmente
dai vecchi sarcofaghi! Pare che tutti avessero sugli occhi una specie di
cateratta artistica! Invece Niccolò Pisano ruppe questa cateratta e con uno
slancio d'arte ammirevole, che non ha forse esempio nella storia artistica di
altri tempi, portò la scoltura dalle forme rozzissime a quelle forme sue, che
se non sono perfette, se accusano l'inesperienza della tecnica, ritraggono però
tutti gli elementi dell'arte antica, e chiudono i germi di tutti i capolavori
futuri, fino a Michelangelo, al Bernini, al Bartolini. Per convincervene voi
dovreste, con questo intendimento di comparazione, fare un viaggio in qualunque
direzione di questa vostra privilegiata terra di Toscana. Muovere per esempio
da Pistoia a vedere l'architrave della porta di San Giorgio e poi fermarvi un
momento a Groppolo a vedere la statua dell'Arcangelo Michele, archeologicamente
preziosissima, ma deforme. Poi passare a Lucca ad esaminare la celebre vasca di
San Frediano e finalmente giungere a Pisa.... Ma che dico? Quando sarete a Pisa
vi convincerete che quel viaggio è stato inutile. Non c'era bisogno di
muoversi. Là in quella città di mercanti e di marinari abbiamo, nello spazio di
pochi metri quadrati, raccolti e messi un di fronte all'altro tutti gli
elementi per un confronto vero, concludentissimo. Vedete là una specie di
triangolo: la Cattedrale, il Battistero, il Camposanto. Cominciate con
esaminare nella porta della Cattedrale che cosa fosse la scultura in un periodo
di poco precedente a quello inaugurato dal grande Niccolò. Quanta goffezza
nella scultura di quelle porte, quanta deformità!... Appena qua e là qualche
movenza ingenua, appena qualche concetto spirituale che vi ferma e vi soddisfa.
Volete vedere il miracolo? Fate solamente pochi passi; partite dalla Cattedrale,
entrate nel Battistero ed esaminate il pulpito. Se i documenti non
testimoniassero, vi parrebbe impossibile che a poca distanza di tempo la
scoltura avesse potuto fare un passo così enorme. E donde ha tratto le forze
esteriori per farlo? Fate ancora alcuni passi; andate nel bel Camposanto ed
esaminate con qualche attenzione il sarcofago della contessa Beatrice, che fu
madre della contessa Matilde. Guardate il mito di Fedra e d'Ippolito e subito
il mistero vi è svelato. Le sembianze di Fedra sono diventate le sembianze di
Maria, le sembianze degli altri personaggi del sarcofago si riproducono nel
pulpito di Niccolò. Vi sono figure di vecchi che ricordano filosofi antichi, vi
sono teste di cavalli che vi fanno pensare alle quadriglie degli antichi trionfi.
Insomma è una evocazione, una risurrezione, pel tempo e per le circostanze del
tutto maravigliosa!
Ma si domanda:
questa epoca così gloriosamente iniziata da Niccolò Pisano, poteva considerarsi
come piena e definitiva per il risorgimento della nuova arte italica? Non lo
credo. Intanto notate che l'impulso di Niccolò, per quanto fosse vigoroso, fu
di poca durata ed ebbe un seguito relativamente scarso. I suoi allievi e
successori immediati poco aggiungono all'opera sua. Per tutta Italia, oltre
Pisa, a Lucca, a Arezzo, a Bologna, a Roma, a Napoli, si ammirano i monumenti
della scultura rinnovata per opera del grande artista pisano; ma nè il
figliuolo Giovanni, nè fra Guglielmo da Pisa, nè fra Guido da Como, nè lo
stesso Andrea e Tommaso e Nerio fanno muovere all'arte dei grandi passi. È fuor
d'ogni dubbio che per un periodo di oltre cinquant'anni abbiamo nell'arte una
specie di sosta. Attività materiale grande, ma progressi scarsi. Più che d'una
corsa in avanti si tratta di un moto circolare sempre dintorno al medesimo
centro. Non è più il marasma di prima, ma una stasi incerta e irresoluta di
cui, sulle prime, non sappiamo renderci conto.
Ma la ragione
non è difficile a trovarsi, o signore. L'opera di Niccolò Pisano non poteva
dare la forma definitiva e l'andamento completo al risorgimento artistico in
Toscana, perchè in sostanza l'arte sua è un'arte di reminiscenze, è un'arte di
pura tradizione. Con essa il Genio italico si riannoda al suo passato glorioso.
Era moltissimo ma non bastava. Bisognava fermare i piedi sicuri sul presente e
divinar l'avvenire.
Per un'arte
nuova facevano mestieri degli elementi nuovi, degli elementi che ritraessero la
ragion loro in modo più diretto dalle condizioni della storia contemporanea e
dalla natura. Pensate solo a questo, o signore; la donna più morbosamente
amorosa dell'antichità, Fedra, che appena Euripide aveva osato portare, tardi,
sulle scene della Grecia; Fedra doveva dare per mezzo dell'artista cristiano le
sue sembianze alla madre di Cristo, alla personificazione cristiana di tutte le
idealità della donna. Questo, voi lo vedete bene, nell'arte metteva i germi di
un altro conflitto che, a lungo andare, ci avrebbe forse ripiombati in un altro
caos artistico e in una impotenza somigliante a quella dalla quale eravamo appena
usciti. Era necessario che il movimento artistico di Toscana si sdoppiasse, o
meglio che il primo fosse seguito da un secondo più efficace perchè più
comprensivo. E per tutta Toscana voi sentite come scorrere un soffio caldo e
primaverile: vedete Arezzo, Pisa, Siena, Lucca, Firenze che vi danno idea di
amazzoni gagliarde in gara fra di loro. Corrono, corrono e ognuna vuole arrivar
prima!... Arezzo ha il suo Margheritone, Pisa ha il suo Giunta, Siena ha Guido,
Firenze ha Cimabue. Già si prevede che, come il periodo precedente ebbe inizio
dal risveglio della scultura, in questo secondo la pittura dominerà; la pittura
che si stende con ala più vasta nell'orizzonte dell'arte. Si prevede ancora che
in questa nobilissima gara la vittoria rimarrà a Firenze; a Firenze che, fra le
città italiane, era una di quelle che conservavano in minor numero ricordi e
avanzi dell'antica arte classica: fatto importantissimo questo, già notato
dallo stesso Benvenuto Cellini; e che doveva grandemente influire
sull'indirizzo più libero, sul carattere più originale, sulla schietta
modernità insomma dell'arte e che s'andava maturando e batteva alle porte
dell'avvenire.
Dunque,
riassumendo: Pisa doveva dare al rinascimento dell'arte italica l'elemento
tradizionale e lo diede con l'opera di Niccolò e dei suoi scolari; lo diede
vigorosissimo, lo diede in modo da render ben meritevole la fama gloriosa che
il Pisano si è acquistato nella storia. Ma bisognava entrare in un periodo
nuovo; e Firenze vi entrò con un vigore e con una fortuna che sconfisse tutte
le altre città toscane in gara con lei. Le esagerazioni storiche del Vasari
sono già state cribate e ridotte al loro giusto valore. Vasari vide con occhio
troppo toscano e forse troppo fiorentino quando entrò nei particolari; ma nella
grande linea storica il buon aretino si mantenne nel vero. Firenze doveva
essere la sede, doveva essere il faro da cui sarebbe partita la nuova luce.
Tutto contribuiva nel conferire a Firenze questa privilegiata e gloriosa
missione storica. Il suo popolo era libero, forte, ricco, fidente di sè,
guardava con sicurezza al futuro. Era sopra tutto istruito, come nessun altro
popolo in quel tempo. Erano i giorni, o signore, in cui i poeti si sognavano di
esser messi per incantesimo in una barca insieme ai loro più cari amici ed alle
loro care donne e di veleggiare a lungo senz'altra cura, sotto un cielo e sopra
un mare tranquillo, ragionando e sognando d'amore. Giovanni Villani ci narra
che nel 1283 per un lungo tratto di tempo tutta la città rimase nel grazioso «dominio
d'Amore». Era una vita spirituale e gioconda. La parte umana che doveva dare il
primo elemento all'arte s'innalzava, si affinava, si ingentiliva. L'altro
elemento, l'elemento mistico cristiano, alla sua volta si rendeva sempre più
acconcio alla composizione della definitiva opera d'arte.
Sopra una verde
collina dell'Umbria un povero uomo pregava Dio; ma lo pregava in una forma
insolita dando alla sua preghiera un'insolita intonazione. Chiamava partecipe
alla sua prece, al suo inno, il sole, la luna, le stelle, le montagne, le
piante, i fiori, le rondini e le colombe dell'aria: voleva che tutte le
creature viventi si unissero a lui in una gara immensa di lode amorosa rivolta
al Creatore. Da una parte adunque il divino, non dirò no che si abbassasse, ma
si rendeva più mite, più dolce, accennava più affabilmente verso questa povera
vita umana; l'umano si elevava, si affinava, si ingentiliva.... Insomma,
eravamo prossimi, eravamo alle viste di quella «divina simmetria»; a
quell'accordo degli elementi materiali e ideali che il medio evo aveva con
tanto disagio e inutilmente cercata, da cui doveva balzare luminosa e gloriosa
la perfetta opera d'arte.
Mancava l'uomo,
e quest'uomo l'aveste voi, e discese, umile pastore, dalle montagne che
circondano la vostra Firenze: Giotto. Ho detto il nome del più grande forse fra
gli artisti di tutti i tempi, e di tutte le civiltà. Egli non esordì come
Niccolò, copiando il sarcofago antico, ma disegnando, in mezzo alla pace de'
suoi boschi, una delle sue pecorelle, simbolo gentile del poetico naturalismo,
che egli doveva inaugurare. Wolfango Goethe nell'olimpica serenità dell'anima
sua lo avrebbe chiamato Euphorion, il
figlio di Elena bellissima e di Fausto pensoso; colui che doveva sintetizzare e
fondere gli elementi plastici dell'arte antica e gli elementi spirituali e
sentimentali dell'arte moderna e cristiana. Come lo chiameremo noi?... Noi ci
contenteremo di prendere in prestito da Dante, il suo grande amico, una frase,
e lo chiameremo il maestro e l'autore del «dolce stile nuovo» della pittura e
dell'arte toscana.
E qui, signore,
io sono arrivato ai limiti nei quali debbo fermarmi. - Saluto il bellissimo
tema che sarà tratto con forma più degna della mia dal mio successore un altro
anno, e in cui si rispecchia così pura gloria italiana, la quale, in tanta
parte, è gloria vostra, o Fiorentini.
EPILOGO
DI
Ernesto Masi
Signore!
È un ufficio
modesto quello che io ho da compiere, ma che sapendo compiere con chiarezza e
brevità, potrebbe, secondo il famoso precetto d'Orazio, riescir utile e
piacevole insieme.
A significarlo
con evidenza sento che, a guisar d'esordio, una buona similitudine, presa in
prestito da qualche poeta, mi tornerebbe assai bene, ma per quanto la cerchi,
non mi vien fatto trovarla adatta, come vorrei. Mi ricorre alla memoria
soltanto la dantesca solita:
E come quei che
con lena affannata
Uscito fuor del
pelago alla riva
Si volge
all'acqua perigliosa e guata.
Ma la lena affannata, che sarebbe la vostra, o
signore, l'acqua perigliosa, che
sarebbe la materia delle conferenze passate.... Oibò! non conviene per nessun
conto! Dico dunque senz'altro che ricordarvi le principali cose discorse
finora, accennarne qualche generalità comprensiva dei molti particolari, che vi
furono esposti, additar qualche nesso, qualche correlazione fra l'uno e l'altro
argomento e riepilogare le conclusioni più importanti, potrebbe riescir utile e
piacevole insieme, appunto come dopo un lungo viaggio (questa volta la
similitudine è un po' vecchietta, ma per compenso convenientissima) s'ama
riandare, fantasticando, le cose vedute, non però in modo da rifarcene in mente
una ridda vertiginosa di monti e di foreste, di laghi e di piazze, di chiese e
di palazzi, di musei e di campanili, ma riordinando dentro di noi e scegliendo
con discrezione quello che in natura ci parve più bello, in storia più
caratteristico, in arte più fecondo di consolanti idealità da mettere in serbo
per la vita.
Prometto
troppo. Me n'accorgo. Ma non mi manca almeno la buona volontà di mantenere e
non di tutte le promesse, che a questo mondo si fanno, si può sempre assicurare
altrettanto. - Ad ogni modo, proviamo!
Dei varii
periodi, nei quali si vuole dividere la storia del Medio Evo italiano, vi fu
principalmente parlato dei secoli XI e XII, con qualche scorsa nei periodi
anteriori e nei susseguenti, ora per indicare la cagione degli avvenimenti, ora
per mostrarne le conseguenze e chiarir bene così da che profonda notte si
usciva a quelli che si convenne chiamare, gli
albori della vita italiana. Albori di vita italiana? O perchè? Era dunque
morta questa vita? Quand'è che nella storia si muore e si rinasce? No, signore;
nè si muore, nè si rinasce in realtà, bensì anche nella storia annotta e si
brancola talvolta nel buio, poi un po' di luce torna a risplendere e ci si
rimette in cammino. La dominazione romana del resto era il mondo, non l'Italia
soltanto. Un'idea e una forza, irresistibili entrambi, il cristianesimo e i
barbari, sfasciano quella potente, quella sapiente unità, annientano quella
universale dominazione. Allora l'un popolo si getta sull'altro, e questa
convivenza forzata di razze diverse sul medesimo suolo, l'una che padroneggia,
l'altra che serve, sino a che col mescolarsi e coll'accomunare le loro forze
rispettive danno origine ad una civiltà nuova sotto la luce dell'idea
cristiana, è il fatto elementare, per dir così, della storia medievale europea;
un fatto non mai accaduto prima in così larghe proporzioni; un fatto, che non
può ripetersi dopo, e che contraddistingue perciò il Medio Evo da tutte le
altre età della storia. - La fusione fra invasori ed indigeni, fra dominatori e
dominanti, accade fuori d'Italia più facile. Ben gli aveva Roma già curvati una
volta gli uni e gli altri sotto il medesimo giogo! Ma in Italia romanità e
barbarie non si fondono con uguale facilità, nonostante il cristianesimo, che
fu gran fattore di tali fusioni. Tutto resiste e impedisce. Più di tutto forse
l'idea romana, stata perciò paragonata, per quella specie di fato perpetuo, che
diviene nella nostra storia, ad una di quelle stelle tanto grandi e tanto
lontane, che il loro raggio non ci giunge se non dopo diecine di secoli,
sicchè, se ora venisse a spegnersi, la si vedrebbe splendere ancora per molte
migliaia di anni. Così è. La vecchia Roma è finita, ma il pensiero di lei
sopravvive e domina tutti per lungo corso di storia, barbari, latini, papi,
comuni, pensatori, tribuni, cronisti, poeti, persino la casalinga donnetta del
primitivo Comune Fiorentino, che
....traendo
alla rocca la chioma,
Favoleggiava
con la sua famiglia
De' Troiani, di
Fiesole e di Roma.
Quando col
pensiero fisso alla libertà e indipendenza dell'Italia, anche i libri di storia
erano per metà di politica[17],
usava discutere se dato che i Longobardi avessero potuto occupare e reggere
tutta l'Italia, non si sarebbe fin d'allora formato dell'Italia uno stato nella
nuova forma romano-barbarica, come la Francia e la Spagna, ed il Machiavelli
accusava fieramente i Papi d'averlo impedito e dietro a lui tanti altri
dibattevano la medesima questione, che con ragione il Mamiani giudicava aver lo
stesso valore che «cercare quello che accaderebbe al mondo se l'aria avesse
manco di ossigene, o il mare di salsedine o la terra ponesse a fare il suo giro
sole dodici ore in cambio di ventiquattro»[18].
Se una filosofia della storia è possibile (cosa di cui molti dubitano) è
fondandola unicamente sui fatti, quali furono, non quali alcuno potrebbe
desiderare che fossero stati. E stando ai fatti, all'anarchia dei duchi Longobardi
fu pure un progresso e un ordine dato la feudalità franca, il cui capo,
invasato anch'esso dall'idea romana, ricostituisce la dignità imperiale cessata
in occidente da oltre tre secoli, fra le ingenue acclamazioni del popolo
italiano, che non sospetta neppure di dover essere la prima vittima di questa
ricostituzione; alla quale, morto Carlomagno, sottentra un'anarchia feudale,
confusa, impotente, buona a nulla, anche quando l'un pretendente sopraffà
l'altro, perchè Berengario osa intitolarsi re d'Italia, allorchè non ne
signoreggia tanta, se non quanta è compresa fra l'Adige e il Po. - Anche a
quest'anarchia viene a metter ordine, dopo oltre settant'anni, una seconda
restaurazione imperiale, ma intanto nel consorzio umile, modesto, quasi
inavvertito della corporazione d'arte, all'ombra del campanile della
parrocchia, sotto l'autorità ecclesiastico-feudale del Vescovo, a cui gli
imperatori di casa Sassone concedono via via il potere degli antichi Conti[19],
si ridesta e si svolge già tanto di nuova vita italiana, che lo storico
Sismondi non dubitò di glorificare quegli Imperatori tedeschi, come i veri
fondatori, i veri padri dei nostri Comuni. Lo furono essi in realtà? - A questa
quistione, o signore, avete sentito accennare più volte, ma poichè trattavasi
della storia speciale dei principali Comuni, era naturale che per accenno
soltanto fosse toccata. Or bene, le linee più generali di tale questione son
queste[20].
Il nostro Comune
medievale è una vecchia istituzione romana, che ha resistito all'urto delle
invasioni barbariche e che ha perdurato durante l'ordinamento feudale (il quale
ordinamento non è altro in sostanza che la barbarie disciplinata per mezzo del
possesso territoriale), ovvero è una istituzione nuova, una istituzione
importata, in una parola una istituzione tedesca?
Ma se era
indigena, antica, romana, perchè avea aspettato a rivelarsi di nuovo che la
feudalità avesse pur dato un assetto qualsiasi alle barbarie, e fosse già
passata per tutte le sue vicende storiche e avesse trionfato dappertutto e
avesse provveduto a tutte le necessità della vita civile, politica, pubblica e
privata?
E se per
contrario era nuova, importata da fuori, tedesca insomma, al pari della feudalità,
se le sue origini erano da ricercarsi nell'indole degli invasori, nello sciolto
individualismo germanico e nelle istituzioni provenienti dalla conquista, come
mai sorgeva essa in assoluta opposizione a quest'indole e a queste istituzioni,
sicchè il suo trionfo non dovesse essere che a prezzo d'abbattere i castelli
feudali e d'assoggettare i discendenti degli invasori alle leggi del Comune? Il
Comune insomma è cosa nostra, è un diritto, di cui il popolo italiano non
smarrì mai la coscienza, o è un effetto del vassallaggio del regno feudale
italico al regno feudale di Germania?
Sì l'una che
l'altra opinione ebbero sostenitori di grandissima autorità. Ma oramai prevale,
come avrete avvertito, una opinione media fra questi due estremi, un'opinione,
che è la più conforme all'indirizzo tutto positivo degli studi storici moderni,
perchè tien conto nella soluzione del problema, non di un ordine di fatti
soltanto, ma quanto è possibile, di tutti i fatti della storia. Ora il
germanismo, la feudalità, la Chiesa, l'Impero, tutti questi sono elementi
storici, che concorrono a comporre la vita civile e politica del Medio Evo.
Sotto molteplici travestimenti, e con adattamenti diversi, ora vigoroso e
visibile, ora debole e quasi perduto di vista, l'antico municipio latino ha
bensì perdurato sotto a tutto quel pondo immane di nuove sovrapposizioni, ma
com'era possibile che risorgesse del tutto all'infuori estraneo affatto a
quegli elementi, in onta ai quali era sopravvissuto? La storia non procede
così. Da tutti quegli elementi di vita medievale e insieme dalla conservata
tradizione romana nasce dunque il Comune, di cui avete veduto, o signore, i
tipi principali in Milano, Venezia, Firenze, e non soggiungo Roma, perchè Roma
sta da sè, impigliata più d'ogni altro Comune nella vecchia idea romana della
dominazione universale e colla presenza del Papato, di cui vi fu narrato il
crescere dell'enorme dominazione spirituale (non certo utopistica questa,
perchè sorpassò di gran lunga l'antica dominazione romana), e vi fu narrato
altresì il sorgere e progredire della dominazione temporale, cagione principale
forse che rese così straordinariamente confusa, tempestosa, anarchica in
permanenza, assai più di quella d'ogni altro Comune, la vita del Comune romano.
- Milano è il tipo del Comune svoltosi nel regno feudale. - Fra i Comuni
marittimi, specie i meridionali, che sottrattisi alla dominazione Longobarda o
sotto la debole e lontana sovranità bizantina sono i primi a sorgere e i primi
a scomparire, fra i Comuni marittimi Venezia sta sola, Venezia che morirà per
ultima di tutte le repubbliche italiane e che costituisce come un lungo
episodio della storia nazionale, estraneo a tutte le forme principali del
movimento politico dell'Italia[21].
- Firenze infine, il più tardivo degli stessi Comuni toscani e insieme il più
glorioso di tutti i Comuni italiani, riassume in sè tutte le forme della vita
comunale, ma ad una ad una le elimina tutte per rimanere il gran tipo del
Comune democratico, dove neppure avete più, come in Milano, vero governo a
Comune, a cui cioè nobili e popolani partecipino ugualmente, ma dopo alterne
vicende di governo di nobili, e di governo di nobili e popolo, questo
all'ultimo sormonta e crea, ripeto, il gran tipo del Comune democratico. Tant'è
che a Firenze il moto comunale si svolge lungo tempo senza che apparisca
nessuna spiccata individualità storica, che non sia tutto il popolo, mentre a
Milano, la città d'Italia, dove si può dire che il moto, il quale dà origine
alle libertà comunali, proceda più manifesto e più regolare, avete una grande
successione di grandi uomini, nei quali sarebbe quasi possibile accentrare la
sua storia. Milano infatti, la maggior sede arcivescovile di Lombardia, con
giurisdizione amplissima, grandi ricchezze, con rito distinto, quasi un altro
Papato di fronte al Romano, è delle prime città, che passano dalla podestà
comitale a quella del Vescovo ed in Sant'Ambrogio, l'eroe eponimo milanese al
IV secolo, s'intravvedono già le prime linee di quella potenza, che dopo
terribili vicende ricomparisce in Ansperto di Biasonno nel IX secolo, in
Landolfo di Carcano nel X e finalmente in Ariberto d'Intimiano nell'XI, la
solenne figura, che in pieno Medio Evo ha ispirazioni e ardimenti politici
degni del Conte di Cavour e attorno alla quale vedeste aggrupparsi
l'insurrezione dei vassalli minori contro i capitani o vassalli maggiori, come
in Lanzone, il nobile ribelle al proprio ordine, il vassallo maggiore, che fa
causa comune colla plebe, vedeste accentrarsi il moto glorioso, che riescì all'unione
dei vassalli minori con la plebe, e quindi alla libertà del Comune.
Ma siamo nel
regno feudale, e nè Ariberto, nè Lanzone, nè capitani, nè vassalli minori, nè
plebe, nè Comune, nessuno sogna neppure di ribellarsi all'Imperatore o di
disconoscere soltanto l'autorità del Sacro
Impero Romano e Germanico, appunto perchè il Comune è una istituzione
italiana, che rigermoglia su terreno feudale[22].
E Ariberto incorona due volte di sua mano Re d'Italia Corrado il Salico e lo
accompagna a Roma, perchè si cinga la corona imperiale, e il primo pensiero di
Lanzone è di rivolgersi all'Imperatore Enrico il Nero, e quando Lanzone ha
intimoriti i nobili fuorusciti, e gli ha rimessi in città, e ha perequati i
diritti di tutti, e ha costituito il Comune, fa ancora sanzionare questi nuovi
ordini nella Dieta Imperiale di Roncaglia. Che se dalla lotta gloriosa, che
Ariberto e Milano sostengono contro Corrado il Salico nel 1037, scendete, oltre
a cent'anni dopo alla prima lega Lombarda e a Federigo Barbarossa, vedrete
bensì che il popolo italiano lotta per mantenere e ricuperare contro
l'Imperatore quello che i risorti Comuni chiamano le buone consuetudini, stabilite già dagli Imperatori della casa di
Sassonia, allargate da quelli della casa di Franconia e all'ombra delle quali i
Comuni stessi si sono ricostituiti; ma se entro le mura della città si
smantellano a furor di popolo le rocche imperiali, se le città collegate
momentaneamente, combattono in campo aperto contro i feudatari italiani e
tedeschi e contro le milizie feudali, che attorniano l'Imperatore, niuno si
sogna neppure di non riconoscere la sua autorità nelle Diete, niuno si sogna,
quand'anche l'Imperatore è respinto dalle mura cittadine, di non riconoscerlo
come giudice ed arbitro fra città e città, di non rispettarlo come il monarca
legittimo, che legittimamente porta la corona dei re nazionali e più ancora
come il monarca romano, che porta la corona d'Augusto, di Trajano e di
Costantino.
Permettetemi di
ricordarvi in proposito i mirabili versi del Carducci, che, poetizzando una
pagina del Quinet, rappresenta epicamente questo che il Quinet chiama il fascino del diritto imperiale[23].
Siamo nella
notte del Sabato santo del 1175, l'esercito della Lega Lombarda cinge da ogni
parte l'esercito del Barbarossa, che ha dovuto levar l'assedio da Alessandria,
e gli chiude ogni possibilità di scampo così dal lato delle Alpi, come da
quello di Pavia. - L'imperatore è perduto. - Lo circondano costernati,
avviliti, pensando già di non poter più uscir vivi da queste strette, il sire
di Hohenzollern, stupito di dover morire per la vil mano di bottegai armati
come i cavalieri; il Vescovo di Spira, che amaramente rimpiange il buon vino, i
giocondi canonici, le torri della sua gotica cattedrale in Germania; il biondo
Conte Palatino Ditpoldo, che in fantasia rivede i suoi castelli sul Reno e la
bella Tecla sospirante d'amore al lume della luna; l'arcivescovo di Magonza che
vorrebbe almeno esser certo i tesori rubati in Italia avessero varcato
sicuramente le Alpi; il Conte del Tirolo, che si dispera dovere ormai il suo
cane e il suo povero figliuolo andarsene alle caccie senza di lui:
Solo, a piedi,
nel mezzo del campo, al corridore
Suo presso,
riguardava nel ciel l'Imperatore,
Passavano le
stelle su'l grigio capo. Nera
Dietro garria
col vento l'imperial bandiera
A' fianchi di
Boemia e di Polonia i regi
Scettro e spada
reggevano del Santo Impero i fregi.
Quando stanche
languivano le stelle, e rosseggianti
Nell'alba
parean l'Alpi, Cesare disse: «Avanti!»
A cavallo, o
fedeli! Tu, Wittelsbach, dispiega
Il sacro segno
in faccia della lombarda lega.
Tu intima, o
araldo: «Passa l'Imperator romano,
Del divo Giulio
erede, successor di Traiano.»
Deh come
allegri e rapidi si sparsero gli squilli
Delle trombe
teutoniche fra il Tanaro ed il Po,
Quando in
conspetto a l'aquila gli animi ed i vessilli
D'Italia
s'inchinarono e Cesare passò![24]
Venezia sola è
posta fuori del tutto da questo fascino del diritto imperiale. Avete visto, o
signore, come nacque, mentre l'Impero d'Occidente cadeva, come crebbe, come si
ordinò questa meravigliosa città, meritevole d'esser detta figlia di Roma assai
più di quanto vantino le cronache medievali per tutte le altre città italiane,
perchè di Roma ereditò la sapienza e la perseveranza politica e perchè
cittadini romani erano i profughi, che la fondarono cercando uno scampo alla
furia dei barbari sulle lagune e sulle isolette del golfo veneto. Vi
esercitarono bensì i Goti una specie di alto dominio, l'impero d'Oriente una
supremazia formale e non più, ma ciò accade nel primo periodo appena della sua
esistenza e non avendo mai lo straniero potuto mettervi il piede, essa sola non
sarà mai vassalla nè d'Impero nè di Chiesa, essa sola non sarà nè guelfa nè
ghibellina, nessun Imperatore Germanico oserà chiederle giuramento di fedeltà:
non avrà in sè mescolanza di due razze di vincitori e di vinti, che si
combattano fra di loro[25];
le sue discordie intestine non faranno che riaffermare i suoi ordinamenti, che
al 1297 saranno definitivi e dureranno per altri cinquecent'anni in punto.
Più travagliato
e meno durevole destino ebbero le sue rivali sul mare, Amalfi, Pisa, Genova, ma
esse dividono con lei la gloria di quella primavera italica del risorgimento
comunale.
Niuno però dei
Comuni marittimi nè Amalfi, nè Pisa, nè Genova può paragonarsi a Venezia,
monumento unico d'italiana energia fin nella sua materiale costruzione, e che
ha tutto di esclusivamente suo, origine, leggende, cittadinanza, sovranità,
leggi, ordini civili, nobiltà, popolo, cerimonie, feste sacre e profane, i suoi
santi persino, perchè tutta veneziana è la leggenda di San Marco, che
detronizza il bizantino San Teodoro e diviene il protettore, il simbolo, il
grido di guerra di Venezia. L'avete udita questa leggenda in tutti i suoi
particolari. Non vi dispiaccia riudirla da un poeta, non senza molte buone
ragioni messo presto fuori di moda, ma la nobiltà dei cui sentimenti raccomanda
ancora, io credo, al ricordo delle signore gentili. I suoi versi compendiano
altri fatti, ch'io non avrei tempo a ricordarvi partitamente:
Veleggiando
venia verso Aquilea
Un dì
l'Evangelista....
Quando il
nocchiero improvvido, dall'ôra
Sospinto in
grembo d'una pigra e trista
Laguna si
perdea
Tra un
labirinto d'isolette....
All'appressarsi
del naviglio sacro,
Unico
abitatore,
Volando emerse
di colombi un nembo
Dal turbato
lavacro.
Il Pio guardò
quell'isole dal lembo
De la sua poppa
lungamente. In core
Gli sfolgorò
del vaticinio il lampo
E profetò che
un giorno
Tra quella
d'acque squallida vallèa
In trionfal
ritorno
All'avello
condotto esser dovea.
E come ei
tacque su le canne apparve
Lo spettro
d'una chiesa bizantina,
Che tremolò per
l'etere e disparve;
E d'eco in eco
per lo tacit'arco
Dell'adriatica
marina
Grido immenso
volò: «Viva San Marco!»
Si laggiù
poserai....
Laggiù, o
celeste, poserai ma cinto
Da selva di
lucenti
Colonne e sul
tuo portico regale
Scintilleranno....
I destrieri di
Corinto.
Al nome tuo,
venturo inno di guerra....
Prigioniere verran
di Palestina
A riflettersi
mille arabe lune
Dentro le tue
lagune;
E su le torri
dell'infido Greco
Un vecchio
ardente e cieco
Guiderà la
vittoria,
A piantar fra i
nemici il tuo vessillo
Logoro dalla
gloria,
Verranno i re
da regïon lontane
Le tue belle a
sposar repubblicane;
E su quella
palude
D'alighe
immonde sorgeran portenti
Di templi, di
trofei, di monumenti[26].
E sia,
ammiriamo pure Venezia. Ma voi sapevate prima, o signore, e sempre più vi
sarete confermate, che se si vuole penetrare veramente nel vivo della storia
del Medio Evo italiano, vedere atteggiate e combattenti tutte le passioni di
quella età, saggiate tutte le forme politiche; se si vuol conoscere come dalla
lotta lontana delle due podestà che dominano il Medio Evo, Papato ed Impero,
come dall'affievolirsi dell'organizzazione feudale si svolga la libertà del
Comune popolare e a che tradizioni questo comune riattacchi le sue origini, e
perchè contenga quasi due popoli in uno e perchè la lotta a morte fra questi
due elementi che lo compongono costituisca il destino e il segreto della sua
storia; se si vuole infine sapere perchè vi sia una storia di un grande Comune
italiano, che è tipo e modello di quasi tutte le altre, bisogna guardare a Firenze,
a questo cuore d'Italia, come fu
chiamata, che all'infausto cosmopolitismo imperiale o papale di Roma potrà per
sua gloria contrapporre il cosmopolitismo dell'arte, della poesia, della
scienza, il privilegio della lingua, e persino fra le tumultuose tragedie della
sua vita interiore i primi germi dello Stato moderno.
Nelle ingenue
leggende delle sue origini vedeste già adombrate, forse con senso più profondo
che non apparisca, le divisioni etniche, che divamperanno più tardi in lotte
furibonde; le quali lotte e divisioni, in quel Comune, che tarda tanto a
svolgersi e si svolge quasi inavvertito, quasi inconscio di sè, strappando a
brandelli il suo potere della potestà Margraviale della contessa Matilde; in
quel Comune, composto nella maggior parte di operai, di artigiani, e di qualche
nobile decaduto, che per miseria s'inurba; in quel Comune che stretto nelle sue
associazioni d'arti e mestieri si regge e progredisce con queste senza bisogno
di potere centrale, cominciando, direbbe il Romagnosi, il suo incivilimento in
ordine inverso, cioè dall'industria per giungere al possesso territoriale; in
quel Comune, dico, come risulta ancor più evidente dalla sua storia ulteriore,
quelle divisioni e le lotte, che ne conseguono, rimangono sempre esse nel fondo
di tutte le sue vicende o possono dirsi quasi la legge storica, che illumina da
cima a fondo tutto quell'incomposto arruffio. Il quale non spossa le forze del
Comune, anzi sembra aumentarle, poichè appena le interne discordie danno
qualche tregua, si guerreggiano le terre vicine e si allarga lo Stato; uno
Stato che è tutto nella città principale, la quale non si aggrega, ma domina
feudalescamente i vicini e che all'Impero chiede sopratutto di lasciarlo
sottentrare nei diritti e nel potere degli antichi feudatari; altra prova, se
mai occorresse, che il nostro Comune medievale è bensì romano d'origine, ma
dalla temperie barbarica e feudale, in cui è risorto, profondamente modificato.
Così è che le due parti combattentisi entro il Comune pigliano i due nuovi nomi,
come dice Dino Compagni, di Guelfi e di Ghibellini, ma il loro contrasto
preesisteva a questi nuovi nomi, nella stessa guisa che il prorompere di queste
lotte si verifica in Firenze assai prima del fatto del Buondelmonte, a cui gli
storici lo sogliono riferire, e non è se non un incidente di quella torbida
vita del Comune fiorentino, di cui parrebbero un mistero inesplicabile non solo
il progredire, ma anche il durare e l'esistere, se non si sapesse donde viene,
ove va, se una medesima legge storica non ci scorgesse a comprendere gli
Ordinamenti di Giustizia del 1293, la vittoria dei Ciompi nel 1378, gli eccessi
che spianano a poco a poco la via alla lunga insidia dei Medici, nel tempo
stesso che i forti e grandi sentimenti di quel popolo, le sue umane riforme, la
sua carità operosa, l'ardente sua fede ci spiegano l'altro mistero che fra
discordie e tumulti così feroci e continui la civiltà più complessa spicchi tal
volo e veggansi nelle chiese, nei quadri, nei primi saggi della pittura
nascente affollarsi angeli, cherubini, madonne, apparizioni candide, innocenti,
che sembrano discese dal cielo a predicar la pace fra gli uomini, e fra tanto
imperversare di odii l'arte, religiosissima ancora, sforzasi, quasi in
espiazione, a moltiplicare dovunque gli emblemi dell'amore.
Potremmo noi
mai sperare di dominare egualmente col nostro pensiero, di assoggettare
egualmente ad una legge storica qualunque la confusione permanentemente
anarchica della storia del Comune di Roma? Ben è spiegabile, anche con soli
argomenti umani, come la potestà del Vescovo di Roma si muti e si espanda via
via nell'enorme e universale potenza del Papa; ben può la critica, la quale
cominciò fin dal secolo XV a sfrondare le leggende congegnate a fine politico
ed a saggiare la falsità dei documenti, sui quali si pretendevano fondare
quelle leggende, dirci come sorse e si piantò formidabile in Roma anche la
potenza temporale del Papa; ma quanto al Comune, e benchè esso assuma talvolta
nel corso della sua storia le forme e le istituzioni degli altri Comuni, non
mai gli riesce trovarvi la forza e la stabilità per lo meno relativa, che gli
altri vi hanno trovato, e lo spettacolo delle sue convulsioni perpetue è tutto
quello che ci apparisce di lui. Egli è che esso non sorge come gli altri, non
si viene formando come gli altri, e per l'influenza dell'Impero e la presenza
del Papato sente spesso ora dall'uno ora dall'altro quasi assorbita la propria
esistenza. La cui prima apparizione è forse quando Roma resiste ai Longobardi
con le forze unite del Papa e del popolo o si palesa in una forma
aristocratico-militare, la quale abbraccia con tale ampiezza tutti gli ordini
dei cittadini, che il nome stesso d'esercito serve ad indicare il popolo
intiero. Dal VII all'XI secolo il Comune di Roma si direbbe costituito a un
dipresso nelle forme degli altri nostri Comuni medievali e precorrerli quasi
tutti. Se non che Roma ha il Papa, il cui potere s'afforza via via sempre più,
e che, se fa causa comune col popolo, lo domina; se mai teme d'esserne
sopraffatto, gli oppone la forza e l'autorità dell'Impero o a questo o a quello
la monarchia napoletana, contrappeso all'Impero, che il Papa baderà bene a non
lasciarsi, finchè può, sfuggire di mano. L'Impero alla sua volta, o è potente e
domina Papa e Comune, o è debole, vacante, assente o conteso fra molti, ed ecco
nobiltà e popolo romano arrogarsene i diritti; pretensione eterna, che
esercitata dal popolo o dai nobili si personifica in Alberico, in Brancaleone,
in Crescenzio, in Arnaldo, in Cola di Rienzo, gli eroi episodici del Comune di
Roma, sviato sempre dal fissarsi in una forma qualsiasi da quelli che il Giusti
chiamò i grilli romani, cessati
soltanto allorchè Martino V, fondatore definitivo del regno temporale dei Papi
nel secolo XV, ebbe annientato in Roma ogni vestigio di libertà comunale. Ma
chi bada alla storia del Comune di Roma? Sopraffatti dal gran nome di Roma, gli
storici stessi, col pensiero fisso nel destino mondiale dell'eterna città,
badano al Papato, all'Impero, poco o nulla al Comune, che penosamente si dibatte
fra le strette mortali dei due colossi, opponendo all'uno e all'altro i suoi
ricordi classici colla pretensione poco giustificata nel fatto che Roma non
solo sia il centro della Chiesa e dell'Impero, ma non debba in realtà
sottostare nè all'una nè all'altro e sia anzi la fonte e l'origine dei diritti
di entrambi[27].
Nel riandare di
volo gli argomenti, dei quali vi fu parlato, ho alterato un po' l'ordine del
programma, ma aggruppare del tutto i ricordi di questa agitata vita comunale e
distogliersene del tutto per guardare ad un paesaggio alpino e vederci sorgere
la potenza e la gloria di Casa Savoia è come riposar l'occhio e il pensiero,
quantunque anche là lo studio delle origini si perda nelle nebbie della
leggenda. Di fatto quell'Umberto, detto nelle cronache dalle bianche mani e che si ha pel capo
stipite di Casa Savoia, chi è desso? donde è venuto? è straniero, italiano,
gallo-romano o latino? Nacque di sangue regio o no? A che giova, si dirà,
affannarsi dietro tali ricerche? Ma appunto quando il destino d'una dinastia o
d'un popolo poggia molto in alto sorgono il desiderio e il bisogno di
magnificarne le origini sempre più. Se il documento manca, la tradizione
soccorre, la tradizione, che è leggenda ancor essa, appunto come la leggenda
degli Eneadi progenitori si ricongiunge alle origini del popolo Romano, quando
questo è già grande, e già distende la sua potenza nel mondo. Ognuno allora raccoglie
ed elabora di suo i frammenti raccolti, cosicchè anche per Umberto Biancamano
sono numerosi i sistemi tentati per ispiegare la sua figura mezzo storica e
mezzo leggendaria. Ma sull'uno o l'altro di tali sistemi non occorre ormai
affaticarsi di più. I nostri principi non pretendono alla corona dei Cesari
Tedeschi, nè ad un nono elettorato dell'Impero. La corona di ferro l'hanno
cinta perchè se la sono meritata; di Umberto Biancamano, sfumate ormai le
faticose industrie degli storici cortigiani e le ingenue combinazioni degli
eruditi fantastici, si sa oggi di più e nel tempo stesso si sa di meno, ma si
sa di certo che Casa di Savoia è sorta, cresciuta e s'è illustrata per la sua
propria virtù[28].
Con tuttociò scarsa è l'azione italiana di Casa Savoia e del Piemonte durante
l'età dei Comuni. Questo moto comunale si propagò anche in Piemonte, perchè era
l'espressione delle condizioni sociali di tutta Italia, ma Casa di Savoia, in
cui perdurano più a lungo e più salde che altrove le forme feudali, gli si
contrappone, mentre poi la sua, come oggi si direbbe, missione italiana è
ritardata dallo scindersi la sua potenza tra i due rami di Savoia e d'Acaia, i
quali non si ricongiungono che al 1418. Casa di Savoia rimane fida in sostanza
all'idea ghibellina, ma l'augurio di sua futura fortuna è appunto in quella
vita strettamente feudale, che le mantiene lo spirito militare e cavalleresco
anche quando altrove è illanguidito, ond'è che nella seconda metà del secolo
XIV vedesi di nuovo nel Conte Verde la baldanza spensierata e lo spirito
avventuroso dei primi Crociati, e n'ha, per così dire, in premio la prima vera
ingerenza italiana di Casa Savoia nella pace di Torino del 1381, con cui ha
fine la cosidetta guerra di Chioggia tra Genova e Venezia. Ma verranno i giorni
di vera gloria italiana per questi guerrieri chiusi ora nei loro castelli di
Savoia, come le aquile nei nidi delle Alpi, mentre tutt'altro destino è
riserbato a quell'altra monarchia che per opera d'avventurieri stranieri sorge
all'altro estremo d'Italia, quasi contemporanea a quando la luce della storia
comincia a diradare le nebbie della leggenda in cui sono ravvolte le origini di
Casa Savoia.
Dura ancora in
parecchi libri di storia l'usanza d'arrecare la fondazione del gran regno
dell'Italia meridionale ai quaranta pellegrini Normanni, reduci da Terra Santa,
che capitati a caso a Salerno verso il 1016, e sdegnati d'un sopruso che i
Saraceni voleano far patire a quel principe longobardo Guaimaro, gittano a un
tratto sarrocchino, cappellaccio e bordone, brandiscono le loro spade,
vendicano Guaimaro e se ne vanno senza voler accettare alcuna ricompensa. Ma
poi narrate ai loro compatriotti le meraviglie e le ricchezze dei paesi veduti
gli invogliano di conquistarli o, come altri pretendono, è lo stesso Guimaro
che li richiama. La critica moderna, se non nega addirittura quel fatto, lo
anticipa però di parecchi anni non solo, ma mostra che non ha alcuna
correlazione colla vera conquista Normanna. I Normanni compariscono bensì
nell'Italia meridionale tra il 1016 e il 1017, ma come ausiliari di Pugliesi
insorti contro la signoria Bizantina, i quali Pugliesi sono favoriti così dal
Papa (speditore dei Normanni da Roma) come dal principe longobardo di Salerno.
E domata dai Bizantini l'insurrezione Pugliese, prostrate a Canne le forze dei
due capi degli insorti, Melo e Datto, i Normanni si disperdono come mercenari
qua e là. Questo l'umile principio della loro fortuna, movendo dal quale, e
astuti, fedifraghi, quanto valorosi, in poco più di cent'anni sfolgorano i
rottami di tutte quelle vecchie istituzioni longobarde, greche, comunali che
ingombravano ancora il largo campo delle loro ambizioni e delle loro cupidigie
e fondano un regno durato bene o male, e in mezzo a tanta instabilità
d'italiane fortune, oltre a sette secoli, poichè fin d'allora comprese quasi
tutto il territorio che fu il regno delle due Sicilie fino al 1860[29].
Più del
riandare le straordinarie vicende della conquista normanna, più del ricordarvi
i nomi de' suoi eroi da Roberto il Guiscardo al primo ed al secondo Ruggero,
importerebbe al mio tema notare le conseguenze, che ebbe tale conquista nella
storia italiana e le relazioni che passarono tra il nuovo regno fondato dai
Normanni e le altre parti d'Italia.
Furono varie,
moltissime, nè potrei sperare neppure di accennare le più notevoli, senza
trapassare di troppo i limiti cronologici, che a queste conferenze furono per
ora segnati. Per farvi osservare quelle di ordine più generale diciamo intanto
che col nuovo regno meridionale tutta quell'immensa regione fu sottratta per
sempre a due delle forme politiche principali, che dalla fine del secolo X fino
quasi al XV dominano la storia italiana, alla sovranità cioè del ricostituito
Impero occidentale ed al regime comunale, mentre poi qualche vestigio di questo
durò colà più che altrove e vi prese anzi a lungo andare, più che l'antica
forma di partecipazione diretta al governo dei nostri Comuni medievali, quella,
direi, più moderna (benchè feudale di origine) di partecipazione
rappresentativa di alcuni ordini, di alcuni ceti almeno, se non di popolo
intiero.
Ma un'altra
correlazione e conseguenza importante, e più circoscritta ai tempi, dei quali
ci occupiamo, è quella, che accennai già parlando del Papato e del Comune di
Roma, vale a dire che avendo i Normanni ottenuta dal Papa l'investitura della
loro sovranità nel continente e nella Sicilia, la Chiesa potrà anch'essa
apparire così e per la prima volta quale suprema sovranità feudale, e ciò alla
vigilia della sua prima lotta contro l'Impero, e se ne varrà con un intuito
politico chiaro, fermo, sicuro, perseverante per contrabbilanciare tutte le
ambizioni dell'Impero, poi, quando i Papi avranno fatto passare la corona
Normanna dagli Svevi agli Angioini, per determinare il trionfo definitivo della
parte guelfa o papale in tutta l'Italia, trionfo tale che, dopo la battaglia di
Benevento del 1266, dir parte guelfa e dir Comune di Firenze sarà tutt'uno[30].
Così, o
signore, vi fu tracciato nelle sue linee maggiori tutto il gran quadro storico,
entro al quale all'uscire dalla notte della barbarie doveva ridestarsi la vita
italiana. - Ma essa è ancora ai primi passi. - È per questo che nel tempo, che
avete attraversato, la parte puramente storica ha dovuto di necessità prevalere
e vi si è più dovuto parlare di barbari e di feudatari, di Papato e d'Impero,
di vassalli maggiori e minori, di Borgognoni e Normanni, e di quelle prime,
quasi misterioso aggregazioni, entro alle quali si vien formando il Comune, di
quello che vive propriamente della vita, che ricomincia a essere vissuta fra
mezzo a tutte quelle istituzioni storiche del primo Medio Evo; vi si è dovuto
parlare insomma, se mi è permesso di esprimermi così, più del contenente che
del contenuto. Egli è, o signore, che, affinchè il popolo italiano ricominci a
vivere quella che giustamente fu chiamata la seconda sua storia, affinchè
Dagli atrii
muscosi, dai fôri cadenti,
Dai boschi,
dall'arse fucine stridenti,
Dai solchi
bagnati di servo sudor,
si ridesti
finalmente quella massa confusa di gente, che il poeta ha chiamato:
Un volgo
disperso, che nome non ha.
bisogna che un
moto profondo di totale disgregamento agiti tutta quella società, che gli pesa
sul capo, e lo preme, lo stringe, lo soffoca da ogni lato, poichè è appunto tra
quel disgregamento, che ripiglia anima, vita, libertà quel nuovo protagonista,
che non ha più nome, ma ne avrà in breve uno «nella storia d'Italia eternamente
memorando» il nome di popolo. Quella società, come avete veduto, o signore, non
cede il posto così di leggieri e senza lungo contrasto, non piega il capo
rassegnata, come nella tragedia manzoniana Ermengarda, la figlia dell'ultimo re
Longobardo, non d'altro rea che di discendere da quella progenie d'oppressori,
Cui fu prodezza
il numero,
Cui fu ragion
l'offesa
E dritto il
sangue e gloria
Il non aver
pietà;
non sente il
distacco dalle cose terrene e gli amari sconforti di Adelchi morente, che esorta
il padre a non rammaricarsi del regno perduto, dicendogli:
Gran segreto è
la vita e nol comprende
Che l'ora
estrema. Ti fu tolto un regno,
Deh nol
pianger: mel credi. Allor che a questa
Ora tu stesso
appresserai, giocondi
Si schiereranno
al tuo pensier dinanzi
Gli anni in cui
re non sarai stato, in cui
Nè una lagrima
pur notata in cielo
Fia contro a te
nè il nome tuo saravvi
Con l'imprecar
dei tribolati asceso,
Godi che re non
sei, godi che chiusa
All'oprar t'è
ogni via: loco a gentile,
Ad innocente
opra non v'è: non resta
Che far torto o
patirlo....
Oh no! Tuttociò
è buono e bellissimo in poesia! Ma nè Imperatore, nè Papa, nè feudalità laica o
ecclesiastica, nè nobili discendenti dai barbari hanno voglia di rassegnarsi
come Ermengarda o di rigettare, come Adelchi morente, quasi inutile ingombro e
vanità, la potenza. Hanno usurpato ed usurpano e contro tutti difendono le loro
usurpazioni, tanto più contro il Comune, il solo che non usurpa, ma rivendica.
Sta qui il segreto della vita dei secoli XI e XII, e questa vita rimarrebbe
davvero un segreto a chi trascurasse le premesse storiche, nelle quali le sue
origini sono contenute.
È una storia
lunga, faticosa, intricata; è un cammino aspro, buio, che ora sale a
generalità, che sono altezze vertiginose, ora si sprofonda in minuzie, che sono
frane, scoscendimenti e rottami; un cammino in cui s'inciampica negli spinai,
ci si urta a sporgenze imprevedibili, sicchè le vostre guide, in questa specie
di spirituale alpinismo, hanno spesso dovuto scusarsi di condurvi a traverso
tali labirinti e semioscurità crepuscolari, sempre col timore che vi stancaste
di troppo, e contentandosi di rischiararvi alla meglio la via, appunto
«....come quei
che va di notte
Che porta il
lume dietro a sè non giova,
Ma dopo sè fa
le persone dotte.»
E voi
resistete, o signore, impavide, coraggiose; ma deve avervi, io penso,
alleggerite le fatiche del viaggio, intravvedere, dopo tanto giro di storia, i
germi della vita nuova, che spuntano, sentire, origliando, «come un brulicare
di vita ancor timida e occulta, che poi (voi lo sapete) scoppierà, come dice il
Carducci, in lampi e tuoni di pensieri e di opere.» Ma per ora sono sintomi di
vita, pronostici, auguri; per ora non c'è nulla di definito, di determinato; è
tutta una vita in formazione, e quanto più la fioritura sarà splendida e ricca,
tanto più s'indugia sotterra. Per ora non si può penetrare molto innanzi; non
si può cogliere che poco o nulla di intimo, di veramente psicologico e
caratteristico, dove tutto è in travaglio di nascimento, a cominciare dalla
lingua. Però non è già più tutta storia morta soltanto.
È vita, o
almeno principio necessario di vita, e forse la prima manifestazione di essa
nel nostro Medio Evo, quel rinascere della scienza del diritto, regolatrice
della giustizia fra gli uomini, che, perdurata nelle scuole di Roma imperiale e
di Ravenna bizantina, resiste in faccia ai Goti, penetra da Pavia longobarda la
legislazione dei barbari, si scioglie in Bologna dalle anguste strettoie di
prima, dall'esser confusa cioè colle altre arti, che formano l'enciclopedia
medievale del trivio e del quadrivio, e fonda in Bologna una
istituzione mondiale.
È vita quel
lento formarsi dell'umile volgare latino, che sarà poi la lingua italiana, il
cui svolgimento (sbattuta giù ormai una gran frasconaia d'ipotesi vane)
apparisce alla critica moderna più come un capitolo di storia naturale che di
storia letteraria, tanto son vari gli inseguimenti e delicati gli intrecci di
quei germogli delle lingue romanze, che si distaccano dal gran tronco latino;
tanto ne aduggia il crescere l'ombra lunga e larghissima, che quel tronco getta
intorno a sè; tanto è difficile vincerla e superarla; tante sono le circostanze
esteriori, che là affrettano, qua ritardano il mutarsi del germoglio in arbusto
e dell'arbusto in albero ricco di fronde e di fiori; mutamento ritardato più
che altrove in Italia, dove la lingua ascende tardi ad ufficio veramente
letterario, ma dove per compenso s'imbattè in chi, appena s'è mostrata, la
ghermisce con mano onnipotente e subito la ferma e la determina per sempre.
È vita, e di
quella che più tocca da presso l'anima e il destino dell'uomo, quella fede
religiosa, che non è vero incomba torpida, uniforme, stagnante sul Medio Evo
italiano, ma che appunto perchè è robusta, sincera, fervente, non agghiacciata
dal soffio di precoci indifferenze e scetticismi, s'agita anzi terribilmente,
fra le pretensioni e le lotte gigantesche della potestà suprema, che la
rappresenta e la regge, e le scandalose mondanità, le violenze della feudalità
ecclesiastica, ed esagera gli ascetismi, talvolta sino alla follia, ora come
perfezionamento della dottrina più schietta, ora come contrapposto alle
rilassatezze della disciplina, sicchè da una fonte comune si veggono scaturire
le democrazie dei nuovi ordini religiosi e le eresie, quelle avute in sospetto
dalla Chiesa stessa, in cui difesa son sorte, queste sterminate ovunque si
mostrano, ma le une e le altre composte d'uomini, che
Maledicenti a
l'opre de la vita
e de
l'amore.... deliraro atroci
congiungimenti
di dolor con Dio
su rupi e
grotte:
discesero ebbri
di dissolvimento
a le cittadi, e
in ridde paurose
al Crocefisso
supplicarono, empi,
d'esser
abbietti[31];
abbiettamenti,
eccessi, deliri, che non impediranno però le grandi ispirazioni, che solo un
pensiero operoso e un sentimento profondo e sincero possano dare.
È vita quella
stessa povera letteratura italiana, il cui sorgere, dovendo per forza camminar
parallelo al formarsi della lingua volgare, procede barcollante da prima in una
debolezza, che non si sa se è d'infanzia o di vecchiaia, nè forse riescirebbe a
spogliarsi dell'involucro latino, se non venissero a darle mano le due
letterature della Francia settentrionale e meridionale, l'una che attinge dal
meraviglioso delle leggende Carolingie, l'altra che in faccia alle
mortificazioni dell'ascetismo medievale ricanta la gioia, la vita, l'amore; le
dolci note, che riecheggieranno nelle corti aleramiche del Monferrato, fra la
varia cultura e lo scetticismo scientifico della corte di Sicilia, nelle scuole
di Bologna e finalmente in Toscana e in Firenze, dove in un attimo, si può
dire, la letteratura italiana sorge gigante e s'incorona d'una gloria
immortale.
È vita quella
stessa filosofia scolastica, che ha nient'altro che in Dante il suo poeta, e
che, fra la scarsa, misera e fantastica vita scientifica del Medio Evo,
rappresenta un tentativo gigantesco di accordo fra la filosofia e il domma, fra
la ragione e la fede; tentativo, che raggiunge il suo punto culminante in San
Tommaso d'Aquino, tipo sublime dell'ingegno italiano, organico e temperante,
dopo del quale ricomincia la scissura fra scotisti e nominalisti da un lato,
tomisti dall'altro, e procede fino allo sciogliersi della scolastica nella
critica razionalistica del Rinascimento.
È vita
finalmente (e che vita!) il sorgere dell'arte nuova, che dopo la scura
tregenda, le cupe immagini bizantine, i deliri architetturali del più fitto
Medio Evo, dopo aver svincolate le sue forme diverse dall'anonima schiavitù,
che le confonde tutte nell'architettura del tempio gotico, si afferma risoluta,
franca, individuale, abbenchè tardiva ancor essa al pari della letteratura,
perchè l'una e l'altra, sono nella civiltà un effetto, un prodotto, che non si
determina senza cagioni proporzionate.
Ora come
dall'anonima congerie delle corporazioni medievali questi primi albori di
rinascimento, ai quali per quest'anno gli studi di queste conferenze si sono
fermati, incominciano a sceverare e a svolgere il concetto dell'unità dello
Stato, come dall'asfissia teologica incominciano a liberare le scienze morali,
delle quali il pensiero laico s'impossessa con Dante, così sciolgono anche le
arti da quell'aggruppamento forzato, così ciascuna ripiglia la propria
individualità, affermantesi in Niccola Pisano, che tenta il primo
riallacciamento del vecchio ideale greco-latino col nuovo ideale cristiano; in
Giotto, l'artista divino, che, al pari di Dante Alighieri, intuisce quasi
perfetto tutto l'ideale del Rinascimento.
Siamo sulla
soglia, o signore, di questo grande avvenimento mondiale, che in Italia non ha
bisogno d'aspettare che i Turchi, pigliando Costantinopoli, sperperino la
coltura bizantina e ce la mandino esule e pellegrina a rifarci il sangue, o che
Colombo slarghi il mondo e l'anima dell'uomo colla scoperta dell'America. No;
un paese, che costituisce i Comuni, che in poco d'ora ha Dante, Giotto, la
Divina Commedia e Santa Maria del Fiore non aspetta nulla da nessuno.
Appena la
libertà, il pensiero, l'arte, la poesia ridanno pregio alla vita; appena collo
scomporsi della società feudale si dirada quel buio mortificante del vero Medio
Evo, che è rappresentato dalla poetica leggenda del finimondo, a cui avete
sentito accennare più volte, l'Italia senza aspettar nulla da nessuno si alza
dal sepolcro, come il Lazzaro quatriduano, e sorge, e cammina.
Oh non è un
vanto cotesto, o se lo è, vi si mescolano a raumiliarci troppi presentimenti
dolorosi. Oh non dubitate! Pagheremo cara questa precocità; pagheremo caro
questo privilegio di gloria!
Ma non
anticipiamo su nulla.
Se, come sento,
il programma dell'anno venturo dovrà riprendere e compiere intiero lo studio
dei secoli XIII e XIV, vi sarà ancora un grande, un immenso quadro storico da
disegnare, ma su questo fondo prospettico le individualità si staccheranno
sempre più vigorose e più vive e verrà quindi da sè la necessità di far meno
storia e più vita.
E poichè questa
vita, benchè torbida, agitatissima, dovrà sempre più concentrarsi in questa
vostra cara e gloriosa Firenze, dove splende il gran triumvirato toscano, dove
Dante chiude il Medio Evo e inaugura la civiltà nuova col poema già moderno di
spirito e di lingua, il Petrarca col suo ideale d'antica coltura, il Boccaccio
col pieno, libero e giocondo sentimento della vita reale, per cui la commedia
umana si contrappone alla commedia divina, così vi sarà caro e gradevole sempre
più conoscer bene tra che popolo vissero questi grandissimi, e riscontrare la
storia coi monumenti non solo, ma entrare nella penombra solenne di quelle
chiese, dove i vostri avi pregarono, nei banchi, nei fondachi, dove i mercanti
accumulavano tesori, nelle officine, dove accanto agli arnesi del mestiere
l'artigiano teneva le sue armi per essere pronto ad accorrere sotto il
gonfalone dell'arte sua al primo tocco di campana; vi sarà caro e gradevole
sempre più penetrare in quelle antiche dimore, in quei palazzi anneriti,
merlati, dove i vostri avi amarono, odiarono, combatterono, e scorrerne le
stanze, i cortili, le scale, tentando figurarvi qual viso, qual discorso, qual
costume avessero i loro antichi abitatori, appunto «come talvolta vedendo un
elmo antico tutto rugginoso ed alzandone la visiera, la fantasia (diceva
Massimo d'Azeglio) tenta dipingersi il maschio ed ardito volto, che dovette un
tempo riempierne il vano».
FINE.
INDICE.
Olindo Guerrini
Preludio
Pasquale
Villari Le origini del comune di
Firenze
Pompeo Molmenti
Venezia e le repubbliche marinare
Romualdo
Bonfadini Le origini del comune di
Milano
Romualdo
Bonfadini Le origini della monarchia in
Piemonte
Ruggero Bonghi Le origini della monarchia a Napoli
Arturo Graf Le origini del papato e del
comune di Roma
Felice Tocco Gli ordini religiosi e l'eresia
Pio Rajna Le origini della lingua
italiana
Adolfo Bartoli Le origini della letteratura
italiana
Francesco
Schupfer Le università e il diritto
Giacomo
Barzellotti La filosofia e la scienza
nel periodo delle origini
Enrico
Panzacchi Le origini dell'arte
nuova
Ernesto Masi Epilogo